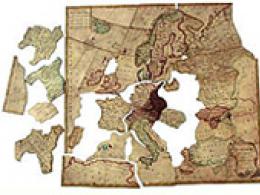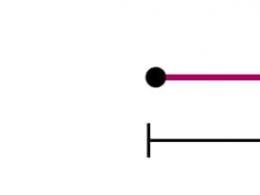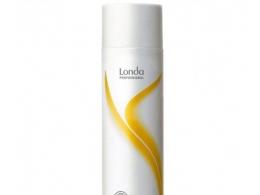Matrimonio e famiglia nell'antica Roma. Matrimonio e famiglia nell'antica Roma
Concetto di famiglia. L'evoluzione dei rapporti familiari
La definizione di famiglia (familia) fu data dal famoso avvocato romano Ulpiano (D. 50.16.195.1-2).
Ha sottolineato che il termine "ha significati diversi, poiché può riferirsi sia a cose che a persone".
Egli distingueva anche tra la famiglia in senso stretto o stretto (proprio iure) e la famiglia in senso ampio nel diritto comune (familia communi iure).
Ulpiano scrisse: "Nel senso stretto della parola, chiamiamo famiglia un insieme di persone sotto l'autorità di una persona, a lui subordinata per nascita o per diritto". “Per diritto comune (parentela) chiamiamo la famiglia di tutti gli agnati... subordinata all'autorità di una persona, poiché provengono dalla stessa casa e clan” * (13).
La comunità clanica (familia gentilicia) era l'unione di parentela più estesa. I membri della stessa gens (gens) avevano un antenato comune, portavano il nome comune di questo antenato, avevano un culto ancestrale comune, un altare.
La differenziazione della proprietà all'interno del clan con la formazione dello Stato contribuisce alla separazione delle unioni più piccole - le famiglie - dal clan.
Fondamentalmente, l'antica famiglia romana era strettamente patriarcale. Era costruito sui principi del potere assoluto del capofamiglia (paterfamilias) sulla moglie, sui figli a carico, sugli altri parenti, sugli schiavi, sui servi, nonché su tutte le proprietà.
All'inizio c'era uguale potere (manus) su tutti. Tuttavia, nel tempo, questo potere cominciò a essere suddiviso in:
dominica potestas: sulle cose, schiavi;
manus mariti: sulla moglie;
patria potestas: sui figli;
mancipium - sopra il legato.
Il potere del capofamiglia cessava solo con la sua morte o con la sua volontà. Dopo la morte del capofamiglia, lo stato familiare di tutti i subordinati è cambiato.
Solo il proprietario aveva piena capacità giuridica. Era una persona di diritto proprio (persona sui juris), tutti gli altri membri della famiglia erano persone a lui soggette - persone di diritto di qualcun altro (persona aliena juris).
Gradualmente, ma molto lentamente, il potere del capofamiglia sui suoi sudditi si indebolisce. La moglie e i figli ricevono il riconoscimento dei loro diritti, la posizione dei soggetti liberi migliora notevolmente rispetto alla posizione degli schiavi. Parentela
Il diritto romano conosceva due tipi di parentela: agnazia e cognazia.
La parentela agnatica corrisponde al carattere dell'antica famiglia romana, che si basava sulla subordinazione al potere di un sovrano: questa è parentela per potere (agnatio). Gli Agnati sono uniti dalla parentela civile (Gaio 3,10). La parentela agnata è nata attraverso la linea maschile. Guy scrive: “Gli agnati sono parenti, uniti da parentela attraverso i maschi:” * (14) (Gai, 1.156). Inoltre: “Ma coloro che sono legati dal sangue tramite femmine non sono agnati...”*(15). Una figlia che si sposava con un membro di un'altra famiglia diventava legalmente estranea alla sua famiglia precedente, poiché, cadendo sotto l'autorità del nuovo capofamiglia, diventava parente agnatica della nuova famiglia. Allo stesso tempo, la persona adottata diventa parente agnatico della famiglia del genitore adottivo. Solo questo tipo di parentela era riconosciuto dal diritto civile.
Parentela di sangue (cognatio): inizialmente la parentela cognatica non veniva affatto presa in considerazione.
Riceve significato giuridico solo nella legge del pretore. Con l'indebolimento delle basi patriarcali della famiglia, la parentela cognaziana divenne sempre più importante. Nella legge di Giustiniano sostituì completamente la legge agnatica.
I romani determinavano la parentela per linee e gradi.
Le persone che discendono l'una dall'altra (padre e figlia) sono chiamate parenti diretti.
Nella linea ascendente: questi sono parenti dal discendente all'antenato (padre, nonno, bisnonno); in linea discendente: questi sono parenti dall'antenato al discendente (bisnonno, nonno, padre).
Le persone che discendono da un antenato comune (zio e nipote, fratello e sorella) sono detti parenti collaterali.
La parentela laterale potrebbe essere di sangue se sia la madre che il padre sono comuni; e mezzosangue: se c'era una madre comune, allora si chiamava mezzosangue; se il padre è comune, mezzosangue.
Il grado di parentela era determinato dal numero di nascite che separavano i parenti gli uni dagli altri. Madre e figlio sono parenti di 1° grado, nonno e nipote sono parenti di 2° grado.
Anche la proprietà e l'atteggiamento di un coniuge nei confronti degli affini dell'altro (suocero, suocera, genero) differivano. Rapporti personali e patrimoniali dei coniugi. Cosa fare, donazioni
Sono stati costruiti in modo diverso nei diversi tipi di matrimonio.
Nel matrimonio cum manu, in cui la moglie era completamente sotto l'autorità del marito, era completamente impotente sul piano personale, i diritti del marito erano illimitati. Il marito poteva reclamare la moglie che abbandonava la casa, anche contro la sua volontà; vendere come schiavo; punire; prendi la vita. Questo diritto era limitato solo dall'opinione dei parenti. Il diritto di vendita, salvo alcune eccezioni, cessò di essere esercitato nell'antichità. Non c'erano restrizioni legali al potere.
Nel matrimonio sine manu, dal punto di vista personale, la moglie non è più in una posizione così subordinata, sebbene l'autorità in questa unione appartenga anche al marito.
Essendo libera e indipendente, la moglie riceveva il nome e la posizione sociale del marito e ne seguiva il luogo di residenza.
Il marito aveva il diritto di reclamare la moglie solo contro coloro che la trattenevano con la forza.
Il marito era il protettore naturale della moglie. Se una moglie veniva insultata, si considerava che l'insulto fosse stato inflitto al marito, e questi poteva fare causa in difesa.
I coniugi dovevano rispettarsi a vicenda. Sulla base di ciò, non potevano avanzare reciproche pretese punitive e disonorevoli, o testimoniare l'uno contro l'altro.
La natura dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dipendeva anche dal tipo di matrimonio.
Nel matrimonio cum manu la moglie non aveva alcun diritto di proprietà. Tutti i suoi beni prematrimoniali e quelli acquisiti dopo il matrimonio diventavano proprietà di suo marito. È stata completamente privata della capacità giuridica in questo settore. Anche se il matrimonio finiva, la dote della moglie non era soggetta a restituzione. Il suo unico diritto era quello di eredità in caso di morte del marito.
Nel matrimonio sine manu i beni della moglie e quelli del marito non sono uniti, ma esistono separatamente. Tutti i suoi beni prematrimoniali e quelli acquisiti durante il matrimonio sono di sua proprietà (a condizione che non sia a carico). La moglie ha piena capacità giuridica.
Tutti i beni possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: dote; beni non compresi nella dote; regali di matrimonio*(26).
Dote (dos). Secondo la definizione dei giuristi romani, si tratta di una concessione patrimoniale che viene fatta al marito dalla moglie o da altra persona per suo conto, affinché aiuti il marito a sopportare i pesi della vita coniugale. Da questa definizione risulta chiaro che si tratta di un tipo speciale di beni appositamente destinati al matrimonio. Lo scopo della dote è aiutare a sostenere gli oneri del matrimonio. La dote veniva stabilita con apposito atto.
Nell'antico periodo repubblicano la dote della moglie diventava completamente di proprietà del marito e non era soggetta a restituzione.
Verso la fine del periodo repubblicano, a causa della crescente frequenza dei divorzi, nacque la pratica di concludere un matrimonio e stabilire una dote di stipulare un accordo orale, secondo il quale il marito si impegnava a restituire la dote in caso di divorzio. . Ritornava anche in caso di morte del marito. Questa disposizione era sancita dalla legge pretoria.
Nel periodo classico, il regime giuridico del dos è regolato come segue.
Dos veniva restituito alla moglie o a lei e suo padre se:
il matrimonio finì con la morte del marito;
il matrimonio è stato sciolto con divorzio su iniziativa del marito o per sua colpa.
Dos è rimasto per il marito se:
il matrimonio veniva sciolto per la morte della moglie, o ritornato al padre, che stabiliva le cose;
il matrimonio è stato sciolto con divorzio su iniziativa della moglie o per sua colpa.
Il marito era infatti il proprietario del dos, lo gestiva e lo cedeva. Tuttavia, per tutelare gli interessi patrimoniali della moglie, fu introdotto il divieto di alienazione da parte del marito dei possedimenti terrieri in Italia e degli schiavi inseriti nella dote senza il consenso della moglie.
In alcuni casi, al momento della restituzione della dote, il marito aveva il diritto di trarne delle trattenute per il mantenimento dei figli, le spese necessarie, i regali, per cattiva condotta, per cose rubate.
Nella legge di Giustiniano, l'unico caso di abbandono del marito come pena era il divorzio per iniziativa della moglie o per sua colpa. Giustiniano proibiva l'alienazione da parte del marito dell'intero patrimonio immobiliare anche con il consenso della moglie. Le regole per la restituzione della dote furono semplificate: non importava più se fosse stato concluso o meno un accordo per la sua restituzione, la moglie e i suoi eredi ricevevano un reclamo dall'accordo per la restituzione della dote.
Beni accessori - non inclusi nella dote.
Ulpiano la definisce come «quelle cose che la moglie ha abitualmente a disposizione nella casa del marito e che non includeva nella dote» (D. 23.3.9.3)* (27). Queste cose includono articoli per la casa e utensili.
Un altro tipo di beni accessori erano i beni personali della moglie persona sui iuris, che ella possedeva prima del matrimonio e ciò che aveva ricevuto durante il matrimonio (beni immobili, prestiti). Poteva usarla e disporne liberamente senza il consenso del marito. Tuttavia, potrebbe affidare la gestione di tutta questa proprietà a suo marito.
Doni di matrimonio (donatio)
Ai tempi dell'imperatore Costantino si diffuse a Roma l'usanza del marito di donare alla futura moglie parte dei suoi beni. All'inizio questo dono veniva fatto prima del matrimonio, poiché i doni tra i coniugi non erano consentiti dalla legge. La legislazione di Giustiniano consentiva doni da parte del marito alla moglie anche dopo il matrimonio, ma i beni donati continuavano a rimanere di proprietà del marito. Ma in caso di divorzio per colpa del marito, questa proprietà, insieme alle cose da fare, diventava proprietà della moglie. Il costo della donatio è stato pari al dos.
Oltre ai doni, i coniugi potrebbero stipulare tra loro qualsiasi negozio giuridico. Erano responsabili l'uno verso l'altro della colpa e della consueta attenzione che un dato coniuge presta ai propri affari. Quando sorgeva una controversia sulla proprietà dei beni, veniva applicata la presunzione di Mutius, secondo la quale ogni cosa si considera appartenente al marito finché la moglie non ne dimostra la proprietà.
Autorità paterna (patria potestas). Rapporti personali e patrimoniali tra padre e figli
Le Istituzioni di Gaio indicano che quasi nessun altro popolo ha un tale potere sui bambini come i romani. Egli annota ciò come “la peculiarità (proprietà esclusiva) dei cittadini romani” (Caio, 1,55) * (28).
Nell'antichità questo potere sui bambini era assoluto, illimitato. I bambini vi erano soggetti indipendentemente dalla loro età, posizione sociale e tipo di matrimonio dei genitori. Il diritto assoluto della potestà paterna si estendeva sia alla personalità dei figli che ai beni da loro acquisiti.
In termini personali, il paterfamilias aveva diritto di vita e di morte, limitato solo dal parere dei suoi parenti; il diritto di buttare via un neonato, limitato dal consenso dei vicini più prossimi; il diritto di vendita in schiavitù su territorio straniero, il diritto di mancipazione (servitù) all'interno dello Stato.
In termini patrimoniali, essendo subordinati, i figli, pur avendo capacità giuridica civile (avevano ius commcrcii e ius conubii), tutto ciò che acquisivano in base ai loro diritti diventava proprietà del padre. Avevano capacità giuridica non per se stessi, ma per il padre. Inoltre, il padre non era responsabile degli obblighi derivanti dalle transazioni dei figli subordinati, rispondendo solo degli illeciti dei figli. Tuttavia, in seguito il pretore cominciò a concedere pretese nei confronti del paterfamilias per le transazioni dei suoi sudditi. La responsabilità cominciò ad essere attribuita ai soggetti stessi quando essi divennero persona sui iuris.
A poco a poco, la natura assoluta del potere si indebolisce: nel campo delle relazioni personali, i diritti del paterfamilias sono limitati, e nel campo della proprietà, i figli a carico diventano più indipendenti grazie al riconoscimento di una certa capacità e capacità giuridica per loro. La posizione dei bambini sudditi è cambiata dalla fine della repubblica. Prima è stato vietato il diritto di buttare via i neonati, poi il diritto di vendere i bambini (ci sono casi di estrema necessità e solo neonati). Secondo le Leggi delle XII Tavole, il diritto di vendere i figli in schiavitù era limitato a tre volte la vendita, dopodiché i figli venivano liberati dall'autorità paterna.
L'uccisione di bambini cominciò a essere fortemente limitata, cominciò a punirla e l'imperatore Costantino escluse questo diritto. L'imperatore Traiano emette un decreto secondo il quale, se il padre abusa dei suoi diritti, il figlio può essere liberato dall'autorità paterna.
Nel corso del tempo, l'indipendenza patrimoniale dei figli si espande. Per le attività economiche, i padri iniziarono ad assegnare proprietà ai figli: peculium, il cui proprietario rimase il paterfamilias.
A poco a poco la proprietà cominciò ad essere assegnata ai figli. La proprietà acquisita dal figlio durante il servizio militare o in relazione al servizio militare (bottino militare, stipendio, doni) divenne nota come peculio militare. Il figlio poteva liberamente utilizzarlo e disporne, anche lasciandolo in eredità. Se il figlio non lo lasciava in eredità, in caso di morte del figlio il peculio militare veniva ereditato dal padre.
Durante il periodo imperiale, le norme sul peculio militare cominciarono ad applicarsi a tutti i beni ricevuti in servizio pubblico o religioso, dalle attività legali come avvocato e al cosiddetto peculio quasi militare.
Successivamente, i beni ereditati dalla madre iniziarono a diventare proprietà dei figli, di cui il padre non poteva disporre, ma aveva solo il diritto di utilizzarli per tutta la vita.
Secondo il diritto di Giustiniano, il padre possedeva solo la proprietà che il figlio aveva acquisito utilizzando la proprietà del padre. Tutti gli altri beni erano di proprietà del figlio, sul quale il padre aveva solo il diritto di uso permanente (sebbene potesse essere privato anche di questo). Istituzione e cessazione della patria potestas
La patria potestas si acquisiva in tre modi: nascita in matrimonio legale, adozione e legittimazione.
Dai detti di Ulpiano risulta chiaro che un figlio si considerava nato da un marito legalmente sposato con la madre del bambino se la nascita avveniva almeno 6 mesi dopo il matrimonio o entro 10 mesi dalla morte del marito o dal divorzio (D.38.16 .3.11- 12)*(29). Altrimenti il figlio veniva considerato illegittimo e seguiva lo status giuridico della madre.
Ma se il padre stesso era sotto patria potestas, allora il bambino passava sotto l'autorità del suo capofamiglia (padre) e solo in caso di morte - sotto l'autorità di suo padre.
L'atto di adozione veniva compiuto in due modi: o per potere del popolo, oppure per ordine di un dignitario superiore, ad esempio un pretore (Gai, 1,98) * (30). Pertanto il primo metodo venne chiamato adrogatio, il secondo adottatio.
I figli degli altri erano oggetto di adozione. Il potere popolare poteva adottare soltanto coloro che godevano di indipendenza giuridica, cioè coloro che godevano di indipendenza giuridica. persona sui iuris. Ciò veniva fatto nelle assemblee popolari delle curie sotto la presidenza del grande pontefice, e poi davanti a 30 littori (secondo il numero delle curie) sotto forma di una legge speciale. In considerazione di ciò, sia i genitori adottivi che gli adottati dovevano avere il diritto di partecipare alle assemblee pubbliche, quindi era impossibile adottare donne e minori. Le donne non potevano adottare anche perché, come sottolinea Guy: “…non hanno nemmeno i propri figli in loro potere” (Gai, 1.104) * (31).
La persona adottata ha acquisito il cognome e il cognome della nuova famiglia ed è diventata partecipe del culto familiare del genitore adottivo. Divenne membro della nuova famiglia, uguale ai suoi propri figli, e ricevette il diritto di eredità. Anche i figli dell'adottato rientravano sotto l'autorità dell'adottante in quanto nipoti.
L'intero patrimonio dell'adottato è passato all'adottante.
Nel diritto postclassico l'arrogazione veniva effettuata in forma semplificata: attraverso un rescritto dell'imperatore o una dichiarazione ufficiale davanti al pretore di Roma o al governatore della provincia. L'adozione di donne e minori è diventata possibile.
Un altro metodo di adozione si chiamava adoptio ed è stato istituito per l'adozione di persone di diritto altrui: persona alieni iuris. Questa procedura si svolgeva davanti al pretore sotto forma di transazione privata.
A differenza dell'adrogatio, qui non era necessario il consenso dell'adottato, poiché la transazione veniva conclusa tra due patres.
La procedura dell'adozione è descritta dettagliatamente da Guy: “Per un figlio occorrono tre mancipazioni e due manomissioni...” (Gai, 1.134) * (32).
Dopo la terza mancipazione, «il genitore adottivo lo vendica (reclama) dal padre davanti al pretore, sostenendo che il figlio è suo, e quando il padre tace (non lo pretende), allora il pretore assegna la figlio a colui che ha presentato il suo diritto in modo rivendicativo...” (Caio, 1,134). Per le altre persone, indipendentemente dal sesso, era sufficiente una vendita immaginaria.
Nel diritto post-classico le forme di adozione sono semplificate e si attuano mediante un accordo tra il padre naturale e l'adottivo o una domanda del padre alla presenza del governatore della provincia. Il diritto all'adozione è riservato alle donne e la differenza di età tra l'adottante e l'adottato è stabilita in almeno 18 anni. Giustiniano introdusse due forme di adozione: piena e incompleta. L'adozione piena veniva effettuata da parenti ascendenti che non avevano discendenti subordinati con tutte le conseguenze dell'adozione. L'operazione incompleta è stata eseguita da un estraneo. Allo stesso tempo, è stata preservata la patria potestas del padre consanguineo, la persona adottata ha mantenuto il diritto di eredità nella propria famiglia, ed ha ereditato anche dopo il genitore adottivo.
I figli illegittimi durante il periodo della monarchia assoluta potevano essere legittimati, a seguito della quale su di loro veniva stabilita l'autorità paterna. Questa è la cosiddetta legittimitio. Solo i loro figli nati liberi erano soggetti a legittimazione. Dopo la legittimazione, i bambini ricevevano tutti i diritti di nascita legale.
Esistono tre metodi conosciuti di legalizzazione:
a) fin dai tempi di Teodosio e Valentiniano - iscrivendo un figlio a membro del senato municipale (curia), una figlia - sposando un membro del senato municipale (curia);
b) dai tempi dell'imperatore Anastasio - il successivo ingresso dei genitori nel matrimonio legale;
c) fin dai tempi di Giustiniano - attraverso un rescritto imperiale.
Cessazione della patria potestas. Emancipazione
Naturalmente la patria potestas cessava con la morte del padre.
La perdita o la menomazione della capacità giuridica del padre comportava anche la cessazione della patria potestas.
Tuttavia, in caso di perdita della libertà del paterfamilias a seguito della prigionia militare, «il potere sui figli è sospeso» fino al ritorno dalla prigionia (Gai, 1.129) * (33).
La perdita della cittadinanza romana sia da parte del paterfamilias che del suddito comportava la cessazione della patria potestas.
Con l'arroganza i padri adottivi perdevano l'autorità paterna sui figli.
I figli uscivano dall'autorità paterna se i figli diventavano flameni di Giove e le figlie si dedicavano alle Vestali; durante il tardo impero, i figli occupavano le più alte cariche statali e ecclesiastiche.
Il padre poteva anche porre fine volontariamente alla sua autorità sui figli attraverso l'emancipazione. Ciò è stato ottenuto vendendo il figlio tre volte, come sancito dalle Leggi delle XII Tavole. Dopo le prime due vendite, il fiduciario al quale fu venduto il figlio fece una manomissione per rivendicazione, e il figlio ricadeva nuovamente sotto l'autorità del padre. Dopo la terza vendita, il figlio fu completamente liberato dal potere. Per altri bastava una vendita. Ereditando per parentela agnatica, la persona emancipata perdeva il diritto all'eredità.
Nel diritto postclassico l'emancipazione si effettua sotto forma di semplice dichiarazione davanti al magistrato e in assenza delle parti - mediante rescritto.
La famiglia era la base dell'intero sistema romano antico. L’appartenenza ad una famiglia o ad un clan determinava in definitiva la capacità giuridica civile di una persona.
Essendo emersa come una famiglia strettamente patriarcale, è stata costruita sui principi del potere illimitato del capofamiglia su tutti i membri della famiglia. Con la crescente importanza della parentela di sangue e la necessità di indipendenza economica dei subordinati, il potere del paterfamilias si indebolisce. Creando un matrimonio sine manu, la moglie veniva liberata dal potere del marito, sia personale che patrimoniale. Questa era una caratteristica distintiva del diritto romano. 14.
Altro sul tema della famiglia romana:
Ritratto degli sposi. Prima metà del I secolo, affresco proveniente da Pompei
La maggior parte dei matrimoni nelle famiglie benestanti dell'antica Roma erano di convenienza: per continuare la linea familiare, per unire i possedimenti e anche per rafforzare le alleanze politiche. Tra la popolazione povera spesso prevaleva anche il calcolo, ma i matrimoni d'amore non erano esclusi.
DIRITTI DEL PADRE
Il capofamiglia, il padre, aveva un potere illimitato nella famiglia, e il suo potere nella famiglia era formalizzato dalla legge. La famiglia comprendeva non solo la madre e il padre, ma anche le figlie non sposate, i figli, le loro mogli e i figli, mentre il nome della famiglia comprendeva gli schiavi e tutti i beni domestici.
L'autorità del padre si estendeva a tutti i membri della famiglia.
Il padre prendeva da solo quasi tutte le decisioni riguardanti i membri della famiglia.
Alla nascita di un bambino determinava il destino del neonato; o riconobbe il bambino, o ordinò che fosse ucciso, o lo abbandonò senza alcun aiuto.
Dall'inizio dell'antica Roma fino alla caduta dell'impero, il capofamiglia aveva il diritto di eseguire punizioni corporali, che talvolta terminavano con la morte dell'autore del reato. Potrebbe cacciare in strada i bambini indesiderati, accusandoli, ad esempio, di essere deformi. La moglie non aveva diritto di voto e non poteva impugnare le decisioni del marito di fronte alla legge.
Il padre era il solo a possedere tutti i beni di famiglia. Anche dopo aver raggiunto l'età adulta e essersi sposato, il figlio è rimasto senza diritti sul cognome. Non aveva il diritto di possedere alcuna proprietà immobiliare durante la vita di suo padre. Solo dopo la morte del padre, in virtù di un testamento, ricevette i suoi beni per via ereditaria. Il dominio illimitato del padre esisteva in tutto l'Impero Romano, così come il diritto di controllare il destino dei propri cari. Nel tardo periodo dell'Impero Romano, i padri furono liberati dai figli non desiderati a causa delle difficoltà economiche e del generale declino dei fondamenti morali della società.
DIRITTI DELLA DONNA
Nelle famiglie romane la donna aveva grandi diritti, poiché le venivano affidate le responsabilità della gestione della casa. Era l'amante sovrana della sua casa. Era considerata una buona forma quando una donna gestiva bene la vita familiare, liberando il tempo del marito per affari governativi più importanti. La dipendenza della donna dal marito era essenzialmente limitata ai rapporti di proprietà; Una donna non poteva possedere o disporre di beni senza il permesso del marito.
Una donna romana appariva liberamente nella società, andava in visita e partecipava a ricevimenti cerimoniali. Ma la politica non era una cosa da donne; non doveva partecipare alle riunioni pubbliche.
ADOZIONE
Se non c'erano figli da matrimoni legali, il romano ricorreva all'adozione in modo che il nome del clan e le sue proprietà non cadessero nell'oblio. Il sangue non ha avuto un ruolo determinante nemmeno nei rapporti familiari. Un bambino adottato diventava uguale a un figlio naturale. In questo senso Roma “adottò” i popoli conquistati, proprio come un singolo romano poteva adottare uno straniero e dotarlo dei diritti di erede.
I padri di famiglia, di regola, contraevano i matrimoni tra i loro figli, guidati dagli standard morali prevalenti e da considerazioni personali. Un padre poteva sposare una ragazza dall'età di 12 anni e un ragazzo dall'età di quattordici anni.
Il diritto romano prevedeva due forme di matrimonio:
Quando una donna passava dal potere di suo padre a quello di suo marito, cioè veniva accettata nella famiglia di suo marito.
Dopo il matrimonio, la donna è rimasta membro dell'antica famiglia, pur rivendicando l'eredità familiare... Questo caso non era il principale ed era più simile alla convivenza che al matrimonio, poiché la moglie poteva lasciare il marito quasi in qualsiasi momento e torna a casa.
FIDANZAMENTO
Indipendentemente dalla forma preferita dai giovani, il matrimonio era preceduto da un fidanzamento tra i giovani.
I ricchi preferivano un rito solenne con un sacrificio alla presenza di dieci testimoni. Era un matrimonio patrizio che era quasi scomparso all'inizio dell'impero. Più comune era il “acquisto” di una moglie, quando il futuro marito, alla presenza di cinque testimoni, consegnava il prezzo della sposa al suocero.
Fin dai tempi dell'impero ha trionfato una forma universale di cerimonia nuziale, preceduta dal fidanzamento nella casa del padre della sposa. Il giorno del matrimonio, è stato compiuto un sacrificio, sul quale gli sposi hanno pronunciato una formula toccante: "Dove sei, Kaya, eccomi, Kaya" e si sono presi per mano.
Lo sposo consegnò alla sua futura moglie una moneta, come simbolo dell'unione nuziale conclusa tra i genitori, e un anello di ferro, che la sposa indossava sull'anulare della mano sinistra.
MATRIMONI
Ai matrimoni, tutte le questioni relative all'organizzazione della celebrazione del matrimonio venivano trasferite al manager, una donna che godeva del rispetto generale. Il direttore condusse la sposa nel corridoio e la consegnò allo sposo. Il trasferimento era accompagnato da riti religiosi in cui la donna svolgeva il ruolo di sacerdotessa del focolare. Dopo la festa a casa dei genitori, la sposa è stata accompagnata a casa del marito... La sposa ha dovuto resistere teatralmente e piangere. E il gestore fermò l’ostinazione della ragazza, strappandola dalle braccia della madre e consegnandola al marito...
NASCITA DI BAMBINI
Le celebrazioni legate all'arrivo di un nuovo membro della famiglia iniziavano l'ottavo giorno dopo la nascita e duravano tre giorni. Il padre sollevò il bambino da terra e gli diede un nome, annunciando così la sua decisione di accoglierlo in famiglia. Successivamente, gli ospiti invitati regalavano al bambino dei regali, solitamente amuleti, il cui scopo era proteggere il bambino dagli spiriti maligni.
Per molto tempo non è stato necessario registrare un bambino. Solo quando un romano raggiungeva l'età adulta e indossava una toga bianca diventava cittadino dello stato romano. È stato presentato davanti ai funzionari e inserito nell'elenco dei cittadini.
La registrazione dei neonati fu introdotta per la prima volta all'alba della nuova era da Ottaviano Augusto, obbligando i cittadini a registrare un bambino entro 30 giorni dalla nascita. La registrazione dei bambini veniva effettuata nel Tempio di Saturno, dove si trovavano l'ufficio del governatore e l'archivio. Allo stesso tempo, sono stati confermati il nome e la data di nascita del bambino. Fu confermata la sua libera origine e il diritto di cittadinanza.
FORMAZIONE SCOLASTICA
Ragazzi e ragazze iniziarono ad imparare all'età di sette anni. I genitori ricchi preferivano l’istruzione domiciliare. I poveri utilizzavano i servizi delle scuole. Allo stesso tempo, è nato il prototipo dell'istruzione moderna: i bambini hanno attraversato tre fasi dell'istruzione: primaria, secondaria e superiore. I capifamiglia, preoccupati dell’educazione dei figli, cercavano di assumere insegnanti greci per i loro figli o di convincere uno schiavo greco a insegnargli.
La vanità dei genitori li ha costretti a mandare i propri figli in Grecia per l'istruzione superiore.
Nelle prime fasi dell'istruzione, ai bambini veniva insegnato principalmente a scrivere e contare e venivano fornite informazioni sulla storia, il diritto e le opere letterarie.
Nella Scuola Superiore la formazione si svolgeva in oratorio. Durante le lezioni pratiche, gli studenti hanno svolto esercizi che consistevano nel comporre discorsi su un determinato argomento tratto dalla storia, dalla mitologia, dalla letteratura o dalla vita sociale.
L'istruzione all'estero avvenne principalmente ad Atene, sull'isola di Rodi, dove si perfezionarono anche nell'oratorio e acquisirono la comprensione di varie scuole filosofiche.
All'età di 17-18 anni, il giovane dovette lasciare gli studi e sottoporsi al servizio militare.
I romani inoltre curavano che le donne ricevessero un'educazione in relazione al ruolo che avevano nella famiglia: organizzatrice della vita familiare ed educatrice dei figli in tenera età.
C'erano scuole in cui le ragazze studiavano insieme ai ragazzi. Ed era considerato onorevole se si dicesse di una ragazza che era una ragazza istruita. Lo stato romano iniziò ad addestrare gli schiavi già nel I secolo d.C., poiché schiavi e liberti cominciarono a svolgere un ruolo sempre più importante nell'economia dello stato. Gli schiavi divennero amministratori di proprietà e furono impegnati nel commercio e furono nominati sorveglianti su altri schiavi. Gli schiavi alfabetizzati erano attratti dalla burocrazia statale; molti schiavi erano insegnanti e persino architetti.
Uno schiavo alfabetizzato valeva più di uno analfabeta, poiché poteva essere utilizzato per lavori qualificati.
Ex schiavi, liberti, iniziarono gradualmente a formare uno strato significativo a Roma. Non avendo altro nell'animo se non la sete di potere e di profitto, cercarono di sostituirsi a un impiegato, un dirigente nell'apparato statale, e si dedicarono ad attività commerciali e all'usura. Il loro vantaggio sui romani cominciò ad apparire, che consisteva nel fatto che non rifuggivano da nessun lavoro, si consideravano svantaggiati e mostravano tenacia nella lotta per il loro posto al sole. Alla fine riuscirono a raggiungere l’uguaglianza giuridica e a cacciare i romani dal governo.
Http://maxpark.com/community/6782/content/2087316
Oltre alla famiglia, la profonda antichità romana conosceva un'altra famiglia. L'istituto della familia Romana costituì in epoca repubblicana e imperiale il principale organismo sociale, strettamente connesso allo sviluppo e all'istituzione della proprietà privata, e fu pertanto oggetto di grande attenzione da parte dei giuristi romani. Grazie alle loro testimonianze, gli scienziati moderni hanno a disposizione moltissimo materiale. Gli storici del diritto hanno descritto dettagliatamente la struttura e le funzioni del cognome romano.
Il primo degli specialisti in storia di Roma a restaurare il cognome romano come famiglia patriarcale dalle rovine di storie di autori antichi e monumenti giuridici fu T. Mommsen. Ma lo considerava un elemento dell’era statale e, nelle prime fasi della storia, vedeva nelle comunità familiari gli inizi di una struttura statale. I. Marquardt descrisse in modo molto dettagliato nel "Manuale delle antichità romane" (dove uno speciale volume 7 è dedicato alla famiglia) la struttura della famiglia e la posizione giuridica del suo capo - pater familias, nonché della moglie che era in suo potere - in manu, figli - in patria potestate, schiavi - in dominicia potestate.
In tempi più moderni la famiglia romana suscitò il particolare interesse di R. Paribeni. Ma concentrò la sua attenzione sui fondamenti morali che, a suo avviso, lo distinguevano favorevolmente dalla famiglia di altri popoli, compresi i popoli indoeuropei. Nell'immagine di R. Paribeni, la familia Romana appare idealizzata come base delle virtù umane. Contemporaneamente a questo libro è stata scritta un'opera in più volumi di K.U. Westrup. Occupa un posto speciale nella storiografia del problema. Le sue fonti non sono solo la tradizione antica e i monumenti giuridici, ma anche un ampio materiale sull'etnografia dei popoli primitivi antichi e moderni. Tuttavia, il significato del lavoro di Westrup non si limita a questo. Egli esplora in molti modi il cognome romano - come manifestazione di una comunità di culto, comunità di beni e potere paterno - patria potestas. È importante anche che Westrup abbia esaminato il cognome romano storicamente, in evoluzione, individuando i nuclei antichi originari nelle formule giuridiche successive che caratterizzarono la famiglia dell'epoca del diritto romano classico.
Essendo uno scienziato con una visione del mondo idealistica, Westrup considera il fattore primario e costitutivo del cognome romano la comunità di culto e la sacra solidarietà delle generazioni. Si oppone all'idea del matriarcato di J. Bachofen come stadio universale dello sviluppo umano e alla comprensione del matriarcato come un sistema in cui le donne occupavano una posizione dominante. Allo stesso tempo, riconosce la presenza di un sistema di parentela matrilineare come conseguenza della promiscuità, ma attribuisce categoricamente questi fenomeni a popoli non indoeuropei. Questa tesi, ovviamente, non può essere accettata, perché è stata più volte confutata dalla ricerca moderna, che ha dimostrato l'unità di sviluppo della società umana, indipendentemente dall'etnia delle persone. Ma lo studio specifico di Westrup sulla famiglia patrilineare romana è degno di nota. Innanzitutto è da segnalare la sua analisi dei beni familiari nel diritto romano antico, alla quale è dedicato l'intero secondo volume della sua monografia. Westrup sostiene il fatto che inizialmente esisteva una terra romana comune e una proprietà curiale o gentilizia della terra. La proprietà privata della terra apparve solo sotto Servio Tullio e fu stabilita al tempo delle leggi delle XII tavole. Westrup associa lo sviluppo dei rapporti di proprietà alle condizioni economiche e geografiche e considera la famiglia il portatore di questi rapporti. Usando il metodo comparativo, mostra che tra le tribù germaniche e slave la coltivazione del grano e le distese di campi portarono all'esistenza a lungo termine della proprietà fondiaria comune, mentre la singola famiglia divenne proprietaria del raccolto. Al contrario, nei paesi del Sud (Grecia e Italia) si coltivavano la viticoltura e l'olivicoltura. Ciò ha comportato l'assegnazione degli appezzamenti per lungo tempo alle stesse famiglie. In queste condizioni cominciò a incarnarsi il diritto di proprietà privata di una singola famiglia - domus.
Westrup ritiene che il termine heredium, cioè pgaedium parvulum, riscontrato presso gli autori antichi, sia una designazione di beni familiari ereditati, mentre i terreni assegnati dall'ager alle singole famiglie furono probabilmente inizialmente restituiti alla comunità (curia o gens) dopo un certo periodo tempo per la ridistribuzione. Westrup sottolinea un punto molto importante: a differenza della pecunia, la ricchezza della famiglia prodotta dal lavoro personale dei suoi membri, cioè dei beni di cui il pater familias disponeva liberamente, l'heredium come base della famiglia era originariamente un bene inalienabile. patrimonio. Nel diritto romano antico quest'ultimo compare solitamente con il termine ercto non cito. Il ricercatore non è d’accordo con l’interpretazione frequente di questa espressione come “proprietà ereditata o ereditaria”. Questa traduzione si basa sull'etimologia di erctum<(h)erectum, связанной с heres (наследник) или, может быть, herus(?) (господин), что он считает неудовлетворительным. Citum Westrup tiene conto anche di altri tentativi di interpretazione dell'espressione citata. (H)erectum era associato non a heres, ma a (h)ercisci e in questo caso veniva spiegato anche come “qualcosa di diviso”, o divisione (di eredità). Il verbo ciere può essere tradotto, tenendo conto dell'uso di Cicerone, non solo con la parola “muovere”, ma anche con “pretendere”. Quindi erctum citum dovrebbe significare "la divisione richiesta [dell'eredità]", ed erctum non citum - "non la divisione richiesta [dell'eredità]", o la proprietà indivisa della famiglia. Questa formula, secondo Westrup, presuppone che inizialmente esistesse una proprietà familiare indivisa o indivisa. Questa conclusione ci sembra del tutto legittima e molto importante. Westrup vede un'ulteriore prova dell'esistenza di una proprietà familiare primaria e indivisa in un frammento del manoscritto delle "Istituzioni" di Guy (III, 154). Questo manoscritto risale al IV o all'inizio del V secolo. È quindi più antica della celebre versione delle “Istituzioni” del palinsesto veronese. Ma è anche più piena di lui. Il nuovo frammento contiene informazioni aggiuntive riguardanti le comunità (societates) prese in considerazione dal diritto romano. Vi viene menzionato un antico tipo di comunità, costituita dagli eredi (sui heredes) del capofamiglia defunto, che possedevano beni comuni (ercto non cito). Westrup fornisce poi un altro argomento: le leggi delle XII tavole (V, 10) riconoscono il diritto di intentare un'azione chiedendo la divisione dell'eredità (actio familiae erciscundae) dopo la morte del padre di famiglia. Da questa legge consegue infatti che tali pretese non erano precedentemente praticate, cioè l'eredità non veniva divisa tra coeredi. Infine, il ricercatore presta particolare attenzione a quel passo del Digesto (XXVIII, 2, 11), in cui si dice che un tempo i figli della casa (sui heredes) durante la vita del capofamiglia erano una sorta di comproprietari dei beni di famiglia, tanto che dopo la morte di quest'ultimo, il passaggio dei beni da non venne effettuato di mano in mano, ma sembrò continuare la sua esistenza (continuatio dominii). L'unico cambiamento è stato che il figlio ha assunto la gestione vera e propria del patrimonio familiare, il patrimonio di famiglia. Questa osservazione ci sembra molto significativa. Esso getta luce sulla posizione del pater familias nell'antichità, indicando che anticamente egli non poteva disporre in modo dispotico dei beni caratterizzati dal termine familia. Questa parola, come sai, ha molti significati. Infatti, il Digesto (L, 16, 195, § 1) dice che per esso si intendono sia i beni (res) che le persone (personae), provenienti dalla stessa casa (cioè moglie) e dallo stesso clan (cioè figli, nipoti ) e schiavi. Secondo Paolo Diacono (Famili), la parola stessa familia deriva dall'osco famel, che corrisponde al latino servus (schiavo). Anche se la dipendenza delle parole è invertita, ciò non cancella l’appartenenza degli schiavi alla famiglia. Confrontando i dati sulle societates e le pretese di divisione ereditaria si può affermare che nel primo periodo non esisteva ancora il potere dispotico del pater familias sui membri della famiglia. Sottolineiamo che questa tesi di Westrup è di grande importanza per le caratteristiche della prima familia romana, e allo stesso tempo dell'intera società. Un posto importante in numerose opere che trattano il problema del cognome romano è occupato dalle opere più volte citate di P. De Francisci, sebbene non siano specificatamente dedicate a questo problema. Come accennato in precedenza, De Francisci non vede una differenza fondamentale tra una famiglia grande e una piccola, individuale, poiché a Roma entrambe hanno una struttura e un carattere patriarcale simili. A questo punto si oppone a F. De Martino, che giustamente considera la piccola famiglia una tipologia familiare successiva, legata ad un tipo di economia più intensiva. De Franchisci prestò particolare attenzione al culto degli antenati e alla festa dei Parentalia. Poiché, secondo Festo, secondo le norme giuridiche, parens non è solo il padre, ma anche il nonno e il bisnonno, il che è vividamente confermato nell'iscrizione (CIL, IV, 1679) “habeas propitios deos tuos tres”, il il ricercatore è giunto alla conclusione che i di parentes per i romani erano limitati a tre generazioni (padre, nonno, bisnonno), sebbene venerassero anche antenati più lontani. Da qui De Francisci trasse la ingegnosa conclusione che il criterio delle tre generazioni dovesse determinare anche il gruppo dei parenti più prossimi tra i vivi, cioè la familia, che componeva il gruppo degli agnati. Si noti che il confine naturale della familia era effettivamente di 3-4 generazioni e, probabilmente, è stata questa circostanza "terrena" a creare l'idea di divinità paterne particolarmente vicine da tre generazioni ascendenti. Ma il fatto stesso della venerazione dei di parentes costituiti da padre, nonno e bisnonno, notato dal De Francisci, è significativo. Importante è un'altra sua osservazione e cioè che nel calendario religioso romano, dopo i Parentalia, vi era un giorno dedicato alla Charistia, legato al culto dei morti, in cui, secondo Valerio Massimo (II, 1, 8), hanno preso parte solo affini e parenti. Da ciò lo scienziato trasse la logica conclusione che il culto dei morti teneva conto del gruppo cognatiano, per così dire “termini sobrino”, cioè comprendente il sesto grado di parentela lungo la linea laterale. Così il De Francisci giunge alla conclusione che il gruppo agnaziano di 3 generazioni venerava di parentes, come quello cognaziano, fino al 6° grado. In altre parole, ciascuno dei gruppi aveva determinati confini. Ci teniamo a sottolineare l'importanza di questa conclusione, perché ci permette di isolare due unità strutturali della società romana. Un tentativo di ricostruire un cognome romano antico appartiene a D. Lotze. Non è d'accordo con De Franchisci, che non vede la differenza tra un individuo e una grande famiglia patriarcale. D. Lotze vede giustamente la primitiva familia Romana come una famiglia patriarcale, comprendente figli sposati e perfino nipoti con figli e mogli, subordinata alla patria potestas di un unico padrone. D. Lotze si oppone però alla possibilità di intendere questa istituzione romana come una comunità domestica in cui sono uniti parenti collaterali uguali; cioè come una sorta di fratriarcato. A questo punto polemizza con G. Broggini, che nel suo ragionamento si basa sul citato nuovo frammento delle “Istituzioni” di Guy (III, 154). Non si può non essere d'accordo con Lotze che il paragone del consorzio romano con la multa irlandese, fatto da Broggini, è legittimo solo entro certi limiti. Mentre tra gli Irlandesi in una famiglia numerosa uno dei fratelli è il capo, nell'associazione romana dei fratelli sono tutti uguali, e ciascuno di loro, divenendo pater familias, riceve una parte uguale dell'eredità. Pertanto, la conclusione di Lotze secondo cui la famiglia allargata romana, di regola, faceva a meno dei parenti collaterali merita un riconoscimento incondizionato. Recentemente è apparsa un'altra opera speciale dedicata alla famiglia romana. Appartiene alla penna del famoso linguista Emilio Peruzzi. L'opera di Peruzzi è interessante soprattutto perché esamina l'inizio dell'era reale. L'autore presuppone che il sistema onomastico sia legato alla struttura sociale, quindi studia i nomi propri romani. Tra i romani di origine albanese, cioè latina, conosciuta secondo l'antica tradizione, si trova un nome. I nomi binari, a suo avviso, appartengono ai Sabini, tanto che Proculus Julius o Mettius Fufetius, persone della famiglia albanese, sono un esempio di influenza culturale sabina. Peruzzi spiega l'introduzione del terzo nome, cioè cognomen, con il numero limitato di nomi personali (praenomina) presso gli antichi romani, che portarono a molti omonimi. Per comodità e per evitare confusione, alla persona è stato assegnato un elemento aggiuntivo che la designa. Tale interpretazione non sembra sufficiente. Dopotutto, il cognome cominciò ad essere ereditato, cioè fu assegnato ai discendenti più vicini. È noto che in epoche successive il cognomen designava un ramo del clan, oppure un cognome, mentre per designare una persona particolarmente illustre veniva utilizzata la quarta componente del nome, solitamente sotto forma di aggettivo. Ma questo soprannome personale non veniva più trasmesso ai bambini, rimanendo una caratteristica distintiva di una persona. T. Mommsen ha osservato che i cognomi stabiliti dietro l'intera casa, cioè dietro un ramo correlato, si perdono nell'oscurità dei secoli, ma non possono riferirsi all'antichità più profonda. Collega questa istituzione al processo di colonizzazione, in cui una parte del clan fu sfrattata e dovette ricevere una designazione speciale. Il ricercatore chiama i più antichi portatori di cognomen patrizi - Cornelii, con rami - Malugipenses, Scipios, Cossae, Sullas, ecc. I primi cognomen, quindi, compaiono nel IV secolo. dalla fondazione di Roma. L'assegnazione del cognomen alle successive generazioni di parenti diretti in linea discendente ha comportato l'isolamento di tutto questo gruppo di parentela, cioè del cognome. Pertanto, la comparsa di cognomen ereditari riflette un fatto importante nella storia della società romana. Come si evince da queste fonti narrative e dalle osservazioni di Mommsen sui fasti, i cognomen sono insoliti per l’epoca reale. E questa circostanza ci sembra molto significativa. Essa mette in luce la posizione della familia all'interno della gens: essa non è ancora in opposizione alla gens, sebbene sia già emersa come la sua cellula importante. Tutto quanto sopra consente di considerare la comparsa del cognomen non tanto un fatto indicativo della crescita numerica della popolazione romana, come si può dedurre dalla citata osservazione di E. Peruzzi, quanto piuttosto un indicatore dello sviluppo socio-politico della Roma. Inoltre, studiando i nomi romani, E. Peruzzi avanzò la tesi secondo cui nomen nei primi tempi era associato a familia, e non a gens, e indicava l'appartenenza a una famiglia e non a un clan. In generale, a suo avviso, l'onomastica romana, in cui è visibile una certa struttura sociale, si è sviluppata nella direzione direttamente opposta a quella prevista per la società. Sulla base di questa affermazione possiamo concludere che la familia ha preceduto la gens, cosa su cui non possiamo essere d'accordo. Pertanto, la scienza ha fatto molto per ricostruire il cognome romano nei primi tempi, compreso il periodo reale. Ma non è stata ancora raggiunta un'unità di opinione nemmeno su questioni cardinali come il suo carattere - piccolo o grande, se grande, come una fratriarcata o guidato da un pater, un parente più anziano in linea diretta. Inoltre, nella maggior parte delle opere, ad eccezione di E. Peruzzi, il cognome a livello dell'inizio della Roma reale non è specificamente considerato. Intanto le nostre fonti contengono materiale che ci permette di soffermarci specificamente sul tempo dei primi re. Ed è importante confrontare questi dati con quanto si può ricavare da fonti giuridiche più recenti. Innanzitutto dovremmo soffermarci sulla composizione personale, per così dire, della famiglia (personae). Lo riportano i Digesti (50, 16, 195, § 1) con riferimento alle leggi delle XII tavole. L'ultima circostanza è significativa, perché ripristina così il carattere della famiglia della prima repubblica. § 2 elenca i membri della famiglia proprio iure. Ce ne sono molti (pluri), tutti sotto l'autorità di un capofamiglia, o per natura o per legge. Il capofamiglia è il pater familias, comprende la mater familias, i figli con i figli, cioè nipoti e nipoti, e le figlie. Questo elenco termina con la parola "deinceps", il che significa che la serie può continuare ulteriormente, almeno fino ai pronipoti. Inoltre, possono essere adottati figli e nipoti. Ciò consegue dagli scoli veronesi all'Eneide di Virgilio (I, 237): «Un genitore (genitor) è migliore di un padre (pater), perché [una persona] diventa padre per adozione, e un genitore non è altro che colui che partorisce." I Digesti (50, 16, 51) indicano che con la parola “parents” si intende non solo il padre (pater), ma anche il nonno e la nonna, e il bisnonno e la bisnonna, e tutti quelli che seguono in linea ascendente. . La definizione di Fest della parola “parents” si basa su questa posizione: “Nella vita di tutti i giorni, padre o madre sono chiamati così, ma gli avvocati ritengono che sia il nonno che il bisnonno, sia la nonna e la bisnonna siano chiamati con questo nome. " Indubbiamente questi testi, che danno un’idea di fenomeni e concetti sorti nell’antichità, testimoniano il carattere multigenerazionale ed esteso della famiglia romana. re. Condividendo questo punto di vista, è necessario soffermarsi su questo strato di testimonianze antiche sull’attività dei primi sovrani a Roma: una parte significativa delle leggi di Romolo riguarda questioni familiari. Questo fatto stesso parla dell'importanza del cognome nella società. Festo (plorare), in un testo piuttosto corrotto, afferma che una delle leggi di Romolo e Tazio riguardava la punizione delle giovani donne. La legge parla di punizione, evidentemente per aver violato le norme familiari, perché il colpevole viene sacrificato agli dei patrigni (dus parentum), poiché questa legge è menzionata da Festo come in una selezione tematica, cioè insieme all'istituzione attribuita a Servio Tullio sull’iniziazione agli stessi dei di un figlio o nipote (puer), che insultò tanto il padre da farlo piangere, si può pensare che il peccato della nuora fosse simile. La suddetta legge indica chiaramente che la famiglia era patriarcale con la subordinazione del minore al maggiore, ma ciò non basta. Poiché Festo usa la parola “nurus”, che significa ugualmente la moglie di un figlio e la moglie di un nipote o pronipote (Dig. L, 16, 50), il testo serve come ulteriore argomento a favore del grande- carattere familiare della familia romana.Indirettamente Tazio indica il gran numero di membri della famiglia la partecipazione però del suo nucleo familiare, insieme ai suoi parenti, all'attacco di rapina agli ambasciatori laviniani (Plut, R, XXIII). È lecito, nel contesto che ci interessa, coinvolgere anche dati provenienti dalle tradizioni su Numa. Era il quarto figlio di suo padre e, avendo sposato Tatia, rimase nella casa dell'anziano genitore (Plut., N., 3). Secondo una versione, trasmessa da Dionisio (II, 76) e Plutarco (N., 21, 1-3), Numa da due matrimoni ebbe una figlia, Pompilio, e quattro figli: Pompon, Pinus, Kalp e Mamerk. Quindi, la famiglia era numerosa e non ci sono indizi che già sotto Numa si fosse divisa in piccoli. Si potrebbe pensare che questo collasso sia avvenuto molto più tardi, dopo diverse generazioni. Dopotutto, anche l'epoca repubblicana conobbe esempi di grandi famiglie patriarcali con proprietà indivisa e casa comune. Nel II secolo a.C. e. questo, a quanto pare, era già una rarità, perché due autori menzionano lo stesso caso, vale a dire la famiglia Eliev. È vero, entrambi citano questa famiglia come un esempio degno di imitazione di amicizia familiare, in cui non c'erano litigi sull'eredità. Tuttavia, i fatti riportati sia da Plutarco (Aem. Paul., V) che da Valerio Massimo (IV, 4, 8) indicano che gli Eliani, di cui erano 16 persone, vivevano tutti insieme in una casa angusta con i loro numerosi discendenti, possedeva congiuntamente una piccola tenuta nella regione di Veyent, aveva un posto d'onore negli spettacoli al Circo Massimo e a Flaminiev. È noto che la figlia di Emilio Paolo, due volte console e due volte trionfatore, era sposata con uno di questi Elia, non vergognandosi, come notò Plutarco, della povertà del marito. Lambert ha trovato un'analogia per una famiglia così numerosa, che comprende 16 capi di piccole famiglie, nella multa irlandese. Questo organismo conteneva 4 gruppi di parenti, cioè 4 generazioni, a partire da un certo capofamiglia, suo padre, suo nonno e bisnonno. Fine possedeva un appezzamento di terreno di una certa dimensione: baile. Ciascuno dei quattro gruppi che componevano la multa controllava 1/4 del baile, che veniva chiamato tate (circa 16 o 32 ettari a seconda della qualità e dell'ubicazione del terreno), nonché 1/4 della casa. Ogni quartiere della casa, a sua volta, era diviso in 4 parti secondo le quattro generazioni dei suoi discendenti. Così, 16 famiglie si sono riunite sotto un tetto comune e attorno allo stesso focolare. Lambert, seguendo Hubert, traduce la parola fine nelle parole francesi famille e maison, poiché fine occupava una grande abitazione (treb) fortificata con un recinto di pietra, che era il rifugio e il centro di 16 menage, cioè famiglie. Ciò significa che Lambert intende la fine come una grande famiglia, nella quale però si stanno già cristallizzando famiglie più piccole, ognuna delle quali coltiva il proprio appezzamento di terreno. In altre parole, la versione irlandese è piuttosto un gruppo di famiglie strettamente imparentate con inclusa l'assegnazione di proprietà fondiarie ad uso di famiglie più piccole, o una grande famiglia patriarcale senza completa unità produttiva, cioè l'inizio del patronimico. Quanto agli Eliani romani, erano solo uno dei frammenti della famiglia, solo un ramo della stessa, perché un membro di questa famiglia, che aveva appena sposato la figlia di Emilio Paolo, era Elio Tuberone. Portava un cognomen speciale, mentre a Roma vivevano gli Aelii Peti, Lamia e altri, tra cui i più notevoli erano i Peti, perché furono loro, secondo Fasti, ad occuparla nel IV - inizio II secolo. AVANTI CRISTO e. posto consolare (nel 337, 286, 201, 198 a.C.). Quanto al ramo di Tuberon, pur essendo considerato rispettato, visse male e non raggiunse le più alte magistrature. A differenza degli irlandesi, gli Elii sopravvissero anche nel II secolo. AVANTI CRISTO e. un tipo di comunità classica di famiglia numerosa con produzione e consumo comuni, cioè riflettevano la sua fase più arcaica. E il loro esempio, con ancor maggiore diritto di quello irlandese, può essere utilizzato per ricostruire il sistema sociale dell'antica Roma. Pertanto, la numerosa vita familiare degli Eliev può essere proiettata all'inizio dell'era reale. Oltre alla legge sulla punizione della nuora, di cui si è parlato sopra, la tradizione attribuisce a Romolo altre tre leggi. Uno di essi istituisce un matrimonio di tipo confarreatio e la posizione della moglie come padrona di casa ed erede del marito insieme ai figli. Secondo la stessa legge, la moglie che ha peccato è giudicata dal marito insieme ai suoi parenti. Tra i crimini punibili con la morte, le nostre fonti menzionano il bere vino, che comporta la perdita della virtù (Dionys., II, 25; Plin., N.H., XIV, 3, 89; Serv. Aen., I, 737). La confarreatio, a giudicare dall'uso dell'orzo in questo tipo di matrimonio, è una norma antichissima. È interessante notare che Guy (I, 112), descrivendo una tale cerimonia nuziale, menziona dieci testimoni. Secondo l'arguta ipotesi di G. Franciosi si trattava di cinque testimoni provenienti da ciascuno dei due clan esogami da cui provenivano gli sposi. È interessante notare che in questo antico matrimonio la moglie è designata come erede. Se nella successiva edizione del monumento legale la dignità della moglie è un po' esagerata, lei non sembra ancora una schiava domestica, e il marito non sembra un despota assoluto. Il destino di una moglie immorale non è deciso solo dal marito, ma insieme ai membri del clan. Ciò fornisce ulteriori ragioni per ritenere che la famiglia fosse ed fosse riconosciuta proprio come un'unità del clan. Secondo la seconda legge, trasmessa da Plutarco (R., XXII), Romolo proibiva alla moglie di lasciare il marito e allo stesso tempo vietava la vendita della moglie, pena il sacrificio del marito che lo faceva agli dei sotterranei. Questa legge lascia supporre che la famiglia nella società sia chiaramente definita e il re cerchi di rafforzarla, in particolare, privando una donna della libertà di controllare il proprio destino. Ma i diritti del marito nei suoi confronti, come nel caso precedente, non sono illimitati. L'eccesso di potere su sua moglie è punibile con la morte. Secondo la terza legge, citata in altro contesto, l'uccisione dei bambini che vivevano fino a 3 anni era limitata, salvo evidenti deformità, cosa confermata nuovamente dalla testimonianza di cinque, questa volta vicini di casa (Dionys., II , 15). Ciò era dovuto non solo all'aumento del livello delle forze produttive, di cui abbiamo parlato, ma testimoniava anche il controllo sullo sviluppo della famiglia da parte del sovrano della nascente comunità romana. Ciò significa che tale istituzione conferma anche l’assenza di una patria potestas illimitata. Anche la menzione dei vicini nella legge è significativa, poiché mostra l'importanza della famiglia non solo all'interno della comunità clanica, ma anche in un insediamento di tipo vicinato. Così le leggi romulane, cioè testi risalenti ad istituzioni autentiche, e non semplici analogie, permettono di immaginare il cognome romano della seconda metà dell'VIII secolo. AVANTI CRISTO e. non come una famiglia individuale, ma come una grande comunità domestica patriarcale multigenerazionale, o una famiglia senza alcun potere illimitato del pater familias come in seguito. E ciò non è smentito dai materiali archeologici, cioè dalle tracce di capanne dell'epoca sul Palatino. Possono trattarsi di piccole abitazioni, circa 30 mq, ma sono ubicate una vicina all'altra. Inoltre, le condizioni del terreno non consentivano la costruzione di grandi case. I dati etnografici suggeriscono anche che l’intera famiglia allargata non vive sempre sotto lo stesso tetto. Consideriamo ora le leggi di Numa riguardanti la familia. Ci sono quattro di loro. Dionigi (II, 27) riferisce dell'emancipazione del figlio dopo che il padre lo vendette tre volte ex arcaiV, cioè da tempo immemorabile. Questa norma fu poi registrata nelle leggi delle XII tavole (IV, 2). Lo stesso testo dionisiaco afferma che Numa approvò una legge che vietava la vendita del figlio sposato. Una legge simile è attribuita a Numa e Plutarco (N., XVII). La Roma dei primi re conosceva già la schiavitù. La società era già gravata dalla disuguaglianza patrimoniale, quindi la vendita di una moglie, come abbiamo accennato prima, o di un figlio non sembra incredibile. Ma la triplice vendita di un figlio suggerisce differenze economiche più profonde tra i romani di quanto fosse concepibile all'inizio del tempo del re, quindi "tempo immemorabile" non deve necessariamente riferirsi alla fine dell'VIII o all'inizio del VII secolo. AVANTI CRISTO e. Tuttavia, la menzione di questa misura probabilmente non è casuale insieme alle leggi del secondo re. Tutte le istituzioni qui elencate sembrano parlare non di limitazione del potere del pater familias, ma del fatto che egli non dispone ancora di un potere illimitato. Al nome di Numa è associata un'altra legge, di cui parla Paolo Diacono sotto la parola “Pelices”. Vietava alla concubina di toccare l'altare di Giunone. Per mancato rispetto del divieto, il trasgressore doveva sacrificare un agnello alla dea. L'epitomatore spiega che i pelici erano in realtà coloro che sposavano un uomo sposato. Questa è una prova interessante che ci permette di parlare della poligamia vera e propria, cioè di una reliquia del matrimonio di gruppo durante il regno dei primi re. Un ricordo di questo tipo di rapporto matrimoniale tra i romani è contenuto nel Confronto tra Licurgo e Numa di Plutarco (III). Lo scrittore vi dice che “sebbene la comunità (koinwnia) di mogli e figli ragionevolmente e a beneficio dello stato bandisse il sentimento di gelosia” sia a Roma che a Sparta, questi legislatori tuttavia risolsero diversamente la questione del rapporto tra marito e moglie . A Sparta era praticamente consentita la poliandria, ma a Roma il marito poteva rinunciare alla moglie per il bene di avere figli ad altri uomini, ma dandola in matrimonio e non lasciandola a casa sua. Rispetto alla legge di Romolo, che vietava alla moglie di lasciare il marito, si può trarre la seguente conclusione: esistevano ancora vestigia di rapporti matrimoniali di gruppo, ma entrambi i sovrani cercarono di limitarne l'effetto, rafforzando così la famiglia patriarcale. Questa idea della situazione familiare a Roma in quel lontano tempo può in una certa misura essere confermata dalla testimonianza di Aulo Gellio (XXIII, 1, 9), ripetuta quasi testualmente da Macrobio (Sat., I, 6, 19) . Gellio, riferendosi a Catone, riferisce che fin dall'antichità esisteva a Roma l'usanza secondo la quale i senatori portavano con sé alle riunioni i figli dell'adolescenza (praetextati filii). Nessuno avrebbe dovuto essere informato dei dibattiti al Senato prima dell'approvazione della risoluzione. Tuttavia, la madre del giovane Papiria apprese da lui che nell'incontro si stava discutendo la questione di cosa sia più utile per lo Stato: che uno abbia due mogli o che una sia la moglie di due. Venuto a conoscenza di ciò, la curiosa rese immediatamente segreto questo Senato proprietà di tutte le matrone. Le matrone erano particolarmente inorridite dalla prospettiva di diventare mogli di due uomini contemporaneamente e si recavano in curia con le preghiere. Successivamente il figlio di Papirio ricevette il soprannome di Praetextata e ai bambini non fu più permesso di unirsi ai loro padri in Senato. Il riferimento a Catone stabilisce un terminus ante quern e consente di datare il dibattito di Senaga all'inizio della Repubblica. Ma l’argomento stesso della discussione è degno di nota. Ciò significa che anche a quel tempo, che è conosciuto come il periodo di massimo splendore della grande famiglia monogama con l'onnipotenza del padre, la possibilità sia della poligamia che della poliandria era, in linea di principio, consentita, sebbene non trovasse conferma legislativa. Inoltre, fenomeni simili sono possibili per la prima epoca reale. Le fonti suggeriscono l'esistenza di sopravvivenze e di altre forme primitive di rapporti familiari e matrimoniali. Hanno attirato l'attenzione dei ricercatori moderni. Erica Mager-Pirnat individuò nella saga di Orazio e dei Curiati una versione molto antica, di cui non venne presa in considerazione da Tito Livio, che parlò di Orazio solo come della sorella degli eroi romani e come della sposa di uno degli albanesi. Dionisio nota che gli Orazi e i Curiazi erano imparentati perché le loro madri erano sorelle. Zonara e Columella, indipendentemente da Dionisio, parlano solo della parentela dei partecipanti al torneo. Il motivo della parentela, secondo la giusta opinione del ricercatore, riflette uno strato molto antico di relazioni primitive tra i latini. Il materiale relativo ai matrimoni tra parenti stretti esistente nel Lazio antico è stato raccolto e analizzato dettagliatamente da G. Franciosi. Il ricercatore, non senza ragione, vede resti di fenomeni caratteristici di profonda primitività nella leggenda registrata dallo pseudo-Plutarco (N., 22), su una certa Valeria di Tuscolo, presa da una passione empia per il proprio padre, nel resoconti di Dionigi e Plutarco su Amulia e Rea-Silvia. Un altro strato, anch'esso molto antico, di norme matrimoniali prevede il fidanzamento di Lavinia con Turno, che, secondo la versione più comune, era nipote di Amate, moglie di Latino (il che significa che Lavinia e Turno erano cugini dal lato materno) lato); il fidanzamento di Orazia con Curiazio e il matrimonio delle figlie di Servio Tullio con i figli della sorella di sua moglie Tarquinia, figlia di Tarquinio Prisca. Tutti questi casi parlano di unioni matrimoniali tra cugini per parte materna e sono giustamente considerati da Franciosi come tracce di rapporti preesistenti alla creazione di classi matrimoniali esogame, mentre l'episodio del rapimento delle Sabine testimonia l'usanza di lo scambio delle spose, cioè, rientra nel quadro dei doppi matrimoni noto agli etnografi come sistemi esogami. Come si può vedere dai dati della tradizione di cui sopra, il periodo in esame è caratterizzato da resti della prima società tribale come la valutazione della parentela matrilineare come particolarmente stretta e significativa. Ciò può essere giudicato dalla reazione di Amata al rifiuto di Turnu di sposargli Lavinia (Amata impazzì dal dolore), dalla preferenza nella famiglia di Servio Tullio per i matrimoni delle figlie reali con i loro cugini da parte di madre, così come dal già notato fatto di vendetta per la disonorata Lucrezia da parte di suo fratello, non di suo marito. Tracce di idee simili si trovano a Roma in tempi successivi. Ne è un esempio la storia di Cecilia, moglie di Metello, raccontata da Valerio Massimo (I, 5, 4). Fu lei, e non la sorella, secondo l’antica usanza (more prisco), a chiedere agli dei un segno riguardante il matrimonio della figlia di quest’ultima, cioè per sua nipote. Cecilia era talmente preoccupata per la sorte della ragazza giunta all'età da marito che si disse pronta a darle il proprio marito. Le parole, dettate dal tenero amore per la figlia di sua sorella, non furono vane. Poco dopo la morte di Cecilia, Metello sposò sua nipote. Un altro esempio convincente è Matralia. Si celebrano in onore di Mater Matuta, identificata con Ino-Leucothea (Ov., F., VI, 479-506; Plut. Cam., V). Nel rituale della festa viene compiuto un rito in cui le donne abbracciano i figli delle sorelle invece dei propri (Plut., Cam., V; Qu est Rom, 17). In Ovidio (F., VI, 559-562) ciò si spiega con il fatto che Ino si rivelò più utile a Bacco, cioè al nipote avuto dalla sorella Semele, che ai suoi figli. Il legame particolarmente stretto tra la zia materna e i nipoti è una traccia di quella fase dello sviluppo sociale in cui anche il clan patriarcale e la famiglia numerosa non si erano ancora formati ed erano in vigore i matrimoni di gruppo. In epoca repubblicana il clan, sia pure in forma trasformata, era esogamo, il che permette di proiettare il divieto di matrimonio all'interno della gens fino all'epoca regia. Allo stesso tempo, sappiamo che i successivi monumenti giuridici dichiararono il divieto di matrimoni fino al 7° grado cognaziano. Di conseguenza, se i parenti oltre il 7° grado non abbandonavano il clan, di fatto questo non era del tutto esogamo. I resti del matrimonio di gruppo, di cui abbiamo parlato sopra, ci permettono di credere che il confine dei rapporti coniugali, cioè il 6°-7° grado di parentela, avrebbe potuto essere determinato proprio nella Roma primitiva. delle forme più primitive, fu un fenomeno di progresso sociale. Dal “Confronto” tra Numa e Licurgo che abbiamo già considerato, Plutarco rivela un'altra istituzione di Numa relativamente. famiglie. Il re romano, a differenza del legislatore spartano, diede ai genitori la libertà di allevare i propri figli come preferivano. Il padre potrebbe, a sua discrezione, mandare il figlio a diventare contadino, medico, flautista, ecc. Plutarco condanna questo ordine, considerandolo la base della fragilità. Tuttavia, attraverso il moralismo di Plutarco, traspare una certa caratteristica della famiglia romana all'inizio del regno dei re: è più indipendente della famiglia spartana nel quadro di comunità sociali più ampie, principalmente all'interno del clan. Un'altra legge appartenuta a questo re getta luce sullo stato della famiglia a Roma sotto Numa. Secondo il commentatore virgiliano Servio (Ecl., 4, 43), le leggi di Numa prevedevano la punizione per l'omicidio colposo. Consisteva nel fatto che il colpevole doveva dare un ariete ai suoi agnati nell'assemblea nazionale per l'assassinato. Questo messaggio è interessante sotto diversi punti di vista. Mostra il progresso di Roma in quel tempo sotto vari aspetti della sua esistenza: la limitazione della vendetta di sangue, che era ancora in uso sotto Romolo, come si vede dall'episodio della discordia tra Tito Tazio e gli abitanti di Lavinio, come così come lo sviluppo del pensiero giuridico, vale a dire l’enfasi sull’omicidio colposo. Allo stesso tempo, il commento di Servio è degno di nota anche per la menzione degli agnati. Il termine stesso, come si rivela leggendo i testi giuridici delle leggi delle XII tavole, delle “Istituzioni” di Gaio o i testi contenuti nei “Digesti”, accompagna sempre i rapporti che si sviluppano all'interno della famiglia o tra famiglie strettamente imparentate, ed è utilizzato in relazione all'eredità dei beni di famiglia. In questo caso si tratta di un risarcimento, o più precisamente della pena per omicidio, che non è andata al clan, ma alla famiglia, il che indica un aumento della sua quota. Quindi, nonostante la natura frammentaria e fluida delle testimonianze degli autori antichi, è ancora possibile formare un quadro abbastanza olistico del cognome romano all'inizio dell'era reale, supportato da analogie etnografiche e storiche. La famiglia dell'epoca in esame era una grande comunità domestica, parte integrante della comunità clanica, gens, cioè era una comunità di ordine inferiore, compresa in una comunità gentilizia di ordine superiore. La base sia del cognome che della gens era la proprietà collettiva o il possesso dei principali mezzi di produzione, la terra, mentre la famiglia riceveva dalla gens un appezzamento di terreno. L'elemento cementante di entrambe le comunità era il lavoro congiunto, nella gens principalmente militare, e nella famiglia - produttivo. Il consumo era condiviso anche in famiglia. Il cognome romano probabilmente esisteva sotto forma di consorzio di fratelli con i loro discendenti, ma principalmente come quel tipo di famiglia, che nella scienza ricevette il nome di famiglia patrilineare. Questa grande famiglia era composta da diverse 3-4 generazioni di parenti diretti in linea discendente, guidati dal padre, o dal nonno, o dal bisnonno. In esso non esiste ancora l'onnipotenza assoluta del padre, che corrisponde al predominio dello sviluppo collettivo e debole della proprietà fondiaria privata. Ma l'importanza del capofamiglia è già sottolineata nei regolamenti dei primi re. Una tale famiglia contiene una serie di agnati più prossimi, figlio, nipote, mentre una famiglia numerosa, con a capo il fratello di un dato pater familias, è compresa nello stesso gruppo di agnati, ma già con i diritti, per così dire, di agnati di la seconda categoria. Per caratterizzare il cognome paleoromano è necessario chiarire la sua parentela con il gruppo delle Agnate. A giudicare dalle "Istituzioni" di Guy (I, 156; III, 10), possiamo dire che il gruppo Agnate era formato dal capofamiglia con la moglie, dai figli e dai nipoti con le rispettive mogli, che vivevano come un'unica grande famiglia paterna, e dopo la morte del capo - separare grandi famiglie paterne guidate da fratelli. Alla morte di uno di essi i suoi beni passavano ai suoi eredi diretti e, in loro assenza, ai fratelli superstiti. Ciò significa che il gruppo Agnate inizialmente comprendeva una grande famiglia paterna multigenerazionale. Coprì il patronimico più tardi, quando l'associazione patronimica cominciò a includere piccole famiglie individuali formate dalla divisione di un cognome grande. Ma una situazione del genere non poteva essersi sviluppata all’inizio dell’epoca zarista, con molti resti delle forme sociali più primitive. Un analogo gruppo agnate, discendente dal secondo capofamiglia, fratello del primo, cui facevano capo dopo la morte del secondo i figli, cioè cugini dei figli del primo, formava con il primo una parentela patronimica gruppo, utilizzando la terminologia moderna. Gruppi agnati simili a questi, discendenti da cugini del primo e del secondo capofamiglia, facevano parte della stessa famiglia. I gruppi eterogenei agnati formano una comunità eterogenea. In direzione verticale la gens, gens, è in linea di principio illimitata, ma in direzione orizzontale idealmente non supera il 7° grado di parentela. Questa situazione è stata determinata da due circostanze: 1) le persone si sono rese conto empiricamente che i matrimoni entro i sei gradi di consanguineità avevano un impatto negativo sulla prole, quindi questo gruppo di parenti è stato individuato come esogamo e allo stesso tempo come spina dorsale del clan esistente in un determinato momento; 2) le condizioni economiche dettavano la necessità per il clan, indicato con la parola gens e che rappresenta una comunità eterogenea, di limitare il numero delle famiglie numerose in esso incluse per garantirne l'esistenza. I termini gentiles e cognati non sono identici. Il numero dei gentili comprendeva cognati paterni sia in linea diretta che collaterale, e inoltre - le loro mogli. I cognati paterni comprendevano tutti i suoi discendenti, comprese figlie e nipoti in linea diretta, nonché i suoi parenti consanguinei, comprese zie e nipoti in linea laterale. L'appartenenza ai gentili si basava solo su rapporti con i capi delle grandi famiglie patrilineari che componevano il clan, mentre l'appartenenza ai cognati si basava su rapporti di parentela sia in linea paterna che materna. I gentili sono membri di un'organizzazione comunitaria e i cognati sono membri di un'organizzazione correlata. La composizione etnica delle gentes romane sotto i primi re, come abbiamo visto, non era omogenea. La maggior parte di loro erano clan latini e sabini. Ma alcuni di essi erano di origine liguro-sicula ed anche illirica. Potrebbero esserci una leggera inclusione di elementi greci achei e singoli elementi etruschi. La diversità etnica delle gentes, che consegue dai dati della tradizione, non consente, come sembra, di considerare l'antica Roma né come una colonia albanese, né come quella sabina, né tanto meno come quella etrusca. I colli romani, con il loro complesso popolamento, di cui lo strato inferiore erano i Liguro-Siculi, conobbero il surf di diverse ondate di colonizzazione, le più significative delle quali provenivano dall'area latina e sabina. Ma questi alieni apparentemente erano localizzati in luoghi diversi nella futura Roma. Si può quindi pensare che il sinoicismo romano fosse il sinoicismo delle colonie latine e sabine, che non sorsero dal nulla e assorbirono la popolazione precedente. Se teniamo presente il carattere latino degli aborigeni, nonché la vittoria della lingua latina nella nascente comunità romana, dobbiamo concludere che l'elemento latino era numericamente predominante nella Roma dei primi re. Una caratteristica importante dello sviluppo sociale di Roma all'inizio dell'età regia fu che le gentes erano organismi viventi costituiti da grandi famiglie patrilineari. Ma la famiglia a quel tempo era un'unità chiaramente funzionante non solo nell'ambito delle gentes, ma anche nell'ambito degli insediamenti in cui erano raggruppati sia parenti che vicini. Origine della famiglia romana. L'unione di parentela più estesa era la comunità clanica (familia gentilicia). I membri della stessa gens (gens) avevano un antenato comune, portavano il nome comune di questo antenato, avevano un culto ancestrale comune, un altare. La differenziazione della proprietà all'interno del clan con la formazione dello Stato contribuisce alla separazione delle unioni più piccole - le famiglie - dal clan. La definizione di famiglia (familia) fu data dal famoso avvocato romano Ulpiano (D. 50.16.195.1-2). Ha sottolineato che questo termine "ha significati diversi, poiché può riferirsi sia a cose che a persone." Egli distingueva anche tra la famiglia in senso stretto o stretto (proprio iure) e la famiglia in senso ampio nel diritto comune (familia communi iure). Ulpiano scrisse: " Per famiglia nel senso stretto del termine intendiamo l'insieme delle persone sottoposte all'autorità di uno, a lui subordinate per nascita o per diritto." "Famiglia per diritto comune (parentela) chiamiamo famiglia di tutti gli agnati... soggetti all'autorità di una sola persona, poiché provengono da una stessa casa e clan." F. Engels definì la famiglia romana come “un'organizzazione economica di un certo numero di persone, subordinata all'autorità paterna del capofamiglia”. Engels sottolineava il carattere patriarcale della famiglia romana. L'essenza della famiglia patriarcale è che si tratta di una grande comunità familiare che abbraccia diverse generazioni di discendenti dell'antenato maschio più anziano, insieme alle loro mogli, figli e schiavi. Fondamentalmente, l'antica famiglia romana era strettamente patriarcale. Era costruito sui principi del potere assoluto del capofamiglia (paterfamilias) sulla moglie, sui figli a carico, sugli altri parenti, sugli schiavi, sui servi, nonché su tutte le proprietà. La struttura dei legami intrafamiliari (parentela) in una famiglia patriarcale non si basava sul sangue, ma sul principio di subordinazione all'uomo più anziano della famiglia: il capofamiglia, il padre della famiglia (pater familias). I giuristi romani chiamarono agnaziano questo sistema di legami di parentela. La base formale della famiglia Agnate era un sistema di subordinazione legale - "autorità paterna" (patria potestas), quindi la parentela nella famiglia romana era stabilita solo attraverso la linea maschile. La parentela agnatica corrisponde al carattere dell'antica famiglia romana, che si basava sulla subordinazione al potere di un sovrano: questa è parentela per potere (agnatio). Gli Agnati sono uniti dalla parentela civile (Gaio 3,10). La parentela agnata è nata attraverso la linea maschile. Guy ha scritto: «Gli agnati sono parenti, uniti da parentela attraverso i maschi:» (Caio, 1.156). “Ma coloro che sono legati dal sangue tramite femmine non sono agnati...” Una figlia che si sposava con un membro di un'altra famiglia diventava legalmente estranea alla sua famiglia precedente, poiché, cadendo sotto l'autorità del nuovo capofamiglia, diventava parente agnatica della nuova famiglia. Allo stesso tempo, la persona adottata diventa parente agnatico della famiglia del genitore adottivo. Solo questo tipo di parentela era riconosciuto dal diritto civile. Parentela di sangue (cognatio): inizialmente la parentela cognatica non veniva affatto presa in considerazione. Riceve significato giuridico solo nella legge del pretore. Con l'indebolimento delle basi patriarcali della famiglia, la parentela cognaziana divenne sempre più importante. Nella legge di Giustiniano sostituì completamente la legge agnatica. I romani determinavano la parentela cognaziana per linee e gradi. Le persone che discendono l'una dall'altra (padre e figlia) sono chiamate parenti diretti. Nella linea ascendente: questi sono parenti dal discendente all'antenato (padre, nonno, bisnonno); in linea discendente: questi sono parenti dall'antenato al discendente (bisnonno, nonno, padre). Le persone che discendono da un antenato comune (zio e nipote, fratello e sorella) sono detti parenti collaterali. La parentela laterale potrebbe essere di sangue se sia la madre che il padre sono comuni; e mezzosangue: se c'era una madre comune, allora si chiamava mezzosangue; se il padre è comune, mezzosangue. Il grado di parentela era determinato dal numero di nascite che separavano i parenti gli uni dagli altri. Madre e figlio sono parenti di 1° grado, nonno e nipote sono parenti di 2° grado. Differivano anche la proprietà e l'atteggiamento di un coniuge nei confronti degli affini dell'altro (suocero, suocera, genero), che non erano di fondamentale importanza. Il matrimonio e le sue tipologie. Conclusione e scioglimento del matrimonio. Nelle Istituzioni di Giustiniano si afferma che " Il matrimonio, o cosiddetto matrimonio, è l’unione di un uomo e di una donna, presuppone una comunità di vita”. Il giurista classico Modestine caratterizza il matrimonio come «l'unione degli sposi, l'unione di tutta la vita, la comunione nel diritto divino e umano» (D. 23.2.1). Dalle definizioni di cui sopra è chiaro che i romani riconoscevano il matrimonio monogamo. Distinguevano tra un matrimonio romano reale e legale, al quale potevano contrarre solo le persone che avevano ius conubii. Solo da un tale matrimonio i figli erano considerati legittimi e soggetti all'autorità paterna e avevano diritto all'eredità. L'unione tra persone che non avevano ius conubii era un matrimonio illegale. Non ha avuto le conseguenze legali di cui sopra, sebbene fosse consentito dalla legge. La convivenza extraconiugale permanente tra un uomo e una donna, associata alla gestione di una casa comune, ma senza reciproca intenzione di sposarsi, veniva chiamata concubinare. Questa convivenza avveniva nei casi in cui il matrimonio tra determinate categorie di persone era impossibile a causa del diritto civile. La convivente (concubina) non condivideva lo status sociale del suo convivente. Con lo sviluppo della legge, i bambini in incubazione ricevono determinati diritti. La convivenza tra schiavi, tra schiavi e uomini liberi, non aveva alcuna importanza. Affinché un matrimonio fosse riconosciuto valido e giuridicamente vincolante, doveva soddisfare determinate condizioni. Il giurista romano Ulpiano scriveva: “Il matrimonio è legale se tra coloro che lo hanno contratto esiste il diritto al matrimonio legale, se sia l’uomo che la donna hanno raggiunto l’età del matrimonio, se è stato ottenuto il loro consenso come persone di diritto, o se sono soggetti, allora il consenso dei genitori» (Ulpiano, Er. 5,2 Il diritto di contrarre matrimonio legale (ius conubii) apparteneva originariamente solo ai cittadini romani e ai latini veteres. In diversi periodi storici, le leggi hanno introdotto varie restrizioni su alcune persone che contraevano matrimonio legale. Quindi, prima della Legge di Canuleo del 445 a.C. I matrimoni tra patrizi e plebei erano proibiti. Prima della legge di Augusto del 18 a.C c'era il divieto di matrimoni tra liberti e nati liberi. Un ostacolo al matrimonio era la parentela diretta senza restrizioni e la parentela collaterale con varie restrizioni a seconda dei cambiamenti legislativi. Furono proibiti i matrimoni tra senatori e libertini, senatori e attrici; tra tutore e tutore; tra il proconsole di una provincia e un residente di quella provincia; I matrimoni contratti in violazione dei divieti stabiliti erano soggetti ad annullamento. Tali matrimoni non comportavano alcuna conseguenza legale. Nel diritto postclassico il termine ius conubii perde il suo significato e cessa di essere utilizzato. L’età per sposarsi era fissata a 12 anni per le donne e a 14 anni per gli uomini. Anticamente il consenso al matrimonio era richiesto al padrone di casa e allo sposo se questi era persona sui iuris. Successivamente cominciò a essere richiesto il consenso dei subordinati degli sposi e dei loro capifamiglia, e da parte dello sposo, inoltre, il consenso della persona sotto la cui autorità paterna poteva trovarsi in caso di morte dello sposo. paterfamilias. Successivamente, in numerosi casi, ai bambini è stato concesso il diritto di sposarsi senza il consenso del paterfamilias. Il matrimonio fu preceduto da un fidanzamento che, secondo Florentin, "c'è una proposta e una promessa di futuro matrimonio"(D.23.1.1). Ciò è stato realizzato attraverso due clausole. Come scrisse Ulpiano: «Il fidanzamento (sponsalia) è così chiamato dalla parola promettere (spondere); poiché gli antichi avevano l'uso di stipulare e, mediante una promessa solenne, acquistarsi le mogli» (D. 23.1.2). Era concluso tra il paterfamilias della sposa e lo sposo o il suo paterfamilias. Se l'accordo veniva violato, l'autore del reato poteva essere punito per il danno causato. Durante il periodo post-classico venne introdotta la pratica di versare una caparra o caparra nuziale al momento del fidanzamento. Secondo la legge di Giustiniano, la risoluzione del rapporto senza motivi sufficienti comportava una responsabilità patrimoniale per l'autore del reato sotto forma di perdita della cauzione o obbligo di restituire la cauzione in misura doppia. Il matrimonio più antico, caratteristico del sistema patriarcale, era cum manu. La moglie in questo matrimonio cadeva completamente sotto l'autorità del marito o del suo capofamiglia, se il marito era un suddito. Ciò si estendeva sia alla sua persona che ai suoi beni. Legalmente diventa figlia. Cessa di essere un'agnata della sua precedente famiglia e diventa un'agnata di suo marito e della sua famiglia. Come ha sottolineato Guy, "il passaggio al potere di marito si compiva in tre modi: prescrizione, pane sacrificale e acquisto"(Caio, 1.110) Un metodo che risaltava era l'usus. Guy scrive di lui: «Attraverso la lunga convivenza, quella donna entrò nel potere del marito che rimase moglie ininterrottamente per un anno intero, divenendo, per così dire, possesso annuale dei beni del marito...» (Gai, 1.111). Tra i patrizi era usato confarian modo di sposarsi :
Secondo Guy "a In un certo modo, le donne entrano nel potere del marito attraverso un certo tipo di rito sacro, che viene compiuto dalla sposa e in cui viene consumato il pane di grano - per questo motivo questo rito solenne del matrimonio è chiamato anche confarreatio"(Caio, 1.112). Questo rito è stato eseguito alla presenza di 10 testimoni e sacerdoti, ed è stato accompagnato da parole solenni. Tra i plebei veniva usata la coemptio, un rito di vendita simbolica. Guy ha scritto: «Quanto alla “comprata”, in base ad essa le donne entrano nel potere del marito per mancipazione, cioè sulla base di una vendita simbolica, alla presenza di meno di cinque testimoni di cittadini romani adulti, nonché un pesatore, quello sotto il cui potere compra la moglie che sta trasferendo"(Caio 1.113). Oltre al matrimonio sotto l'autorità del marito, le Leggi delle XII Tavole indicano l'esistenza di un altro matrimonio - sine manu, in cui la moglie non era sotto l'autorità del marito. Lo afferma la tabella VI “una donna che non voleva che il potere del marito fosse stabilito su di lei [a causa della convivenza di lunga data con lei] doveva lasciare la sua casa per tre notti all’anno e interrompere così il suo mandato di un anno”.. Questo doveva essere ripetuto ogni anno. Allo stesso tempo, il matrimonio sine manu non ha modificato lo status giuridico della moglie. Ella manteneva il suo precedente stato civile, continuando ad essere persona sui iuris se lo era stata prima del matrimonio, oppure rimanendo soggetta al padre e giuridicamente estranea ai figli e al marito. In un matrimonio sine manu, rimase un'agnata della sua precedente famiglia. In termini di proprietà, la moglie non dipendeva dal marito. Essendo sorto più tardi del matrimonio cum manu, il matrimonio sine manu esiste parallelamente ad esso per 200-300 anni. Nella seconda metà della repubblica, il matrimonio sine manu diventa predominante e, nell'era dei giuristi classici, l'unico tipo di matrimonio. In tempi successivi si concludeva con un semplice accordo tra i coniugi, dopo il quale la moglie si trasferiva nella casa del marito. La differenza tra un matrimonio sine manu e un concubinato è che è stato concluso con l'intenzione di fondare una famiglia e allevare figli. Prima che i matrimoni in chiesa fossero introdotti da Leone Filosofo nella Novella 89, a volte era difficile dimostrare che un matrimonio fosse avvenuto. Le leggi di Teodosio II e Valentiniano III stabilivano che se persone di pari status sociale entrano in convivenza, in caso di dubbio si presume che abbiano contratto matrimonio. Principali caratteristiche del sistema familiare. L'ordinamento giuridico della famiglia romana è uno degli istituti giuridici romani specifici. Solo un cittadino romano poteva contrarre un matrimonio romano e fondare una famiglia romana. I tratti principali del sistema familiare furono espressi nel diritto romano con eccezionale completezza e coerenza, e i loro cambiamenti segnarono profondi cambiamenti sia nelle condizioni economiche di Roma che nell'ideologia delle sue classi dirigenti. L'ambito del diritto di famiglia a Roma inizia quindi con la famiglia monogama, che si fondava sull'autorità del capofamiglia e del padrone di casa (paterfamilias). Tutti i membri di una tale famiglia sono soggetti all'autorità di uno. Si tratta di una famiglia agnatica, che comprendeva, oltre al capofamiglia: la moglie (in manu mariti), cioè subordinata al potere del marito, i figli (in patria potestate), mogli dei figli, sposati cum manu e non subordinavano al loro potere i mariti, che a loro volta erano soggetti al capofamiglia, e al potere di quest'ultimo, e, infine, tutta la discendenza dei figli soggetti: nipoti, pronipoti, ecc. Tutti i membri della famiglia erano soggetti al capofamiglia erano chiamati sui. In tale famiglia, solo il capofamiglia era una persona pienamente capace (persona sui iuris), mentre il resto della famiglia non aveva piena capacità giuridica (personae alieni iuris). Da qui l'espressione: la moglie è loco filiae rispetto al marito, la madre è loco sororis rispetto ai figli, ecc. Figli e nipoti non ricevono la libertà dalla subordinazione all'autorità paterna, anche se ricevono la posto di magistrato. Neppure l’età dei subordinati esonera il capofamiglia dal potere. Termina solo con la morte o per volontà del capofamiglia. Il concetto di parentela agnatica e cognatica. Nel diritto romano si distinguevano due tipi di parentela. 1. Rapporto agnatico. La sottomissione all'autorità del capofamiglia determinava la parentela agnatica, sulla base della quale venne fondata la famiglia romana. La figlia del pater familias, che si sposava, passava sotto l'autorità del nuovo capofamiglia. Divenne una parente agnatica della nuova famiglia e cessò di essere una parente agnatica di suo padre e dei membri della sua precedente famiglia. “Coloro che sono legati da parentela legale si chiamano agnati. È rapporto giuridico quello che si forma attraverso persone di sesso maschile» (Gai. Inst. 3, 10). La parentela agnatica poteva essere stretta o lontana. I parenti stretti erano considerati persone sotto l'autorità di un certo capofamiglia. I parenti agnatici lontani sono persone che una volta erano sotto la sua autorità. Con lo sviluppo dell'economia, la trasformazione di Roma da società di produttori in società di consumatori, il potere del capofamiglia cominciò ad assumere confini più definiti; la parentela di sangue (parentela cognatica) divenne sempre più importante. 2. Parentela cognatica. I parenti cognatici sono individui che condividono almeno un antenato comune. I parenti di sangue sono: a) parenti diretti o collaterali: I parenti in linea diretta (linea recta) sono persone che discendono l'una dall'altra (nonno, padre, figlio). Una linea retta può essere ascendente (linea ascedens) o discendente (linea descedens), a seconda che sia tracciata dal discendente all'antenato o dall'antenato al discendente; Parenti laterali (linea collaterales) - persone che hanno un antenato comune, ma non sono imparentate in linea diretta (fratelli, sorelle, cugini, nipoti, ecc.); b) parenti coniugali (legittimi) e illegittimi (disprezzare); c) parenti consanguinei o consanguinei: I parenti a pieno titolo (germani) discendono dagli stessi antenati; I semiparenti (consanguinei e uterini) provengono dallo stesso padre e da madri diverse (consanguinei), o viceversa, dalla stessa madre e da padri diversi (uterini). L'affinità (affinitas) è la relazione tra il coniuge e i parenti cognati del secondo coniuge (ad esempio, l'affinità era tra il marito e i parenti cognati della moglie). Il grado di parentela è stato calcolato dal numero di nascite in base al quale le persone confrontate sono separate l'una dall'altra: in linea retta - il numero di nascite direttamente tra queste persone in modo ascendente o discendente, e in linea laterale - il numero delle nascite da un antenato comune. Il grado di proprietà è stato calcolato allo stesso modo del rapporto di parentela del coniuge (ad esempio, il marito è parente di 1° grado del suocero in linea diretta). La storia romana ha attraversato lo sviluppo delle famiglie dalla parentela agnatica a quella cognatica: Il consorzio fu il primissimo tipo di famiglia: una comunità familiare basata sulla parentela agnatica e nata dopo la disgregazione del clan in gruppi separati. La comunità era guidata da un anziano; gli uomini adulti decidevano il destino della comunità in un'assemblea generale; La famiglia patriarcale (familia) sostituì il consorzio; La famiglia cognatica è comparsa più tardi con il miglioramento dello status giuridico delle persone prive di piena capacità giuridica (alieni iuris). La famiglia cognatica era un'unione di parenti stretti, solo consanguinei che vivevano insieme. Una famiglia cognatica era solitamente composta dal capofamiglia con la moglie, i figli e altri parenti stretti. Il potere del capofamiglia non era più illimitato e si riduceva a una punizione prudente (“ad modicam castigationem”). Con l'avvento della famiglia cognatica si cominciò a riconoscere che anche gli schiavi potevano avere legami familiari (cognatio servilis); questa situazione era nuova per i romani. Con una famiglia patriarcale sviluppata, quando gli schiavi erano solo uno “strumento parlante”, gli schiavi potevano solo convivere e i loro legami familiari non erano riconosciuti. La coerente limitazione del potere del capofamiglia in tutte le sue manifestazioni: nei confronti della moglie, dei figli e della loro progenie e il parallelo graduale spostamento della parentela agnatica dalla parentela cognatica costituiscono il contenuto principale dello sviluppo del diritto di famiglia romano. Questo sviluppo si è realizzato sulla base di profondi cambiamenti nella vita economica di Roma, sotto l'influenza del corso della sua storia politica, contemporaneamente ad un consistente cambiamento delle forme di proprietà e alla liberazione del diritto contrattuale dal suo formalismo originario. 4.2. Matrimonio e rapporti familiari Il concetto e le forme del matrimonio. Il avvocato romano Modestino (III secolo dC) definì il matrimonio come l'unione del marito e della moglie, l'unione di tutta la vita, la comunità della legge divina e umana (d. 23.2.1). Questa definizione, tuttavia, non corrispondeva alla situazione reale. Il fatto è che la prima forma di matrimonio a Roma era un matrimonio chiamato cum manu, un matrimonio che stabiliva il potere del marito sulla moglie. Avendo contratto un tale matrimonio, una donna cadeva sotto il potere di suo marito o del suo signore e diventava un agnato nella casa di suo marito. Tuttavia già nell’antichità una donna poteva sottrarsi al potere del marito. Per fare questo, ha dovuto contrarre matrimonio senza osservare alcuna formalità (sine manu), un matrimonio che non ha dato origine al potere del marito sulla moglie. Se entro un anno dalla conclusione di un tale matrimonio una donna trascorreva tre notti di seguito fuori dalla casa di suo marito, non diventava un agnello in casa di suo marito. Questa procedura potrebbe essere ripetuta ogni anno. Se la moglie non usciva di casa, cadeva sotto l'autorità del marito e il matrimonio si trasformava in matrimonio con l'autorità del marito (cum manu). Il matrimonio sine manu è una forma di matrimonio basata sull'uguaglianza dei coniugi, sull'indipendenza della moglie dal marito. La moglie era la padrona di casa e la madre dei bambini. Le restanti questioni erano di responsabilità del marito. Presumibilmente nel secondo periodo della Repubblica questa forma di matrimonio sostituì cum manu e divenne predominante. Nel I secolo AVANTI CRISTO e. apparve una forma speciale di matrimonio: il concubinato. Si tratta della convivenza permanente di due persone, nessuna delle quali è stata sposata, allo scopo di creare una comunità vitale. Sotto il concubinato, i diritti dei bambini e della concubina stessa erano limitati. Pertanto, i figli nati da una concubina non erano considerati legittimi e quindi avevano diritti di eredità limitati. Condizioni per il matrimonio. Per consumare un matrimonio con i relativi effetti giuridici era necessario che i coniugi soddisfacessero determinate condizioni. Alcune di queste condizioni erano assolute e dovevano essere presenti per la conclusione di qualsiasi matrimonio romano. Altri hanno praticamente svolto il ruolo di condizioni relative, la cui presenza era necessaria per il matrimonio tra persone appartenenti a diversi gruppi sociali. La prima condizione per il matrimonio era il raggiungimento dell'età da marito, che, in coincidenza con la maggiore età, dopo alcune oscillazioni veniva fissata a 14 anni per gli uomini e a 12 anni per le donne. La seconda condizione era il consenso al matrimonio. Nei tempi antichi questo era il consenso del solo padrone di casa. Lo sposo esprimeva la sua volontà se aveva piena capacità giuridica; una sposa legalmente capace necessitava del consenso di un tutore (auctoritas tutoris). Tuttavia, gradualmente è emersa una visione diversa: per sposare una persona non pienamente capace, bisogna prima avere il suo consenso e, insieme ad esso, il consenso del capofamiglia della sposa e il consenso di entrambi i capi della famiglia dello sposo e della persona sotto la cui potestà paterna lo sposo può finire con la morte dei capofamiglia. Pertanto, il consenso al matrimonio di un nipote viene dato non solo dal suo capofamiglia - il nonno, ma anche dal padre, subordinato all'autorità dello stesso nonno, poiché dopo la morte del nonno il nipote sarà sotto l'autorità del padre, al quale il figlio non ha diritto di imporre eredi, i futuri figli nati dal matrimonio. Al contrario, la nipote, contraendo matrimonio, non solo non impone eredi al nonno e al padre, ma lei stessa cessa di essere il loro erede, unendosi alla famiglia agnatica del marito. Il capofamiglia dà il consenso alla sposa a lasciare l'antica famiglia agnatica. Pertanto, inizialmente, tutte le disposizioni relative al consenso al matrimonio procedevano dalla stessa idea di potere su cui poggiava la famiglia agnatica in generale. Il padre ha dato il consenso al matrimonio dei suoi figli non perché fosse lui il padre, ma perché era il capofamiglia, portatore dell'autorità paterna. Ma man mano che la personalità dei figli comincia ad emanciparsi dal potere, un tempo illimitato, del capofamiglia, gli interessi e la volontà dei figli cominciano ad essere sempre più presi in considerazione nella questione del consenso del padrone di casa al matrimonio. Così, la legge di Giulio (4 dC) riconosceva ai discendenti il diritto di ricorrere al magistrato contro il rifiuto ingiustificato del capofamiglia di acconsentire al matrimonio. Quindi i bambini potevano sposarsi senza il suo consenso se fosse stato catturato o disperso. Vi sono stati casi in cui il consenso al matrimonio veniva chiesto non al parente agnatico, ma ai consanguinei: una donna che, essendo sotto tutela, poteva sposarsi solo dopo aver ricevuto il consenso del tutore (auctoritas tutoris), dopo la cessazione della tutela su le donne erano obbligate a chiedere il permesso di sposarsi al padre e, in assenza del padre, alla madre o ad altri parenti stretti. La terza condizione per contrarre un matrimonio romano è che i coniugi abbiano il diritto di contrarre un matrimonio legale. Gli ostacoli al matrimonio in assenza di questa condizione potevano derivare sia dall'appartenenza degli sposi a diversi strati della società (classi successive), sia da legami familiari tra loro o talvolta da altri rapporti che esistevano tra loro. Quindi, innanzitutto, la Legge di Canulio (445 aC) non consentiva matrimoni tra patrizi e plebei. Prima della prima legge matrimoniale di Augusto, la Legge di Giulio (18 a.C.), non erano consentiti i matrimoni di liberti con nati liberi, e dopo la Legge di Giulio - con persone della classe senatoriale. Inoltre, la parentela, sia agnatica che cognatica, serviva da ostacolo al matrimonio: in linea retta senza limitazione di gradi, in linee laterali - nell'antichità, apparentemente fino al sesto grado; dopo l'abolizione di questa regola e fino alla fine della repubblica - tra persone le cui madri erano sorelle (consobrini), e i cui padri erano fratelli; infine, durante il periodo dell'impero, solo tra persone, di cui almeno una discendente del primo grado di un antenato comune per entrambi, ad esempio tra zio e nipote, zia e nipote, ecc. Decreti imperiali più di una volta fatto eccezioni a questa regola generale. Durante il periodo dell'Impero la proprietà in linea diretta divenne un ostacolo anche al matrimonio senza limiti di grado, e sotto gli imperatori cristiani anche nelle linee laterali tra genero e cognata. Inoltre, erano vietati i matrimoni tra il tutore e il tutore, il sovrano della provincia e i residenti di quest'ultimo. La legge giuliana vietava i matrimoni tra il coniuge adultero e il suo complice. Modi per sposarsi. Il matrimonio è stato preceduto dal fidanzamento. Anticamente veniva eseguita dagli sposi con il consenso dei capifamiglia. Il fidanzamento avvenne sotto forma di mancipazione. In un secondo momento ciò si è svolto senza osservare le formalità. La parte che ha violato l'accordo di fidanzamento ha perso il diritto ai doni da essa trasferiti all'altra parte e ha anche restituito ciò che ha ricevuto dalla parte. A Roma il matrimonio veniva celebrato in tre modi: 1) eseguendo una cerimonia religiosa; 2) acquistando la sposa dallo sposo; 3) per semplice accordo delle parti. I primi due modi di sposarsi davano origine al “matrimonio vero e proprio”, un matrimonio con autorità maschile (cum manu). La terza modalità di matrimonio portava all’istituzione di un “matrimonio sbagliato”, un matrimonio senza autorità maschile (sine manu). Il rito religioso (confarreatio) si svolgeva nelle famiglie patrizie benestanti. Questo metodo era una cerimonia magnifica, accompagnata dal consumo di focacce (pane) e dal portare cibo in favore di Giove. La cerimonia si è svolta alla presenza di un sacerdote e di 10 testimoni. L'acquisto della sposa da parte dello sposo (coemptio) avveniva sotto forma di mancipazione, che veniva effettuata dal padrone di casa. Avvenne alla presenza di cinque testimoni, di un pesatore con bilancia, ed fu accompagnato dall'enunciazione di alcune parole. Un semplice accordo tra le parti non richiedeva particolari formalità matrimoniali. Il matrimonio si considerava concluso con la conduzione della sposa a casa dello sposo. Con questo metodo di matrimonio il potere del marito sulla moglie era stabilito da un anno di convivenza coniugale continuativa. Dote e dono prematrimoniale. Con l'avvento e la diffusione del matrimonio sine manu, nacque l'usanza di fare al marito un dono speciale al momento del matrimonio: una dote (dos). L'ammontare della dote veniva determinato dalla donna stessa (se era sui iuris), dal capofamiglia o da un terzo. Ciò che veniva ricevuto dal padre veniva chiamato “maturo” (dos profecticia), e ciò che veniva ricevuto da altre persone veniva chiamato dos adventicia. La dote consiste nel versare contributi di carattere patrimoniale sotto forma di beni mobili e immobili al fine di agevolare le prossime spese del marito legate alla vita familiare. La regolamentazione veniva effettuata mediante il diritto comune, ma in epoca successiva il padre poteva essere costretto a dare una dote se si rifiutava di farlo per impedire il matrimonio. La dote era così stabilita: La promessa di una dote sotto forma di stipulazione (promissio dotis). La persona che dona la dote dovrà in futuro trasferire la proprietà corrispondente al marito; Anche la promessa di una dote sotto forma di contratto verbale concluso in forma solenne (dictio dotis). Si differenzia dalla stipulazione nella forma: se durante la stipulazione deve esserci uno scambio di frasi, suona una domanda e risposta (Stai dando? Io do!), allora nella forma di un contratto verbale parla solo chi promette la dote - del capofamiglia, della donna stessa o del suo debitore, e non è richiesto alcuno scambio di domande e risposte. Per mantenere una promessa si poteva intentare un'azione legale se si trattava di denaro o, al contrario, se si trasferivano cose in dote; Non una promessa, ma un trasferimento diretto dei beni (datio dotis): poteva realizzarsi con qualsiasi atto del marito che entrasse in possesso della dote (mancipatio, traditio). Inizialmente si credeva che il marito avesse il controllo completo sulla dote. Tuttavia, nella Roma classica, per evitare matrimoni fittizi allo scopo di ottenere una dote, furono emanate leggi che limitavano i diritti del marito riguardo ai beni ricevuti. Ora la dote non passava sotto il controllo del marito. Poiché lo scopo della dote era quello di alleviare gli oneri del matrimonio (sustinere onera marimonii), il coniuge aveva solo il diritto di utilizzare i beni e di riceverne i frutti per soddisfare i bisogni familiari. Secondo la legge, al marito era vietato alienare beni fondiari senza il consenso della moglie, né gravarla con ipoteca (al tempo di Giustiniano era vietato alienare beni fondiari in Italia anche con il consenso della moglie). La disposizione dei beni mobili compresi nella dote era limitata all'atto di restituzione della dote in caso di eventuale divorzio. Per fare ciò, al momento del trasferimento della dote, veniva valutato il valore e, se il matrimonio veniva sciolto, era questo importo che l'ex marito della donna doveva restituire. Con il rafforzamento della legge pretoriale, fu emanato un decreto secondo cui la dote (o il suo valore) veniva restituita in tutti i casi di divorzio per colpa del marito. Regole per la restituzione della dote in caso di divorzio: In caso di morte della moglie, la dote “matura” veniva restituita al padre della donna (con detrazione 1
/ 5
parte della dote per ogni figlio nato da questo matrimonio), e la dote ricevuta da altre persone rimaneva al vedovo; Se il marito moriva, la dote veniva restituita alla donna o a suo padre. In caso di morte, il marito lasciava solitamente una dote attraverso la “dote del prelegato” (praelegatum dotis); In caso di divorzio per colpa della donna, la restituzione della dote era limitata. Il marito aveva il diritto di mantenere 1
/ 6
dote per ogni figlio, ma in generale non di più 1
/ 2
dote Se il divorzio è avvenuto a causa dell’infedeltà della donna, allora il 1
/ 6
dote, e se dovuto ad altri reati, allora 1
/ 8
; Se il matrimonio veniva sciolto per iniziativa del marito o per sua colpa, ciò che gli era stato donato gli veniva restituito. La donazione prematrimoniale (donatio ante nuptia) è un bene donato a una donna dal futuro marito prima del matrimonio. Il divieto di doni tra coniugi non si applicava ai doni prima del matrimonio, e al tempo dell’imperatore Giustiniano si diffuse l’usanza, presa in prestito dall’Oriente, di donare parte dei propri beni alla futura moglie. Di solito la dimensione del regalo prematrimoniale era 1
/ 2
dal costo della dote. Tuttavia, il regalo di nozze divenne proprietà della moglie solo fittiziamente. La proprietà donata manteneva il controllo del marito e serviva agli stessi scopi del matrimonio come dote. Se il marito moriva, il dono prematrimoniale veniva ereditato dai figli, ma la moglie poteva continuare ad utilizzarlo e ricevere i frutti della proprietà. Se il divorzio avveniva per iniziativa o colpa del marito, il dono prematrimoniale veniva dato alla donna insieme alla dote. Pertanto, il dono prematrimoniale era una sorta di garante e di risarcimento in caso di divorzio. Sotto Giustiniano il valore del dono prematrimoniale fu equiparato al valore della dote e cominciò ad applicarsi la regola secondo cui l'entità del dono poteva essere aumentata durante il matrimonio (donatio propria nuptias), nonostante il divieto esistente di donazioni durante il matrimonio. Divorzio e sue tipologie. Il matrimonio romano fu sciolto per diversi motivi. 1. Morte di uno dei coniugi. In caso di morte naturale della moglie, gli uomini potevano contrarre immediatamente un nuovo matrimonio. Per le donne veniva stabilito un periodo di lutto (tempus lugendi), durante il quale la donna non poteva sposarsi. 2. Perdita della libertà (capitus deminutio maxima) da parte di uno dei coniugi, cioè trasformazione di lui in schiavitù. Poiché è possibile solo la convivenza con uno schiavo e il matrimonio è impossibile, il matrimonio legale è stato considerato sciolto. Se la perdita della libertà fosse avvenuta a causa della cattura del marito, la donna non avrebbe più potuto sposarsi, poiché il marito avrebbe potuto tornare. Al tempo di Giustiniano il periodo di attesa per il ritorno del marito dalla prigionia era limitato a cinque anni. 3. Perdita della cittadinanza (capitus deminutio media) da parte di uno dei coniugi. Il matrimonio continuava ad essere considerato valido solo secondo il diritto naturale. 4. Compromissione della capacità giuridica civile sotto forma di incesto (incestum superveniens). Se, a seguito dell'adozione, i coniugi diventavano parenti agnatici, tra i quali il matrimonio era impossibile, il loro matrimonio veniva sciolto. Ad esempio, se il capofamiglia di una figlia adottava un genero, questi diventava, per così dire, il fratello di sua moglie. Ciò avrebbe potuto essere evitato solo rendendo la figlia legalmente competente. 5. La volontà del capofamiglia. In un matrimonio sine manu, in cui la donna rimaneva sotto l'autorità del padre, il capofamiglia poteva reclamare la donna, privandola così della possibilità di vivere una vita insieme. Nei matrimoni tra persone non pienamente capaci legalmente, qualunque capofamiglia poteva, a suo piacimento, sciogliere il matrimonio, dichiarandolo convivenza. 6. Divorzio. Nell'antica Roma solo un uomo poteva avviare un divorzio. Un matrimonio potrebbe essere sciolto se una donna si comportasse in modo inappropriato: ubriachezza, infedeltà, infertilità e persino aborto spontaneo. Il divorzio in quanto tale (divortium) si diffuse ampiamente con la crescente popolarità dei matrimoni sine manu. Il divorzio divenne possibile sia per volontà del marito (repudium) che per volontà della moglie, nonché per mutuo consenso dei coniugi. 7. Nomina a senatore del marito della liberta. Questo motivo di divorzio fu abolito al tempo di Giustiniano. Le forme di divorzio erano l'annuncio del divorzio davanti a testimoni (in epoca di Augusto il numero dei testimoni era fissato a sette persone), un accordo scritto e l'effettiva cessazione della convivenza. A partire dall’epoca post-classica, con l’introduzione della morale cristiana, sono stati posti severi divieti al divorzio. Sono emersi i seguenti tipi di divorzi: 1) divorzio con conseguenze negative (divorium cum Damno): Per colpa di uno dei coniugi (repudium ex iusta causa) (adulterio, reato grave, stile di vita immorale); Senza colpa del coniuge (repudium sine ulla causa), cioè divorzio unilaterale errato. Un simile divorzio era punibile con sanzioni severe: dalla confisca della dote all'espulsione, ma il matrimonio era considerato sciolto; 2) divorzio senza conseguenze (divorium sine Damno): Divorzio consensuale dei coniugi (divortium communi consensu); Divorzio per volontà di uno dei coniugi (divortium bona gratia). Questo tipo di acqua era possibile solo per una buona ragione: impotenza, ingresso in monastero, ecc. 4.3. Rapporti giuridici tra genitori e figli Rapporti tra madre e figli. Il rapporto tra madre e figli differiva a seconda che la madre fosse sposata cum manu o sine manu con il padre dei figli. La madre sposata cum manu è madre dei figli (loco sororis) e, insieme ad essi, è soggetta all'autorità del marito (o del capofamiglia, se il marito è sotto l'autorità del capofamiglia). ella eredita, in parità con i figli, dopo il marito; il reciproco diritto di eredità la unisce come figli agnatici a quelli di loro provenienti dalla patria potestas del marito. In quanto agnati, i suoi figli esercitano la tutela su di lei dopo la morte del marito. Dopo il legame tra il capofamiglia e i suoi subordinati, il legame tra madre e figli era il più stretto. Nel matrimonio sine manu era vero il contrario: la madre non era legalmente legata ai figli. Lei rimane un agnata dei suoi vecchi agnati, cioè è un membro della sua vecchia famiglia, da cui eredita e i cui membri ereditano dopo di lei. In un tale matrimonio, la madre non è un membro della famiglia dei suoi figli. Tuttavia, così come l'alienazione giuridica del marito e della moglie nel matrimonio sine manu è stata molto attenuata nel tempo, così è stata quasi eliminata nel rapporto tra madre e figli nati da un matrimonio sine manu. Il legame di sangue cognativo cominciò gradualmente a servire come base per il diritto della madre di convivere con i suoi figli minorenni che erano sotto la tutela di un estraneo o addirittura sotto l'autorità di un marito da cui la madre era divorziata, e più tardi anche per il diritto madre ad esercitare la tutela. Alla madre veniva concesso il diritto al mantenimento dei figli, ai figli era vietato citare in giudizio la madre, portarla in tribunale senza il permesso del magistrato e limitare la portata della sua responsabilità patrimoniale ai figli. Infine, le Consultazioni del Senato del II secolo, e poi le Costituzioni Imperiali, stabilirono e successivamente ampliarono i reciproci diritti di eredità dei figli e delle madri sposati sine manu, consentiti dal pretore. Rapporto tra padre e figli. Il rapporto tra padri e figli è stato costruito diversamente. Per questo rapporto era indifferente se il padre fosse sposato cum manu o sine manu. I figli sono sempre sotto l'autorità del padre, in patria potestate. Inizialmente, questo potere era illimitato, ma a causa dello sviluppo della schiavitù, del crollo dell'ex famiglia contadina e dello sviluppo dell'artigianato nelle città, il potere dei padri sui figli cominciò ad attenuarsi. I figli iniziarono sempre più a gestire famiglie indipendenti. Allo stesso tempo, i figli acquisiscono una posizione indipendente nell'esercito permanente e nell'apparato statale. Già nell'antichità il potere del paterfamilias sulla personalità dei figli era moderato dall'influenza del consiglio di famiglia, i cui giudizi non erano giuridicamente vincolanti, ma non potevano, secondo l'opinione pubblica, essere ignorati quando venivano inflitte severe punizioni. imposto ai bambini. Alla fine della repubblica e all'inizio dell'impero furono introdotte una serie di restrizioni dirette ai diritti del paterfamilias sulla personalità dei bambini. Il diritto di vendere bambini era limitato ai casi di estrema necessità e si applicava solo ai neonati. Il diritto di buttare via i bambini è stato abolito. Decreto imperiale del IV secolo. equiparava l'omicidio di suo figlio a qualsiasi omicidio di parenti prossimi. Secondo un altro decreto precedente (II secolo d.C.), le autorità potevano costringere il padre a liberare il figlio dalla patria potestas. Infine, veniva riconosciuto il diritto dei figli a carico di ricorrere al magistrato extra ordinem per denunce contro il paterfamilias, nonché il diritto di esigere gli alimenti. Nell'ambito dei rapporti patrimoniali, sembra che i figli a carico siano stati presto autorizzati ad effettuare transazioni per proprio conto. Ma tutti i diritti derivanti da tali transazioni (così come dalle transazioni di schiavi effettuate ex persona domini) spettavano al paterfamilias. Da queste transazioni non nascevano obblighi per il paterfamilias. Gli illeciti commessi dai sudditi servivano da base per actiones noxales contro il paterfamilias per il risarcimento del danno o per l'estradizione del soggetto alla vittima per risarcire il danno arrecatogli. Contemporaneamente alla conseguente limitazione del potere del marito sulla moglie, da un lato, e parallelamente all'ampliamento della gamma delle conseguenze giuridiche derivanti dal commercio degli schiavi, dall'altro, si avvia il processo di graduale riconoscimento dei diritti di proprietà e di è stata esercitata la capacità giuridica dei figli a carico. Il pretore cominciò a prevedere nei confronti del paterfamilias le stesse actiones adiecticiae qualitatis dalle transazioni dei subordinati, che prevedeva sulla base delle transazioni degli schiavi. Ma i soggetti stessi, dopo essere diventati giuridicamente capaci, cominciarono ad essere riconosciuti come responsabili di queste transazioni non dal diritto naturale, come gli schiavi, ma dal diritto civile. Allo stesso tempo, se il peculium, che spesso veniva assegnato al figlio soggetto, continuava ad essere riconosciuto come proprietà del capofamiglia (peculium profecticium), allora apparivano alcuni gruppi di proprietà, i cui diritti cominciavano a sorgere non nella persona del paterfamilias, ma nella persona del figlio soggetto. Sotto l'influenza della creazione di un esercito professionale permanente, il bottino militare era riconosciuto come tale proprietà, così come tutte le proprietà acquisite dal figlio in relazione al servizio militare: il proprietario non aveva il diritto di prendere questa proprietà da suo figlio , il figlio non solo utilizzava liberamente questa proprietà, ma aveva il diritto di disporne, in particolare di fare testamento (prima durante il servizio militare, e a partire dal II secolo d.C., indipendentemente dal momento della redazione del testamento). Tuttavia, se il figlio muore senza testamento, questi beni passano al padre senza gravare su quest'ultimo gli obblighi del figlio defunto. Le regole che si svilupparono durante il periodo del principato per i beni acquisiti da un figlio in servizio militare furono, durante il periodo imperiale, in connessione con la creazione di un vasto apparato amministrativo del principe, trasferite ai beni acquisiti nel servizio civile: stato, incarichi giudiziari o ecclesiastici. Quindi, dal IV secolo. N. e. si sviluppò gradualmente un peculio militare, quando la proprietà fu a completa disposizione del figlio. Dopo la morte della madre, sposata sine manu, i figli ricevettero il diritto all'eredità, ma rimasero pretese da parte del proprietario. Solo nel IV secolo. N. e. è stato dichiarato che la proprietà apparteneva ai figli e il capofamiglia ha ricevuto il diritto di utilizzarla e gestirla per tutta la vita. Successivamente, i beni ereditati dai parenti per parte materna furono costantemente collocati nella stessa posizione. L'evoluzione è stata completata dalla sentenza che il proprietario conserva la proprietà solo dei beni in possesso dei figli che sono stati acquisiti (ex re patris) a spese del padre, o ricevuti (contemplatione patris) da un terzo che volesse creare un certo vantaggio per il capofamiglia, nonché sui beni che il padre ha trasferito ai suoi dipendenti, volendo darli in dono, ma che sono rimasti di proprietà del padre a causa dell'invalidità dei negozi tra lui e lui i figli a carico. Tutti gli altri beni appartengono al soggetto, che ha il diritto di disporne durante la sua vita e solo non ha il diritto di lasciare in eredità questi beni, che passano dopo la morte del soggetto al padre, gravando sul padre le responsabilità incluse in questa proprietà. Cessazione del potere del capofamiglia (patria potestas). Come già accennato, il potere nella famiglia era permanente e normalmente terminava con la morte del capofamiglia. Durante la sua vita e indipendentemente dalla sua volontà, cessò solo con l'acquisizione da parte del figlio del titolo di flamen dialis (la carica di supremo piumino, al quale venivano trasferiti gli aspetti sacri del potere reale), e da parte di sua figlia - la titolo di vestale (le vergini vestali mantenevano il fuoco sacro, conducevano uno stile di vita casto, facevano voto di innocenza, non avevano difetti fisici). Nella successiva epoca imperiale, il potere del capofamiglia cessò con l'acquisizione da parte del figlio del grado di console, comandante in capo o vescovo. Ma il capofamiglia poteva egli stesso porre fine al suo potere sul figlio o sulla figlia mediante l'emancipazione (emancipatio). Una forma di emancipazione fu il ricorso alla norma delle Leggi delle XII Tavole, secondo la quale la mancipazione di un suddito per tre volte pone fine all'autorità paterna: il capofamiglia per tre volte mancipava il soggetto a una persona di fiducia, che per tre volte rilasciava soggetto alla libertà. Dopo le prime due volte il soggetto ritornava sotto l'autorità del capofamiglia, dopo la terza diventava legalmente capace. Nel VI secolo. N. e. non c'era più bisogno di queste formalità. Dopo l'emancipazione, il padre conservava il diritto di utilizzare la metà dei beni del figlio. La situazione dei figli legittimi e illegittimi. I figli erano considerati legittimi (iusti): Quelli nati con matrimonio legale (iustae nuptiae) dalla propria moglie non prima di 180 giorni dalla data di inizio del matrimonio; Nato entro e non oltre 300 giorni dalla cessazione del matrimonio legale. Se le condizioni di cui sopra erano soddisfatte, i figli erano considerati agnati della loro famiglia e cadevano sotto l'autorità del padre. I figli erano considerati illegittimi (iniusti naturales): Nato in un matrimonio illegale valido solo secondo il diritto delle nazioni; Figli nati in concubinato (liberi naturales); Figli illegittimi (vulgo quaesiti). Da unioni non riconosciute dalla legge o addirittura vietate nascevano figli illegittimi. Tutti i figli naturali non sono legalmente imparentati con il padre ma sono imparentati (cognaticamente) con la madre e i suoi parenti. Se la loro madre era una persona dotata di capacità giuridica, anche loro sarebbero nati dotati di capacità giuridica. Se la loro madre non era una persona con piena capacità giuridica, la questione se questi bambini sarebbero stati inclusi nella famiglia dipendeva dal capofamiglia. Nel diritto classico, la situazione dei figli illegittimi e illegittimi migliora. Hanno diritto agli alimenti dalla madre e dai suoi parenti. Per quanto riguarda i figli nati in concubinato, gli alimenti potevano essere richiesti anche al padre (poiché era conosciuto durante il concubinato); potevano anche pretendere una quota nell'eredità paterna, ma solo se questi non aveva altri figli legittimi. Legalizzazione. La legalizzazione (legittimatio) ha ricevuto il suo sviluppo nell'era di Giustiniano. Attraverso la legittimazione, un figlio naturale potrebbe ricevere uno status giuridico. Tuttavia solo il figlio nato dalla convivenza poteva essere legittimato. C'erano diversi modi di legalizzazione: - “mediante una donazione alla curia” (legittimo per oblationem curiae). Questo metodo implicava che il capofamiglia pagasse una somma sufficiente affinché il figlio (nel caso di una figlia, suo marito) entrasse nella posizione di decurione (ordo decurionum). Questa posizione non era molto popolare, poiché i decurioni erano responsabili della riscossione delle tasse e del loro invio al tesoro. Doveva essere garantita la ricezione di un importo fisso indipendentemente da quanto effettivamente incassato; Matrimonio dei genitori dopo la nascita di un figlio (legittimo per subsequens matrimonium); Emettendo un decreto speciale per l'imperatore (legittimo per rescriptum principis). A questo si potrebbe ricorrere qualora il matrimonio fosse impossibile per validi motivi, ad esempio in caso di morte della madre. Tutela e tutela. La tutela e l'amministrazione fiduciaria è un istituto giuridico che serve a compensare la capacità giuridica mancante o limitata di una persona attraverso le azioni di altre persone, nominate o elette - tutori o fiduciari. Le persone venivano poste sotto tutela per motivi di salute, età, spendaccioni, donne e pazzi. La differenza tra tutela e amministrazione fiduciaria è stata espressa nell'ordine di attività del tutore e del curatore. Nei tempi antichi, la tutela non era istituita nell'interesse del rione, ma nell'interesse delle persone che erano i suoi eredi più prossimi per legge. Il suo compito principale era proteggere la proprietà del rione nell'interesse dei suoi eredi. Pertanto, la procedura per la richiesta della tutela (se nel testamento non era nominato un tutore) coincideva con la procedura per la richiesta dell'eredità, cioè il tutore era l'affine più vicino del tutore. Nell'antichità la tutela non era responsabilità del tutore, ma un suo diritto, o più precisamente, il potere del tutore sui beni e sulla persona del tutore, simile nel contenuto al potere del capofamiglia. Tuttavia, gradualmente i diritti del tutore cominciano ad essere intesi come un mezzo per svolgere i suoi doveri. Questi cambiamenti, strettamente legati al progressivo indebolimento dei legami clanici, trasformano progressivamente il concetto di tutela come potere nel concetto di tutela come servizio pubblico (munus publicum). A questo proposito, insieme alle due procedure sopra menzionate per l'istituzione della tutela (a causa del rapporto agnatico con il tutore e secondo la volontà del capofamiglia), si pone un terzo ordine: la nomina di un tutore da parte dello Stato. Allo stesso tempo, si è gradualmente sviluppato il controllo statale sulle attività dei tutori. Sono stabiliti particolari motivi (excusationes) per i quali la nomina di un tutore non può essere accettata. Si sta sviluppando un sistema di rivendicazioni contro il tutore in caso di mancata relazione sullo svolgimento degli affari del reparto e in caso non solo di appropriazione indebita, ma anche di condotta negligente degli affari. Poi divenne consuetudine richiedere al tutore una garanzia al momento dell'assunzione dell'ufficio (satisdatio rem pupilli salvam fore), e durante il periodo dell'impero fu introdotta un'ipoteca legale del tutore su tutti i beni del tutore.
 Una parte importante della tradizione della prima Roma sono le leggi reali. Come abbiamo già notato, ora, al posto della completa negazione della loro storicità da parte degli ipercritici della scienza, si afferma nei loro confronti un atteggiamento fondamentalmente affidabile, almeno in quanto risalenti a istituzioni autentiche.
Una parte importante della tradizione della prima Roma sono le leggi reali. Come abbiamo già notato, ora, al posto della completa negazione della loro storicità da parte degli ipercritici della scienza, si afferma nei loro confronti un atteggiamento fondamentalmente affidabile, almeno in quanto risalenti a istituzioni autentiche.