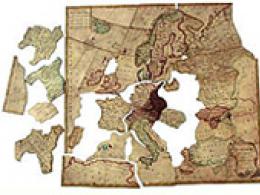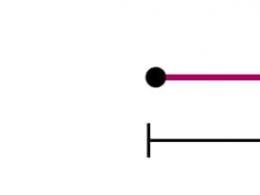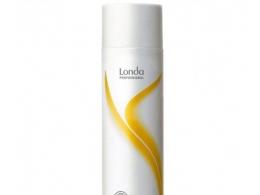Caratteristiche legate all'età dello sviluppo della sfera emotivo-volitiva. Caratteristiche della sfera emotiva di un bambino in età prescolare
Inviare il tuo buon lavoro nella knowledge base è semplice. Utilizza il modulo sottostante
Studenti, dottorandi, giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenze nei loro studi e nel loro lavoro ti saranno molto grati.
Pubblicato su http://www.allbest.ru
INTRODUZIONE
1. CARATTERISTICHE DELLO SVILUPPO DELLA SFERA EMOZIONALE DEI PRIMI BAMBINI
1.1.2 Teorie dell'emozione
1.2.2 Tendenze generali cambiamenti legati all’età sfera emotiva bambini
1.2.3 Caratteristiche dello sviluppo emotivo dei bambini piccoli
1.2.4 Caratteristiche dell'età sfera emotiva dei bambini di 2-3 anni
CONCLUSIONE
BIBLIOGRAFIA
INTRODUZIONE
La prima infanzia è un periodo di intenso sviluppo fisico e mentale. Le trasformazioni qualitative che un bambino subisce nei primi tre anni sono così significative che molti psicologi, pensando a dove si trova la metà del percorso di sviluppo umano dalla nascita all'età adulta, vengono definiti tre anni.
Le emozioni svolgono un ruolo importante nella vita dei bambini, aiutandoli a percepire e rispondere alla realtà. I sentimenti dominano tutti gli aspetti della vita di un bambino in età prescolare, conferendo loro una colorazione ed espressività speciali, quindi le emozioni che sperimenta si leggono facilmente sul suo viso, nella postura, nei gesti e in ogni comportamento.
Il comportamento del bambino e lo sviluppo della sua sfera emotiva lo sono indicatore importante nella comprensione del mondo piccolo uomo e indica il suo stato mentale, il suo benessere e le possibili prospettive di sviluppo.
La rilevanza di questo lavoro sta nel fatto che non viene prestata sufficiente attenzione allo sviluppo della sfera emotiva del bambino. Ma uno dei problemi più importanti oggi è che i nostri figli non sono molto emotivi. L.S. Vygotsky ha scritto del fenomeno del “cuore inaridito”... quando sia la tecnologizzazione che la progmatizzazione della vita a cui il bambino partecipa contribuiscono alla “desensibilizzazione”. è vero ancora oggi. Disturbi nello sviluppo psico-emotivo e ritardi nella formazione delle emozioni nei bambini portano a un ritardo nello sviluppo generale, a comportamenti negativi persistenti e a uno sviluppo distorto dei sentimenti.
La conseguenza di tutto ciò è che è difficile per i bambini stabilire rapporti con la società circostante e il processo del loro ingresso in una nuova realtà diventa più complicato.
Attualmente nel nostro Paese cresce l’interesse per il problema della posizione dei bambini nella società. Come notato da A.I. Zakharov, “la società comincia a capire sempre di più che le sue basi affondano nell’infanzia e che la salute mentale è una delle acquisizioni più preziose”.
Diagnosi precoce l'identificazione del livello di sviluppo emotivo del bambino e un lavoro correttivo tempestivo aiutano a garantire che lo sviluppo deviante del bambino rispetto alle norme generalmente accettate possa essere corretto nelle fasi iniziali.
CAPITOLO 1. CARATTERISTICHE DELLO SVILUPPO DELLA SFERA EMOZIONALE DEI PRIMI BAMBINI
1.1 Caratteristiche generali delle emozioni
1.1.1 Il concetto di emozione. Meccanismi psicologici di formazione delle emozioni
Quando guardiamo l'alba, leggiamo un libro, ascoltiamo musica, cerchiamo una risposta a una domanda o sogniamo il futuro, quindi, insieme a varie forme di attività cognitiva, mostriamo il nostro atteggiamento nei confronti del mondo cognitivo.
Il libro che leggiamo o il lavoro che svolgiamo possono renderci felici o tristi, provocarci piacere o delusione. Gioia, tristezza, paura, paura, gioia, fastidio: questa è una vasta gamma di sentimenti ed emozioni che sorgono nel processo della cognizione e dell'attività umana e ne influenzano il corso.
In effetti, quasi ogni evento provoca una reazione emotiva in una persona: un'emozione o un sentimento.
Secondo T.A. Danilina, V.Ya. Zedgenidze, N.M. Stepin, il mondo dei sentimenti e delle emozioni è complesso e diversificato. Ricchezza esperienze emotive aiuta una persona a comprendere meglio cosa sta succedendo, a penetrare più sottilmente nelle esperienze di altre persone, nelle loro relazioni interpersonali, promuove la conoscenza di se stessa da parte di una persona, delle sue capacità, abilità, vantaggi e svantaggi, del mondo degli oggetti e dei fenomeni che lo circondano.
Le emozioni sono esperienze personali legate alla soddisfazione o insoddisfazione dei propri bisogni
RS Nemov ha dato una definizione di emozioni e la loro classificazione.
"Sotto le emozioni", ha osservato R.S. Nemov, si possono comprendere esperienze specifiche, colorate in toni piacevoli o spiacevoli e associate alla soddisfazione dei bisogni vitali dell'uomo...”
Come notato da S.L. Rubinstein, “le emozioni possono essere preliminarmente caratterizzate da diverse caratteristiche: in primo luogo, a differenza delle percezioni, che denotano il contenuto di un oggetto, le emozioni esprimono lo stato del soggetto e il suo atteggiamento verso l'oggetto; in secondo luogo, le emozioni di solito differiscono nella polarità; nei sentimenti umani complessi, interagiscono per formare un'unità complessa e contraddittoria (ambivalenza dei sentimenti); in terzo luogo, le emozioni hanno sempre un carattere che cattura l'intera persona, sono associate all'io personale.
È difficile tracciare un confine tra emozioni e sentimenti.
Di solito, le emozioni sono intese come esperienze più elementari e i sentimenti come formazioni olistiche complesse.
Le emozioni sono associate alla soddisfazione o insoddisfazione dei bisogni biologici e i sentimenti sono associati ai bisogni sociali dell'individuo.
In base all'intensità, alla durata e al grado di regolazione volitiva delle emozioni, queste si dividono in: umore, passioni e affetti.
L'umore è uno stato emotivo caratterizzato da durata e stabilità, positivo o esperienze negative, fungendo da sfondo per tutti gli altri elementi dell'attività mentale (gioia, malinconia).
La passione è uno stato emotivo, caratterizzato da durata e persistenza, che costituisce l'essenza della vita interiore di una persona in un determinato stadio.
L'affetto è uno stato emotivo, in rapido sviluppo e di breve durata, caratterizzato da azioni e azioni che non sono soggette al controllo volitivo (rabbia, disperazione, intorpidimento).
Per un lungo periodo gli psicologi si sono impegnati nella descrizione e classificazione delle emozioni. Come riassumendo quest'area di ricerca, W. James (1901) scrisse: “La varietà delle emozioni è infinitamente grande. La rabbia, la paura, l'amore, l'odio, la gioia, la tristezza, la vergogna, l'orgoglio e le varie sfumature di queste emozioni possono essere definite le forme più grossolane di emozioni, essendo strettamente associate a un'eccitazione corporea relativamente forte. Le emozioni più raffinate sono sentimenti morali, intellettuali ed estetici... Gli oggetti delle emozioni, le circostanze ad esse associate e i vari tipi di emozioni possono essere descritti all'infinito. Innumerevoli sfumature di ciascuno di essi si trasformano impercettibilmente l'una nell'altra e sono in parte notate nel linguaggio dei sinonimi, come odio, apatia, inimicizia, rabbia, antipatia... Il risultato di molti lavori è che la letteratura puramente descrittiva su questo tema, da Cartesio rappresenta fino ai nostri giorni il dipartimento più noioso della psicologia."
In un periodo successivo, un punto di vista simile fu espresso da L.S. Vygotskij.
Egli ha osservato: "...il percorso di definizioni e classificazioni che la psicologia ha seguito per diversi secoli ha portato al fatto che la psicologia dei sentimenti si è rivelata il più sterile e noioso di tutti i capitoli di questa scienza."
UN. Luk fornisce un elenco di 70 definizioni di emozioni e sentimenti, Kanner ne fornisce 365 parole inglesi associato alla designazione di diversi stati emotivi.
Questo non vuol dire che tali descrizioni e definizioni siano inutili. Da un lato indicano l'importanza delle emozioni e dei sentimenti nella vita umana, perché i concetti più importanti sono fissati nel linguaggio. D'altra parte, hanno portato alla formulazione del problema delle emozioni iniziali, di base, da cui si genera il resto della varietà di emozioni e sentimenti.
B. Spinoza ha individuato tre emozioni fondamentali: piacere, dispiacere e desiderio. V. Wundt ha identificato tre paia di diversi opposti come le principali forme di sentimenti: piacere - dispiacere, eccitazione - calma, tensione - rilascio. W. McDougall ha scritto che “ci sono due forme primarie e fondamentali di sentimento: piacere e dolore, o soddisfazione e insoddisfazione, che colorano e determinano in una certa misura, almeno insignificante, tutte le aspirazioni dell'organismo. Il piacere è la conseguenza del successo, sia totale che parziale, la sofferenza è la conseguenza e il segno del fallimento e della frustrazione.”
Considerando il problema dello sviluppo delle emozioni, Watson sostiene che un bambino ha tre emozioni innate: paura, rabbia e amore.
K. Izard identifica 10 emozioni fondamentali come primarie, che formano il sistema motivazionale di base dell'esistenza umana:
1) eccitazione dell'interesse;
2) gioia;
3) sorpresa;
4) sofferenza;
6) disgusto;
7) disprezzo;
Le emozioni sono fondamentali perché “ognuna di esse possiede:
a) uno specifico substrato nervoso determinato internamente;
b) complessi mnemonici o neuromuscolari caratteristici;
c) una diversa esperienza soggettiva o qualità fenomenologica”.
Consideriamo le emozioni di base elencate, tenendo conto del fatto che a determinate esperienze sono assegnate reazioni motorie caratteristiche. In ogni reazione o stato emotivo c'è sempre una componente motoria.
L'interesse è un atteggiamento selettivo di una persona verso un oggetto a causa del suo significato vitale e del suo fascino emotivo. Una persona sperimenta questa emozione positiva più spesso di altre emozioni. Nei primi mesi di vita di un bambino l’interesse è spontaneo e involontario e solo successivamente, essendosi approfondito, l’interesse può diventare un bisogno.
Gli interessi delle persone sono caratterizzati da un certo grado di costanza e forza. Un interesse forte e sostenuto incoraggia una persona a essere attiva e a superare gli ostacoli associati all’attività.
Un'espressione facciale di interesse durante la percezione visiva si manifesta nelle sopracciglia sollevate o leggermente aggrottate, spostando lo sguardo verso un oggetto, in una bocca leggermente aperta o increspando le labbra. Ciascuno di questi movimenti può avvenire da solo o in combinazione.
La gioia è una reazione al ricevere inaspettatamente qualcosa di piacevole e desiderato.
La gioia è poco soggetta all'influenza cosciente e non può essere il risultato di uno sforzo volontario.
La capacità di provare l'emozione della gioia è individuale e in parte determinata geneticamente. Alcune persone nascono con una soglia più alta per l'emozione della gioia, altre il contrario.
Quando è felice, il viso si apre con un sorriso: gli angoli delle labbra sono tirati verso l'alto e le rughe si accumulano intorno agli occhi. I bambini ridono di gioia, saltano, battono le mani, fanno vari movimenti senza scopo, che sono semplicemente una scarica di eccitazione motoria.
La risposta sorridente è innata, quindi la gioia può essere osservata fin dall'infanzia. I genitori divertono il bambino, incoraggiandolo ad una reazione di gioia.
Inducendo gioia in un bambino, puoi assicurarti che le emozioni si sviluppino e che la sua vita sia piena di esperienze gioiose.
La sorpresa è un’emozione a breve termine e molto vaga. La sorpresa è generata da un improvviso cambiamento di stimolazione ed è di breve durata. Le situazioni che provocano sorpresa provocano poi sentimenti negativi o positivi. Di solito si costruiscono le seguenti catene di emozioni: sorpresa - gioia - interesse o sorpresa - vergogna - paura.
L'espressione facciale quando sorpreso è la seguente: le sopracciglia sono sollevate in alto, a seguito delle quali si formano rughe sulla fronte e gli occhi si allargano e rotondi. La bocca leggermente aperta diventa ovale.
La bocca e gli occhi si aprono maggiormente, maggiore è il grado di sorpresa. Le osservazioni sull'espressione di sorpresa hanno mostrato che questo sentimento si esprime allo stesso modo. Qualsiasi emozione improvvisa, compresa la sorpresa, accelera l'attività del cuore e della respirazione.
Succede che gli europei esprimano l'emozione della sorpresa schioccando o schioccando la lingua contro il palato.
Una persona sorpresa spesso alza le braccia aperte sopra la testa, spesso con i palmi aperti rivolti verso la persona che ha causato la sensazione. Molto spesso puoi osservare il seguente gesto: una mano viene posizionata sulla bocca o su un'altra parte della testa.
L’angoscia si manifesta nella tristezza, nella sofferenza, nel dolore.
La base psicologica della tristezza sono le situazioni problematiche che si incontrano Vita di ogni giorno. La principale causa di tristezza è il sentimento di perdita che si prova in caso di morte o di separazione da una persona cara.
Le espressioni facciali di una persona rattristata assomigliano a questa: le estremità interne delle sopracciglia sono sollevate e avvicinate al ponte del naso, gli occhi sono leggermente socchiusi e gli angoli della bocca sono abbassati. L'espressione facciale può essere accompagnata da pianto o singhiozzo, ma ciò dipende dall'età della persona e dall'intensità della tristezza. L'espressione facciale può durare pochi secondi, ma l'esperienza può durare a lungo.
Le emozioni negative possono essere osservate già nei primi mesi di vita di un bambino. Il bambino lo comunica piangendo e facendo smorfie di dispiacere. Prendendosi cura del bambino in un momento simile, un adulto aiuta a ridurre il pianto. Un bambino può entrare in empatia con gli adulti che si prendono cura di lui molto presto ed è capace di imitare volontariamente uno stato d'animo triste già a 4 anni.
Disgusto. L'espressione "disgusto" nel suo senso più semplice ha a che fare con il cibo e significa qualcosa che ha un sapore disgustoso.
Nell'infanzia, la reazione di disgusto si verifica a causa del cibo amaro, avariato o dal sapore o odore sgradevoli. Man mano che una persona cresce, impara a provare disgusto per vari oggetti nel mondo che lo circonda e anche dall'età di 5 anni, disgusto per se stesso.
Le espressioni facciali di disgusto hanno vista successiva: sopracciglia aggrottate, naso rugoso, sollevato labbro superiore e quello inferiore, la lingua sporge leggermente.
Con l'età, una persona impara a controllare le proprie espressioni facciali, questo vale anche per la reazione di disgusto.
La rabbia è espressa in una persona dal fatto che il viso diventa rosso, le vene sul collo e sulla fronte si gonfiano e talvolta il viso diventa pallido o blu. La bocca è strettamente compressa, i denti sono serrati. I capelli si rizzano. Alcune persone aggrottano le sopracciglia, altre spalancano gli occhi. I muscoli sono tesi e la persona è pronta per un'azione immediata.
I gesti in uno stato di rabbia sono inutili, i movimenti sono scoordinati, la voce si interrompe. I bambini piccoli urlano, calciano, si rotolano sul pavimento o mordono qualsiasi cosa su cui riescono a mettere le mani.
Il livello più alto di rabbia è la rabbia. L'attività cardiaca aumenta bruscamente o viene interrotta. Il viso diventa rosso, viola o, al contrario, diventa pallido. La voce cambia. C'è tremore nel corpo. I gesti hanno la natura di un combattimento o di un attacco.
Il significato della rabbia è che mobilita l'energia di una persona, infonde un senso di fiducia, aumentando così la capacità di autodifesa.
Il disprezzo si esprime abbastanza bene attraverso il viso. Esprimendo disprezzo, una persona diventa più alta, si raddrizza, getta indietro la testa e guarda l'oggetto del suo disprezzo come da cima a fondo. Sul viso appare un sorriso o un ghigno ironico.
Il disprezzo può essere espresso ad alta voce quando c'è sarcasmo o un'intonazione beffarda nella voce.
L’emozione del disprezzo è associata a un sentimento di superiorità. Può sorgere il disprezzo comunicazione interpersonale. Il disprezzo è alla base di vari pregiudizi come quelli razziali, etnici, religiosi, di classe e sociali.
Paura. L'emozione della paura non viene vissuta molto spesso dalle persone e ciò potrebbe essere dovuto a questo situazioni diverse. Ma la cosa comune è che le situazioni vengono percepite come una minaccia alla sicurezza e alla tranquillità.
Le manifestazioni facciali della paura assomigliano a queste: le sopracciglia sono sollevate e leggermente abbassate sul ponte del naso, gli occhi sono spalancati, la palpebra superiore è sollevata e il bianco è esposto. La bocca è solitamente leggermente aperta. I muscoli di tutto il corpo tremano.
La sensazione di paura colpisce la pelle, dove i peli si rizzano e appare il sudore. A causa di un disturbo nell'attività del cuore, la respirazione diventa più frequente, la bocca diventa secca e si apre e si chiude.
Un intenso sentimento di paura può trasformarsi in terrore mortale, portando a svenire o urlare inorriditi.
La vergogna è l’emozione sociale più dolorosa. Quando si prova questa sensazione, una persona abbassa o gira la testa e nasconde gli occhi. Sul viso può apparire un timido rossore, che aggrava l'esperienza della vergogna, poiché attira l'attenzione degli altri sul viso. Arrossire non dipende dalla volontà di una persona, ma il desiderio di spegnerlo aumenta la tendenza ad arrossire. Fondamentalmente, il viso, il collo e le orecchie diventano rossi, ma molte persone hanno la sensazione che tutto il corpo stia bruciando. I bambini piccoli, spaventati o pieni di vergogna, si voltano o nascondono il viso sotto il vestito della madre.
I movimenti della testa e del corpo dimostrano che una persona sta cercando di diventare più piccola di quanto non sia in realtà.
K. Marx ha scritto che "...la vergogna è una specie di rabbia, rivolta solo all'interno". Questa sensazione nasce in una situazione in cui si commette un atto immorale, quando una persona sa che sarà giudicata dagli altri.
Il senso di colpa, così come altri sentimenti morali, sono caratteristici solo degli esseri umani, ma per persone e nazioni diverse le ragioni di tali sentimenti sono diverse e talvolta opposte.
L'idea di ciò che è vergognoso, prima di tutto, dipende dalla posizione morale occupata dalla persona, nonché dalle norme e dai principi morali in cui la persona è stata allevata.
La timidezza e la timidezza sono strettamente legate alla vergogna e si ritiene che queste siano manifestazioni della stessa emozione. Ma attenzione cattivo comportamento compagni e svergognarli, solo quei bambini che hanno già formato il senso della vergogna ne sono capaci.
Essendosi trasformato in uno stato emotivo stabile dell'individuo, un sentimento di vergogna può trattenere un bambino dalle azioni e dalle parole condannate dagli altri. Prendendo gradualmente piede, il sentimento di vergogna diventa la base per la formazione della coscienza.
Colpevolezza. Il senso di colpa è la condanna delle proprie azioni e di se stessi. Il senso di colpa è caratterizzato da rimorso e diminuzione dell’autostima. La principale causa di colpa è la cattiva condotta, ovvero la violazione di uno standard interno, un atto immorale o un tradimento. Una persona può sentirsi in colpa nei casi in cui in realtà non ha commesso un reato, ma avrebbe potuto agire diversamente.
Le espressioni facciali che accompagnano il senso di colpa non sono così espressive come quelle di altre emozioni negative. L'uomo abbassa la testa, distoglie lo sguardo, guarda l'accusatore e arrossisce. La persona sembra voler apparire più piccola.
AD ha studiato le emozioni. Kosheleva, N.L. Kryazheva, E.I. Kulchitskaya e altri S. Fainberg [crede che il significato biologico delle emozioni sia quello di aumentare la mente e forza fisica del corpo umano, servendo a raggiungere un obiettivo desiderato o, al contrario, a prevenire un evento indesiderato. Come bambino più piccolo, tanto più spazio nella sua vita psicologica è occupato dalle emozioni (intendendo per emozioni l'intero insieme delle esperienze sensoriali colorate).
Le emozioni sorgono in una situazione specifica con un contenuto specifico e sono accompagnate da movimenti espressivi. Le emozioni sorgono istantaneamente e sono piuttosto acute, quindi c'è un declino specifico. In un momento di stress emotivo, una persona può sviluppare una tale forza fisica e morale che potrebbe non aver osservato in se stessa fino a quel momento.
Le emozioni possono sia intensificare le azioni che aumentare la vitalità e, al contrario, ridurla.
Un'emozione insorta in modo inappropriato sovraccarica il sistema nervoso-endocrino e, di conseguenza, nel sangue si crea un eccesso di sostanze simili all'adrenalina, ma poiché non c'è modo di scaricarsi in un'azione mirata, tale emozione inizia a interferire con le attività mentali e attività fisica.
Kant divideva le emozioni in steniche e asteniche. Le emozioni steniche aumentano l'attività vitale, le prestazioni e l'energia del corpo. Tali emozioni includono gioia, amore, ispirazione. Una persona sperimenta emozioni positive quando qualsiasi desiderio è soddisfatto.
I sentimenti astenici sorgono durante i fallimenti o le difficoltà, durante i conflitti con gli altri. Hanno un effetto deprimente sulla psiche e inibiscono l'attività dell'individuo.
Il significato biologico delle emozioni negative è mobilitare il corpo umano all'attività e alla lotta. Ma, nonostante il fatto che una persona sia in grado di controllare il proprio comportamento grazie ad una volontà sviluppata, le emozioni negative influenzano ancora il comportamento e lo stato del corpo.
Pertanto, le emozioni umane sono sia un nemico che un aiuto. E dalla nascita alla morte, le emozioni ci accompagnano ovunque, sia negli eventi minori che in quelli importanti. È molto importante per il normale sviluppo di un bambino addestrare gradualmente le esperienze emotive.
S.L. Rubinstein ha identificato tre livelli di esperienze emotive.
Il primo è il livello della sensualità affettivo-emotiva organica (sensazioni fisiche di piacere e dispiacere). Include i sentimenti oggettivi corrispondenti alla percezione oggettiva e all'azione oggettiva al secondo livello. “A questo secondo livello”, ha osservato S.L. Rubinstein, “un sentimento non è altro che un’espressione nell’esperienza cosciente del rapporto di una persona con il mondo…”
È opportuno notare che l'oggettivazione dei sentimenti trova la sua massima espressione nel fatto che i sentimenti stessi si differenziano a seconda della sfera oggettiva a cui si riferiscono. Questi sentimenti si dividono in intellettuali, estetici e morali (amore o odio per una certa persona, indignazione per un'azione, ecc.).
Al terzo livello ci sono sentimenti generalizzati (ironia, sublime, tragico), che esprimono la visione del mondo dell'individuo.
Infatti, nella sua classificazione, Rubinstein fornisce un quadro dello sviluppo delle emozioni, ponendo nei suoi principali sentimenti organici primari di piacere e dispiacere.
Sulla base dell'analisi, possiamo concludere che le emozioni sono associate alla soddisfazione o all'insoddisfazione dei bisogni individuali.
Prima di considerare lo sviluppo della sfera emotiva dei bambini, è necessario soffermarsi sui meccanismi psicologici che sono alla base della formazione delle emozioni.
In psicologia, ci sono tre modi di apparire nuova emozione: contagio emotivo, mediazione emotiva, condizionamento emotivo.
Il meccanismo del contagio emotivo è dovuto al fatto che una nuova emozione viene appropriata da un altro oggetto. Per l'infezione da una nuova emozione, il grado di stress emotivo è importante, sufficiente per influenzare la sfera emotiva di una persona. Pertanto, o l'emozione stessa deve essere forte, oppure un'esperienza non molto forte dell'emozione deve verificarsi in un ampio gruppo di persone, il che aumenta il grado della sua espressione. Il meccanismo del contagio emotivo non richiede una quantità di tempo significativa. Dopo una singola presentazione, il bambino si appropria dell'emozione che gli è stata mostrata, se ha toccato la sua sfera emotiva. Ma questo meccanismo non è abbastanza efficace, poiché non possiamo sempre controllare la situazione in cui si è manifestata questa o quell'emozione.
La mediazione emotiva è associata alla formazione di un atteggiamento emotivo verso un oggetto neutro attraverso la sua associazione con un oggetto emotivamente significativo.
Lo studio dei meccanismi di mediazione emotiva ha dimostrato la sua connessione con la riduzione (diminuzione) della forza del bisogno e la formazione del comportamento: “quanto più spesso il bisogno è soddisfatto, tanto più stabile è l'abilità che si forma” (K. Scafo).
Secondo V.K. Vilyunas, la mediazione emotiva è l'essenza dell'educazione. La sua posizione si basa sulla posizione di Zh.Zh. Rousseau, che credeva che l’educazione si basasse sul rinforzo, sul condizionamento e sul reale impatto emotivo.
La pedagogia, secondo V.K. Viliunas, è più interessato a sviluppare immagini di qualità desiderabili e misure per raggiungerle, piuttosto che all'istruzione stessa.
Il meccanismo della mediazione emotiva è legato alla necessità di ripetere la situazione in cui avviene l'associazione, quindi richiede molto tempo. Vale anche la pena notare che con un rinforzo insufficiente, la motivazione nascente può indebolirsi. Allo stesso tempo, la mediazione emotiva rappresenta una grande opportunità per controllare la situazione, poiché sappiamo quale motivo determina questo o quel comportamento.
Vediamo quindi che sia il contagio emotivo che la mediazione emotiva presentano alcuni vantaggi e svantaggi. A questo proposito, in psicologia Attenzione speciale si concentra sull'imitazione e sull'identificazione (imitazione motivazionale di un'immagine stabile) come meccanismi per la formazione delle emozioni in particolare e del comportamento in generale.
Questi meccanismi si basano sulla connessione tra contagio emotivo e mediazione emotiva. La formazione di una nuova emozione è determinata dal campione copiato: il processo è mediato da questo campione, dalle sue reazioni, dal suo stato ed è controllato dal ruolo motivazionalmente determinato di questo campione per il soggetto. Pertanto, è più probabile che un bambino si appropri di un'emozione non molto brillante di un adulto significativo (madre, padre, ecc.) rispetto a un'emozione più intensa di un adulto o pari non familiare.
Il meccanismo più efficace per generare emozioni è il condizionamento emotivo. Questo meccanismo prevede di “creare una connessione tra oggetti neutri e significativi in modo ideale. Nell’immaginazione nasce un’esperienza che gradualmente si diffonde nella realtà”.
Un ruolo speciale nel condizionamento emotivo è svolto da quei tipi di attività che provocano una reazione emotiva nel soggetto. Questo è un gioco, la percezione di opere d'arte, musica, letteratura, teatro, cinema, ecc.
L'identificazione con modelli di ruolo nel gioco, le esperienze dei personaggi e l'autore nelle opere percepite espande l'esperienza emotiva del soggetto. Se un’opera è costruita in modo tale che la sua forma influenzi i sentimenti e l’esperienza di una persona, allora la soglia per la sua valutazione razionale e la sua criticità si riduce. Ciò diventa la base per l'appropriazione dell'emozione attraverso un tale metodo di contagio emotivo, come in un'esperienza reale condivisa.
Ecco perché gli approcci moderni per guidare la formazione delle emozioni in un bambino utilizzano in modo preponderante mezzi basati su attività di gioco, teatrali ed estetiche musicali.
1.1.2 Teorie dell'emozione
Storicamente, il desiderio di trovare la causa principale degli stati emotivi ha portato all'emergere vari punti opinioni, che si riflettevano nelle teorie corrispondenti.
In psicologia, una teoria deve spiegare il comportamento umano rivelando modelli psicologici specifici.
In questo caso, siamo interessati alle teorie che descrivono, spiegano e prevedono il comportamento emotivo umano, rivelando i meccanismi delle emozioni e il loro contenuto specifico.
1. Le prime teorie psicologiche delle emozioni (classiche) spiegavano il comportamento umano sulla base delle osservazioni. Nei secoli XVIII-XIX. non esisteva un unico punto di vista sulla natura delle emozioni. La posizione più comune era che si basasse sull'affermazione che le manifestazioni organiche delle emozioni sono una conseguenza dei fenomeni mentali. La formulazione più chiara di questa teoria fu data da I.F. Herbart, che credeva che il fattore psicologico fondamentale fosse l'idea, e che i sentimenti che proviamo corrispondono alla connessione che si stabilisce tra idee diverse e possono essere considerati come una reazione al conflitto tra idee. Pertanto, l'immagine di un conoscente defunto, rispetto all'immagine di questo conoscente ancora vivo, suscita tristezza. A sua volta, questo stato affettivo provoca involontariamente, quasi di riflesso, lacrime e cambiamenti organici che caratterizzano il dolore.
Sulla stessa posizione aderì anche W. Wundt (1832-1920). A suo avviso, le emozioni sono, prima di tutto, cambiamenti caratterizzati dall'influenza diretta dei sentimenti sul flusso delle idee e, in una certa misura, dall'influenza di quest'ultimo sui sentimenti, mentre i processi organici sono solo una conseguenza delle emozioni.
Pertanto, inizialmente nello studio delle emozioni, è stata stabilita l'opinione sulla natura mentale delle emozioni.
Sistema di idee di base del primo teorie psicologiche ridotto a quanto segue:
1) le emozioni sono una conseguenza dell'impatto su una persona fattori esterni(naturale e sociale);
2) le emozioni caratterizzano lo stato interno di una persona;
3) l'elenco delle emozioni di base è limitato;
4) sulla base delle emozioni primarie si sviluppa una varietà individuale di esperienze chiamate sentimenti;
5) le emozioni danno origine a desideri e, quindi, possono servire come fonte di attività umana;
6) le emozioni possono aumentare o diminuire la capacità di agire di una persona;
7) una persona non è sempre in grado di controllare le proprie emozioni;
8) una persona può o meno essere consapevole delle proprie emozioni e sentimenti;
9) le emozioni sono una manifestazione delle leggi generali dell'evoluzione.
Esistono pochissime teorie puramente psicologiche sulle emozioni che non influenzano i processi fisiologici e altri processi ad esse associati. Nel corso della storia dello sviluppo e dello sviluppo di questo campo della conoscenza, sono stati fatti più di una volta tentativi di connessione cambiamenti fisiologici nel corpo con certe emozioni e mostrano che i complessi di caratteristiche organiche che accompagnano varie processi emotivi, esiste veramente.
2. Nel 1872, Charles Darwin pubblicò il libro "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali", che rappresentò un punto di svolta nella comprensione della connessione tra fenomeni biologici e psicologici, anche in relazione alle emozioni, nella comprensione dell'origine delle emozioni e della loro connessione con il comportamento degli organismi viventi. Questo libro presentava una teoria delle emozioni che fu successivamente riconosciuta dagli psicologi. Da questo momento in poi, le emozioni cessarono di essere un fenomeno puramente psicologico e iniziarono a essere considerate un fenomeno biopsichico che svolge un ruolo importante nell'evoluzione e nel comportamento degli organismi viventi. In questo libro, Darwin ha dimostrato che nell'espressione esterna di vari stati emotivi e nei movimenti corporei associati alle emozioni, gli esseri umani e le scimmie hanno molto in comune. Inoltre, Darwin notò che quanto più alta è la posizione occupata da un essere vivente sulla scala evolutiva, tanto più ricca e diversificata è la sua posizione. mondo emotivo. Queste osservazioni costituirono la base per la sua teoria delle emozioni, chiamata teoria evolutiva delle emozioni.
Secondo questa teoria, le emozioni sono apparse nel processo di evoluzione degli esseri viventi come fenomeni vitali di adattamento psicofisiologico che contribuiscono alla sopravvivenza, alla lotta per l'esistenza e all'adattamento degli esseri viventi alle condizioni della loro vita. I cambiamenti corporei caratteristici delle varie emozioni e che le accompagnano non sono, secondo Darwin, altro che rudimenti (resti) di veri movimenti adattivi che una volta esistevano nel processo di evoluzione. Ad esempio, l'emozione della paura è accompagnata esattamente dagli stessi cambiamenti nel corpo che si verificano durante il volo. Di conseguenza, l’emozione della paura prepara praticamente il corpo ad evitare influenze dannose. L'emozione della rabbia, dal canto suo, è associata a cambiamenti nel corpo che lo preparano ad un attacco contro un oggetto che interferisce con la soddisfazione di un bisogno. Ne consegue che anche l'emozione della rabbia gioca un ruolo positivo nell'adattamento di un organismo vivente al suo ambiente.
Una delle idee principali della teoria evoluzionistica delle emozioni è che le emozioni sono nate e si sono sviluppate durante l'evoluzione come reazioni molto utili per gli animali e gli esseri umani nel loro adattamento alle condizioni di vita. Ciò spiega la connessione che esiste tra la ricchezza delle manifestazioni emotive e la complessità della struttura di un organismo vivente, nonché la sua capacità di adattarsi all'ambiente e ai cambiamenti che si verificano in esso.
3. La storia moderna delle emozioni inizia con la pubblicazione nel 1884 dell’articolo di W. James “Cos’è un’emozione?” W. James, cercando di superare i limiti delle teorie classiche e sviluppare le idee espresse da Darwin, formulò la sua teoria periferica delle emozioni. Ha cercato di elevarsi al di sopra del livello delle descrizioni specifiche e di indicare una delle cause delle emozioni. È meglio esporre la teoria delle emozioni di James con parole sue:
“Di solito è consuetudine pensare”, scrisse, “che nelle forme grezze di emozione, l'impressione mentale ricevuta da un dato oggetto evoca in noi uno stato mentale chiamato emozione, e quest'ultima comporta una certa manifestazione corporea. Secondo la mia teoria, invece, l'eccitazione corporea consegue direttamente dalla percezione del fatto che l'ha provocata, e la nostra coscienza di questa eccitazione, mentre avviene, è emozione. Di solito è consuetudine esprimerlo così: abbiamo perso la nostra fortuna, siamo sconvolti e piangiamo, abbiamo incontrato un orso, abbiamo paura e scappiamo, siamo offesi dal nemico, infuriati e lo colpiamo. Secondo l'ipotesi che difendo, l'ordine degli eventi dovrebbe essere un po' diverso; È proprio il primo stato mentale che non viene immediatamente sostituito dal secondo: tra loro devono esserci manifestazioni corporee, e quindi il modo più razionale per esprimerlo è il seguente: siamo tristi perché piangiamo, arrabbiati perché colpiamo un altro, paura perché tremiamo,... Se solo le manifestazioni fisiche non seguissero immediatamente la percezione. Quest’ultimo sarebbe nella sua forma un atto puramente cognitivo, pallido, privo di colore e di “calore” emotivo. In questo caso potremmo vedere un orso e decidere che è meglio fuggire, potremmo infliggergli un insulto e ritenere giusto respingere il colpo, ma non proveremmo paura né indignazione”.
James sosteneva che ogni percezione ha un certo tipo impatto fisico ha un effetto diffuso sul nostro corpo che precede l'emergere di emozioni o di un'immagine emotiva in noi.
Secondo la teoria di James, quando proviamo emozioni, proviamo sensazioni diverse provenienti da diverse parti del corpo. L'emozione è un prodotto dello stato dell'intero organismo; da ciascuna parte dell'organismo penetrano nella coscienza varie impressioni sensoriali, deboli e forti, piacevoli e spiacevoli, definite e indefinite, da cui si forma un senso di personalità, costantemente consapevole di ogni persona.
Da che parte oggetti evocare emozioni, suscitano in noi eccitazioni corporee? Rispondendo a questa domanda, James osserva che non esiste ancora un quadro chiaro e cita spiegazioni, principalmente darwiniane, come possibile origine delle reazioni emotive. Ad esempio, le emozioni associate alla distruzione di qualcuno (il nemico) si esprimono nella tensione generale del sistema muscolare, nel digrignare i denti, nel rilasciare gli artigli, nell'allargare gli occhi e sbuffare, che è una condizione per una lotta vittoriosa. Darwin considera una caratteristica come scoprire i denti, esporre i denti superiori e inclinare la bocca di lato come qualcosa che abbiamo ereditato dai nostri antenati. Alzare le sopracciglia è associato all'apertura degli occhi per vedere meglio.
L'espressione di disgusto è l'inizio dei movimenti associati al vomito, l'espressione di contentezza è simile al sorriso di una persona che succhia qualcosa di dolce. Annuire affermativamente è analogo a chinare la testa per mangiare.
Citando gli esempi sopra riportati per spiegare l'origine delle reazioni emotive, James afferma contemporaneamente che le ragioni proposte non spiegano tutte le manifestazioni corporee emotive. Questi includono: una sensazione di "pezzo in gola" con grave tristezza, angoscia con paura, fenomeni peculiari che si verificano all'interno e ghiandole interne e così via.
In conclusione, notiamo che dalla teoria periferica delle emozioni possiamo trarre una conclusione su come gestire le nostre emozioni. Sopprimi la manifestazione esteriore della passione e questa si congelerà dentro di te. Prima di cedere a un lampo di rabbia, prova a contare fino a dieci e il motivo della rabbia ti sembrerà insignificante. Se vogliamo sopprimere in noi stessi un'attrazione emotiva indesiderata, dobbiamo riprodurre pazientemente su noi stessi i movimenti esterni che corrispondono agli stati d'animo mentali opposti che desideriamo.
Pertanto, si può notare che la teoria di James riflette una serie di fenomeni significativi che spiegano cosa sono le emozioni e come si sviluppano e si esprimono.
Quasi contemporaneamente a James (1884), visioni simili sulla natura delle emozioni furono espresse da Lange (1885) nella sua “teoria vascolare-motoria delle emozioni”. Secondo la teoria di Lange, le emozioni sono il risultato della consapevolezza dei cambiamenti vasomotori che avvengono nel corpo. Analizzando, ad esempio, la tristezza, Lange scrive: “Elimina la stanchezza e la letargia dei muscoli, lascia che il sangue scorra alla pelle e al cervello, appaia la leggerezza negli arti e non rimarrà nulla della tristezza”.
La teoria di Lange procede dalle stesse premesse della teoria di James, ma su basi più limitate. base fisiologica. Pertanto, in una certa misura, può essere considerato un caso speciale della teoria di James. Dal punto di vista storico, queste sono due teorie apparse quasi contemporaneamente, quindi di solito vengono combinate e chiamate teoria delle emozioni di James-Lange.
4. Teorie neuropsicologiche delle emozioni (teorie centrali delle emozioni). Già Edouard Claparède (1873-1940), sostenitore della teoria di James, notava che la sua teoria incontrava grandi difficoltà.
“Se l’emozione è solo la coscienza dei cambiamenti periferici del corpo, allora perché viene percepita come un’emozione e non come una “sensazione organica”? Perché, quando ho paura, sono consapevole della “presenza della paura” in me stesso, e non solo di alcune impressioni organiche, tremore, battito cardiaco, ecc.? Lo stesso Claparède risponde a questa domanda così:
“Le emozioni sono la coscienza dell'atteggiamento globale del corpo... È noto che nel caso della percezione emotiva è più utile conoscere l'atteggiamento generale del corpo che le singole sensazioni elementari unite in un tutto. La percezione dei dettagli delle sensazioni interne non dovrebbe essere di grande interesse per l'individuo. La cosa più importante per un organismo è l’azione… Ciò che la coscienza coglie nell’emozione è, per così dire, la forma dell’organismo stesso, o il suo atteggiamento.”
Per quanto detto l'emozione viene “compresa” direttamente, incondizionatamente da chi la vive. Un'emozione racchiude in sé il suo significato.
Un passo serio nello spiegare l'emergere delle emozioni può essere fatto sulla base di studi fisiologici e neurofisiologici sulle emozioni. Questi studi iniziarono all'inizio del XX secolo, ma iniziarono ad essere condotti in modo particolarmente attivo dagli anni '30 e '40 ad oggi. Lo scopo di questi studi era ricercare il “substrato” cerebrale delle emozioni, studiare il ruolo di alcune parti del cervello nell'emergere delle emozioni e nell'organizzazione degli atti emotivo-comportamentali.
Il fisiologo americano Cannon e il fisiologo canadese Bard, in contrasto con la teoria allora dominante di James-Lange, formularono la teoria talamica delle emozioni. Le principali disposizioni di questa teoria sono le seguenti:
1) le emozioni non sono riflessi di processi che si verificano nel corpo, ma corrispondono a ciò che accade nella testa umana, cioè nel talamo;
2) c'è e, soprattutto, un percorso diretto per l'emergere delle emozioni, aggirandolo organi interni. Consiste nel fatto che l'informazione sullo stimolo emotiogenico percepito dai sensi entra immediatamente nel talamo, lì viene elaborata, correlata ai bisogni attuali del corpo, e quindi entra direttamente nel cervello, dove l'emozione nasce come riflesso diretto del CGM processi che avvengono nel talamo.
In studi successivi, si è scoperto che di tutte le strutture cerebrali, non è il talamo stesso ad essere maggiormente associato alle emozioni, ma l'ipotalamo e le parti centrali del sistema limbico.
La teoria del Cannone-Bardo è stata ricevuta ulteriori sviluppi influenzato lavoro sperimentale nel campo della neurofisiologia delle emozioni, che mostra in modo convincente il ruolo principale dei meccanismi centrali del cervello nella formazione delle emozioni umane. Nel cervello furono scoperti centri di “piacere” e “dispiacere”, la cui stimolazione elettrica provocava, rispettivamente, esperienze emotive piacevoli e spiacevoli (come rabbia e paura); sono stati costruiti diagrammi topografici di zone di strutture centrali associate a reazioni emotive di un tipo specifico; la reazione emotiva dipende non solo dall'attivazione di uno specifico “punto cerebrale”, ma anche dalle condizioni circostanti; è stata mostrata la multifunzionalità delle singole strutture cerebrali, in particolare, la multifunzionalità delle aree temporali della neocorteccia: svolgono non solo funzioni uditive, ma anche di attivazione e integrali; e così via.
Proviamo ora, sulla base di quanto esposto, a rispondere alla domanda posta da Claparède.
“Il processo di riconoscimento dei cambiamenti periferici come “emozioni” e non come “sensazioni organiche” avviene perché esistono neuroni specializzati (o le loro reti), la cui stimolazione porta a esperienze associate principalmente alle emozioni di base, cioè in linea di principio, allo stesso modo della percezione dell'esterno mondo oggettivo. Nelle emozioni viene effettuata la percezione dello stato interno del corpo, il risultato di questa percezione sono le esperienze. Come la percezione mondo esterno(immagini) è effettuata dal sistema funzionale (visivo) e la percezione dello stato interno (esperienza) è effettuata dal sistema funzionale delle emozioni. Pertanto, possiamo dire che le emozioni (esperienze) sono una proprietà sistema funzionale cervello, che implementa le funzioni di riflessione dello stato interno del corpo.
5. Teorie cognitive. Dopo teorie che spiegano le emozioni sulla base di processi fisiologici che si verificano nel corpo, in particolare nel cervello, sono apparse teorie delle emozioni che descrivono l'origine delle emozioni sulla base di processi psicologici e la loro influenza sul comportamento umano. Si è scoperto che nella dinamica degli stati emotivi di una persona, i fattori cognitivo-psicologici svolgono un ruolo non meno importante dei cambiamenti organici o dei processi fisiologici. A questo proposito, sono state proposte teorie cognitive per spiegare l'origine delle emozioni e i loro cambiamenti in base processo mentale.
Una delle prime teorie del genere fu la teoria della dissonanza cognitiva di L. Festinger.
Secondo questa teoria, una persona ha un'esperienza emotiva positiva quando le sue aspettative vengono confermate e le sue conoscenze e idee esistenti prendono vita, ad es. quando i risultati effettivi delle prestazioni corrispondono a quanto previsto. Le emozioni negative sorgono e si intensificano nei casi in cui vi sono discrepanze significative (incoerenza o dissonanza cognitiva) tra i risultati prestazionali attesi e quelli effettivi. Soggettivamente, una persona sperimenta uno stato di dissonanza cognitiva come disagio e si sforza di liberarsene il prima possibile. L'uscita dallo stato di dissonanza cognitiva può essere duplice: o modificare le aspettative e i piani cognitivi in modo che corrispondano al risultato effettivamente ottenuto durante l'attività, oppure cercare di ottenere un nuovo risultato che corrisponda a quello atteso.
In uno degli esperimenti volti a verificare la correttezza della teoria cognitiva delle emozioni, alle persone è stata offerta una soluzione fisiologicamente neutra come medicinale, che non ha avuto alcun effetto sul corpo. L'assunzione di questa soluzione per via orale è stata accompagnata da varie istruzioni. In un caso, le istruzioni lo affermavano questa medicina dovrebbe causare uno stato di euforia, in un altro - uno stato di rabbia. Dopo aver assunto il farmaco appropriato, ai soggetti è stato chiesto dopo un po' di tempo come si sentivano effettivamente. Si è scoperto che i soggetti hanno sperimentato esattamente quelle emozioni che, secondo le istruzioni, il medicinale corrispondente avrebbe dovuto causare loro.
Si è anche scoperto che la natura e l’intensità delle esperienze emotive di una persona in una data situazione dipendono da come vengono vissute dagli altri nelle vicinanze. Ciò significa che gli stati emotivi possono essere trasmessi da persona a persona e negli esseri umani, a differenza degli animali, la qualità degli stati emotivi vissuti dipende dalla sua natura. relazione personale a colui con cui entra in empatia in un dato momento.
A quanto già detto sulle condizioni e sui fattori che influenzano l'emergere e il cambiamento delle emozioni, S. Schechter ha aggiunto i suoi pensieri. Ha dimostrato che i processi emotivi dipendono anche dalla memoria e dalla motivazione di una persona. Il concetto di emozioni da lui proposto fu chiamato cognitivo-fisiologico.
Secondo questa teoria, lo stato emotivo emergente di una persona, oltre agli stimoli che percepisce e ai cambiamenti corporei generati da questi stimoli, può essere influenzato dall'esperienza passata (memoria) e dalla valutazione della situazione attuale da parte di una persona dal punto di vista considerazione dei suoi bisogni attuali (motivazione). La conferma indiretta della validità di questa teoria è l'influenza delle istruzioni verbali, nonché di informazioni emotive aggiuntive, che hanno lo scopo di modificare la valutazione della situazione.
Un'altra versione della teoria cognitiva delle emozioni è stata proposta da P.V. Simonov. Ha definito la sua teoria informativa. Si afferma che la forza di un'emozione che nasce in una persona dipende da due fattori: la forza del bisogno a cui l'emozione è associata e la disponibilità delle informazioni necessarie per soddisfare il bisogno corrispondente. L'autore ha espresso l'essenza di questa teoria nella seguente formula:
E = F (P, (Ineobh. - Inal.)),
dove E è l'emozione; P - bisogno; Inobh. - informazioni necessarie affinché una persona soddisfi pienamente tale esigenza; Inale. - informazioni che una persona ha.
Di conseguenza, maggiore è la differenza tra ciò di cui una persona ha bisogno e ciò che ha (in termini di disponibilità di informazioni), tanto più forte sarà vissuta l'emozione.
Ad oggi non esiste un unico punto di vista sulla natura delle emozioni. La ricerca sulle emozioni continua ad essere intensa. Il materiale sperimentale e teorico attualmente accumulato ci consente di parlare della duplice natura delle emozioni. Da un lato, si tratta di fattori soggettivi, che includono vari fenomeni mentali, inclusi processi cognitivi, caratteristiche organizzative del sistema di valori di una persona, ecc. D'altra parte, le emozioni sono determinate da caratteristiche fisiologiche individuale. Si può sostenere che le emozioni sorgono come risultato dell'esposizione a un determinato stimolo e il loro aspetto non è altro che una manifestazione dei meccanismi di adattamento umano e della regolazione del suo comportamento. Possiamo anche supporre che le emozioni si siano formate durante l'evoluzione del mondo animale e abbiano raggiunto il loro massimo livello di sviluppo nell'uomo, poiché in lui si presentano oggettivamente a livello dei sentimenti.
1.1.3 Il ruolo delle emozioni nella vita umana
Emozioni e sentimenti permeano tutta la vita di una persona, evidenziando gli eventi per lui più importanti. Solo questo determina il loro enorme ruolo mondo interiore ogni individuo e in tutte le culture umane.
La nostra vita è piena di esperienze: piacere e dispiacere, amore e odio, speranza e delusione, fiducia e disperazione, allegria e depressione, orgoglio e vergogna, malinconia, rabbia, gelosia, ecc. Le emozioni si manifestano come processi e stati in forme stabili reazioni che possono trasformarsi in tratti della personalità. Le emozioni "portano l'impronta di qualcosa di particolarmente vicino al soggetto che le vive" (S.L. Rubinstein).
Le emozioni sono riconosciute come importanti ruolo positivo nella vita delle persone, e ad esse sono associate le seguenti funzioni positive:
1. Funzione motivazionale-normativa. Sta nel fatto che le emozioni sono coinvolte nella motivazione del comportamento umano e possono motivarlo, guidarlo e regolarlo. Inoltre, a volte le emozioni possono sostituire il pensiero nella regolazione del comportamento. In situazioni critiche, le emozioni dicono a una persona come agire e, obbedendole, ad es. Con la sua intuizione, una persona spesso trova la giusta via d'uscita dalla situazione attuale. L'affetto che sorge in una situazione del genere indica alla persona una linea di condotta abbastanza ragionevole. Una delle manifestazioni significative dell'affetto, secondo V.K. Vilyunas, è che “imponendo azioni stereotipate al soggetto, rappresenta un certo modo di risoluzione “di emergenza” della situazione, fissata nell’evoluzione: fuga, intorpidimento, aggressività, ecc.”
La funzione motivazionale-regolatrice delle emozioni si manifesta anche nel fatto che possono attivare (emozioni steniche) o inibire (emozioni asteniche) l'attività umana.
2. Funzione di comunicazione. Sta nel fatto che le emozioni, o più precisamente, le modalità della loro espressione esterna, trasportano informazioni sulla mente e condizione fisica persona, e quindi, con l'aiuto delle emozioni, le persone possono scambiarsi informazioni significative tra loro. Grazie alle emozioni, ci capiamo meglio; possiamo, senza usare la parola, solo osservando i cambiamenti nello stato emotivo dell'altro, giudicare ciò che sta accadendo nella psiche.
3. Funzione di allarme. La vita senza emozioni è impossibile quanto la vita senza sensazioni. I movimenti emotivamente espressivi di una persona - espressioni facciali, gesti, pantomima - servono come segnali sullo stato del sistema dei bisogni umani. Se tutto va bene per lei, se il processo di soddisfazione dei bisogni vitali procede bene, allora la persona sperimenta emozioni positive; se in questo processo sorgono fallimenti e problemi, la persona sperimenterà emozioni negative.
4. Funzione protettiva. Questa funzione si manifesta nel fatto che l'emozione, che nasce come reazione istantanea e rapida del corpo, può proteggere una persona dai pericoli che la minacciano.
L'importante ruolo mobilitativo, integrativo e protettivo delle emozioni è stato sottolineato da P.K. Anokhin. Scrive: “Avendo realizzato un'integrazione quasi istantanea di tutte le funzioni del corpo, le emozioni stesse possono essere innanzitutto un segnale assoluto di un'utilità o di un'utilità. effetti dannosi sul corpo, spesso anche prima che venga determinata la localizzazione degli effetti e il meccanismo di risposta del corpo.”
Dall'elenco sopra e dalla definizione delle funzioni vitali delle emozioni, ne consegue che, in primo luogo, influenzano tutti gli aspetti della vita di una persona e, in secondo luogo, svolgono un ruolo significativo in tutti i tipi di attività interne (mentali, mentali) ed esterne (pratiche) ) attività umana.
1.2 Caratteristiche legate all'età dello sviluppo della sfera emotiva dei bambini
1.2.1 Approcci moderni guidare la formazione e lo sviluppo della sfera emotiva del bambino
L’analisi dei principali sistemi di sviluppo della sfera emotiva del bambino permette di individuare diversi approcci.
Il più sviluppato può essere considerato un approccio il cui obiettivo è legato all'arricchimento della sfera emotiva, alla stimolazione delle esperienze estetiche e allo sviluppo di capacità artistiche, musicali e recitative. I metodi sviluppati nell'ambito di questo approccio sono principalmente legati alla compilazione di concetti olistici e programmi di formazione e possono essere considerati pedagogici o psicologico-pedagogici. Esistono anche metodi psicologici basati su approcci concettuali psicologici. Va notato che, quando si affronta la questione dello sviluppo emotivo del bambino, i rappresentanti di questo approccio, di regola, si sforzano di espandere il suo potenziale creativo.
Il secondo approccio per migliorare la sfera emotiva di un bambino ha iniziato a prendere forma relativamente di recente. Lo scopo di questo approccio è legato allo sviluppo di metodi per la correzione psicologica degli stati emotivi negativi, dei disturbi nel funzionamento o dei ritardi nello sviluppo della sfera emotiva del bambino, nonché dei tratti della personalità che si sviluppano sulla base di processi negativi. In generale, l’obiettivo del secondo approccio può essere definito come l’armonizzazione del funzionamento della sfera emotiva del bambino.
Documenti simili
Caratteristiche dello sviluppo psicologico dei bambini piccoli. Il ruolo della comunicazione con gli adulti nello sviluppo di un bambino piccolo, l'influenza di fratelli e sorelle sullo sviluppo della sfera emotiva. Studio dello sviluppo della sfera emotiva dei bambini piccoli.
lavoro del corso, aggiunto il 22/07/2011
Caratteristiche generali dello sviluppo psicologico dei bambini. Caratteristiche dello sviluppo della sfera emotiva dei bambini piccoli. L'influenza dello stile di interazione con un bambino in famiglia, la presenza o l'assenza di fratelli e sorelle sullo sviluppo della sua sfera emotiva.
lavoro del corso, aggiunto il 07/04/2012
Interpretazione teorica delle emozioni nella psicologia straniera. Opinioni e teorie degli psicologi domestici. Sviluppo della sfera affettiva nei bambini in età scolare. Caratteristiche della sfera emotiva di un bambino mentalmente ritardato. Emozioni.
lavoro del corso, aggiunto il 14/12/2006
Concetto emozioni umane e studio delle loro funzioni. Caratteristiche della sfera emotiva della personalità nell'adolescenza. Caratteristiche dell'ansia e dell'implementazione ricerca empirica sfera emotiva degli adolescenti. L'importanza delle emozioni nella vita di un bambino.
test, aggiunto il 01/06/2014
Studio della sfera emotiva nella psicologia straniera e domestica. Meccanismi di sviluppo della sfera emotiva con danni al sistema muscolo-scheletrico. Caratteristiche psicologiche donne in età matura. Condizioni per lo sviluppo della personalità in età adulta.
tesi, aggiunta il 12/12/2009
Livelli di comprensione degli stati emotivi umani da parte dei bambini in età prescolare. Tipi di percezione delle emozioni da parte dei bambini. Idee di bambini di 6-7 anni sulle emozioni e sui sentimenti delle persone. Fasi e caratteristiche della formazione della reattività emotiva nei bambini, livelli del suo sviluppo.
lavoro del corso, aggiunto il 16/01/2012
Basi scientifiche e metodologiche per l'interpretazione delle tecniche di disegno proiettivo. Il concetto della sfera emotiva di un bambino. Riflessione delle caratteristiche individuali e della sfera emotiva della personalità nei disegni dei bambini. Metodi e tecniche per la conduzione di test psicologici.
lavoro del corso, aggiunto il 01/03/2014
Il problema della sfera emotiva dei bambini in età prescolare nella letteratura russa. Analisi della letteratura psicologica sullo studio del problema giochi per computer. Organizzazione di uno studio sull'influenza dei giochi per computer sulla formazione della sfera emotiva nei bambini.
lavoro del corso, aggiunto il 18/08/2014
Caratteristiche dello sviluppo della sfera emotiva dei bambini in età prescolare più anziani con disturbi normali e dello sviluppo. Studio sperimentale della sfera emotiva dei bambini in età prescolare con ritardo mentale, suo sviluppo mediante tecniche di musicoterapia.
lavoro del corso, aggiunto il 03/12/2012
L'emozione è il processo di valutazione delle informazioni che entrano nel cervello sul mondo esterno ed interno, sui loro tipi. Il problema dello sviluppo delle emozioni in età pre- età scolastica. Modelli di formazione dei processi mentali in un bambino. Sviluppo della sfera emotiva dei bambini dai 3 ai 7 anni.
L'obiettivo principale dell'educazione è la padronanza dell'esperienza sociale da parte della personalità emergente, il suo sviluppo armonioso e completo, che a sua volta porta l'impronta dell'età e delle caratteristiche individuali. Devono essere presi in considerazione processo pedagogico e utilizzare forme, metodi e mezzi educativi adeguati.
L'età è caratterizzata dalla natura dell'attività di una persona, dalle peculiarità del suo pensiero, dalla gamma dei suoi bisogni e interessi, dalle manifestazioni sociali e allo stesso tempo dalle sue opportunità e limiti nello sviluppo. Ad esempio, lo sviluppo delle capacità di pensiero e della memoria avviene più intensamente durante l'infanzia e l'adolescenza. Se le opportunità di questo periodo nello sviluppo del pensiero e della memoria non vengono utilizzate adeguatamente, negli anni successivi sarà difficile, e talvolta addirittura impossibile, recuperare il ritardo. Allo stesso tempo, i tentativi di andare troppo avanti, realizzando lo sviluppo fisico, mentale e morale del bambino senza tener conto delle sue capacità legate all'età, non possono produrre alcun effetto.
Le emozioni compaiono in una persona ancor prima che nasca. K.V. Shuleikina (1971) ha rivelato che le reazioni emotive di piacere e dispiacere sono già osservate in un feto umano di cinque-sei mesi.
Tracciando il percorso di sviluppo della sfera emotiva del bambino, G. Münsterberg scriveva all'inizio del XX secolo: “All'inizio i sentimenti sono causati solo dagli stati del corpo del bambino. La fame, la fatica e l'irritazione fisica sono sgradevoli, la leggera eccitazione e il mangiare sono piacevoli; più tardi, gli oggetti del mondo esterno e le persone danno piacere o dispiacere, e infine si raggiunge la fase in cui le cose vengono sostituite dalle parole, e gli oggetti del pensiero diventano fonti di soddisfazione e insoddisfazione. Dinamiche simili dello sviluppo della sfera emotiva del bambino sono fornite da S. L. Rubinstein: “Lo sviluppo emotivo di una persona segue... un percorso simile a quello della sua sviluppo intellettuale: il sentimento, come il pensiero del bambino, viene prima assorbito direttamente dal dato; Solo a un certo livello di sviluppo si libera dall'ambiente immediato - parenti, amici, in cui il bambino è cresciuto, e inizia a muoversi consapevolmente oltre i confini di questo ambiente ristretto. Insieme al movimento delle emozioni dagli oggetti individuali e privati all’area del generale e dell’astratto, avviene un altro cambiamento, non meno significativo: il sentimento diventa selettivo”.
I modi di reagire volontariamente a determinate emozioni stanno cambiando. Ad esempio, un bambino piccolo, avendo paura, molto probabilmente si precipiterà verso le persone a lui vicine (madre, padre, sorella, fratello). Tuttavia, già in età prescolare, le emozioni di base (innate) acquisiscono una connotazione sociale. Pertanto, un adolescente associa la fuga dal pericolo all'emozione della vergogna. Di conseguenza, sceglie un modo diverso per affrontare la paura: cerca di valutare il grado di pericolo, di assumere una posizione più vantaggiosa o semplicemente ignora la minaccia e non le attribuisce importanza.
Come osserva K. Izard (2000), con l'età non cambiano solo le reazioni emotive, ma anche il significato degli attivatori di emozioni specifiche. Quindi, a tre settimane di età, il suono della voce di una donna fa sorridere il bambino, ma man mano che il bambino cresce, la stessa voce può farlo irritare. Il volto indietreggiato della madre non causerà molta reazione bambino di tre mesi, mentre un bambino di 13 mesi reagirà con una protesta rabbiosa, e un adolescente di 13 anni potrebbe addirittura essere felice perché lasciato a casa da solo, senza cure dei genitori.
K. Izard, Yu A. Makarenko e altri psicologi hanno rivelato che nell'ontogenesi, lo sviluppo delle emozioni basali, così come la conoscenza di esse, si forma prima del previsto rispetto alle emozioni secondarie. Anche i bambini di due o tre anni non solo comprendono lo stato di paura e di gioia, ma possono riprodurli volontariamente sui loro volti. È caratteristico che, secondo A.G. Zakabluk, da scolari più piccoli In età avanzata, il numero di studenti che hanno una conoscenza corretta delle emozioni di gioia e paura rimane praticamente invariato. Ciò potrebbe indicare che la comprensione finale di queste emozioni appare entro e non oltre nove anni.
K. Bühler (1930) ha mostrato come le emozioni positive si sviluppino con l'età. Il momento in cui si prova piacere nei giochi dei bambini cambia man mano che il bambino si sviluppa: il bambino sperimenta il piacere nel momento della ricezione risultato desiderato. Nella fase successiva di sviluppo, il piacere deriva non solo dal risultato, ma anche dal processo del gioco stesso. Nella terza fase, i bambini più grandi iniziano ad anticipare il piacere all'inizio delle attività di gioco.
Lo sviluppo di idee sui fattori di formazione della personalità, tenendo conto delle caratteristiche legate all'età nel processo educativo, si è riflesso nel pensiero filosofico e psicologico-pedagogico progressivo delle epoche successive (E. Rotterdamsky, J. A. Komensky, K. A. Helvetius, D Diderot, A. Disterverg, K.D. Ushinsky, N.G. Chernyshevsky, K. Marx, Z. Freud, D. Dewey, E. Thorndike, N.K. Krupskaya, P.P. Blonsky, A.S. Makarenko, L.S. Vygotsky, E.I. Monoszon, L.I. Bozhovich, S.L. Rubinstein, V.V. Davydov, ecc.).
I bambini in età prescolare primaria sono caratterizzati da un'emotività molto elevata, non sanno ancora come gestire i propri stati emotivi. Ma gradualmente diventano più sobri ed equilibrati. I bambini sono caratterizzati da uno stato d'animo duraturo, stabile, gioioso e allegro, ma alcuni di loro mostrano stati affettivi negativi associati alla discrepanza tra un livello gonfiato di aspirazioni e risultati modesti del lavoro accademico. I sentimenti cognitivi, estetici e soprattutto morali cambiano in un modo unico. I sentimenti intellettuali di un bambino di questa età sono associati alla soddisfazione della sua crescente curiosità e dell'insaziabile sete di conoscenza. Ai bambini piace leggere, guardare la TV, si sforzano di acquisire sempre più nuove conoscenze e impressioni. Durante questo periodo si creano condizioni favorevoli per lo sviluppo dei sentimenti estetici e la coltivazione del gusto estetico.
È facile ispirare l'amore per l'ascolto della musica e il canto nei bambini in età prescolare media. Sono in grado di comprendere in modo abbastanza sensibile e sottile pezzo di musica e descriverlo accuratamente. I bambini sono in grado di percepire le immagini e imparare a distinguere ciò che è veramente bello da tutti i tipi di falsi. I sentimenti, compresi quelli estetici, sono una forma specifica di riflessione dell'ambiente. Si formano e si sviluppano, quindi, laddove la natura, l'ambiente e gli oggetti domestici riescono a soddisfare esigenze estetiche.
È necessaria l'inclusione mirata in varie forme di attività: osservare, ascoltare, suonare strumenti, cantare, ballare, disegnare, ecc.
Nei bambini si verificano cambiamenti profondi nella sfera dei sentimenti morali. Possono già provare sentimenti morali elevati: cura e sensibilità non solo verso i propri cari (genitori), ma anche verso gli estranei che hanno mostrato coraggio, nobiltà e devozione. I bambini di questa età sono estremamente caratterizzati da diverse valutazioni delle loro azioni e delle azioni di altre persone, nonché da giudizi su di loro. Le reazioni emotive dei bambini in età prescolare a un particolare evento dipendono direttamente dal grado di “rigidità” che hanno o dal livello delle loro aspirazioni.
La formazione di sentimenti cognitivi, estetici e morali richiede che il bambino padroneggi un certo sistema di conoscenze rilevanti. Sulla base si formano giudizi di valore e vari sentimenti. I sentimenti di una persona, basati sulla conoscenza, diventano giustificati e stabili. Tuttavia, la padronanza dei concetti morali non garantisce lo sviluppo di sentimenti morali in un bambino, tanto meno azioni morali. I sentimenti, soprattutto quelli morali, si sviluppano sulla base della formazione di un sistema unificato di associazioni: conoscenza - sentimenti - azioni. L'educazione mirata solo a migliorare uno di questi legami, isolato dagli altri due, porta o al formalismo e al sentimentalismo, oppure a esperienze che nascondono l'indifferenza e l'insensibilità.
La nuova formazione centrale e specifica di un adolescente è la sua idea emergente di se stesso come non più un bambino: inizia a sentirsi un adulto, si sforza di essere un adulto. L'unicità di questa caratteristica, chiamata sentimento dell'età adulta, sta nel fatto che l'adolescente rifiuta la sua appartenenza ai bambini, ma non ha ancora un sentimento di genuina e piena età adulta, sebbene sia necessario il riconoscimento della sua età adulta da parte di altri.
Questa caratteristica dell'adolescente determina la direzione della sua attività sociale: si sforza di percepire e assimilare le forme, i valori e le modalità di comportamento che esistono nel mondo degli adulti e nelle loro relazioni. Gli adolescenti lottano per l'indipendenza, una certa indipendenza, sono molto sensibili alle valutazioni degli adulti, alla sminuizione della loro dignità e dei loro diritti. Trattarli da “piccoli” li offende e li allontana dagli adulti. Allo stesso tempo, le ragazze sono più preoccupate di ciò che gli altri pensano di loro rispetto ai ragazzi, e sono molto più sensibili alle critiche e al ridicolo. Alcune caratteristiche delle reazioni emotive dell'adolescenza sono radicate in processi ormonali e fisiologici. I fisiologi spiegano lo squilibrio mentale dell'adolescente e i suoi caratteristici sbalzi d'umore, il passaggio dall'esaltazione alla depressione e dalla depressione all'esaltazione con un aumento dell'eccitazione generale durante la pubertà e un indebolimento di tutti i tipi di inibizione condizionata.
Tuttavia, le reazioni emotive e il comportamento degli adolescenti, per non parlare dei giovani, non possono essere spiegati solo dai cambiamenti ormonali. Dipendono anche da fattori sociali e dalle condizioni di educazione e le differenze tipologiche individuali spesso prevalgono sulle differenze di età. Le difficoltà psicologiche della crescita, l'incoerenza del livello delle aspirazioni e dell'immagine dell'io portano spesso al fatto che la tensione emotiva tipica di un adolescente attanaglia anche gli anni della giovinezza. I test proiettivi (test di Rorschach, test di appercezione tematica) mostrano un aumento del livello di ansia dai 12 ai 16 anni. La stessa età segna il picco di prevalenza della sindrome da dismorfomania (deliri di compromissione fisica). Dopo 13-14 anni, secondo lo psichiatra A.A. Mehrabyan, il numero dei disturbi della personalità è in forte aumento.
Le difficoltà emotive sono proprietà collaterali e non universali della gioventù. Esiste uno schema generale secondo il quale, con il livello di organizzazione e autoregolazione del corpo, aumenta la sensibilità emotiva e allo stesso tempo aumentano le possibilità di difesa psicologica.
La gamma di fattori che possono causare eccitazione emotiva in una persona non si restringe con l'età, ma si espande.
I modi di esprimere le emozioni diventano più diversi, aumenta la durata delle reazioni emotive causate dall'irritazione a breve termine, ecc. Se un adulto reagisse a tutti gli stimoli con la spontaneità di un bambino, morirebbe di sovraeccitazione e instabilità emotiva - dopo tutto, il cerchio delle relazioni che sono significative per lui è molto più ampio di quello di un bambino.
Tuttavia, un adulto viene salvato dallo sviluppo di meccanismi efficaci di inibizione interna e autocontrollo, nonché dalla capacità di rispondere selettivamente alle influenze esterne, notano D. Hebb e W. Thompson. Man mano che il bambino cresce, impara a controllarne e reprimerne alcuni manifestazioni esterne le emozioni, le emozioni sembrano entrare dentro, interiorizzarsi, creare fonti interne di eccitazione e allo stesso tempo differenziarsi.
Gli scolari più grandi mostrano il più alto livello di ansia in tutte le aree della comunicazione rispetto alle altre età, ma la loro ansia aumenta particolarmente bruscamente quando comunicano con i genitori e con quegli adulti da cui in una certa misura dipendono.
I problemi emotivi nell'adolescenza hanno origini diverse. La sindrome da dismorfomania adolescenziale – preoccupazione per il proprio corpo e il proprio aspetto – di solito scompare in gioventù. Il forte aumento del numero dei disturbi della personalità è dovuto principalmente al fatto che i bambini non presentano affatto tali disturbi a causa del sottosviluppo della consapevolezza di sé. I sintomi dolorosi e le ansie che compaiono in gioventù spesso non sono tanto una reazione alle difficoltà specifiche dell'età stessa, ma piuttosto una manifestazione dell'effetto ritardato di traumi mentali precedenti. Ricerche recenti rifiutano l’idea dell’adolescenza come periodo “nevrotico” dello sviluppo. Per la maggior parte delle persone, il passaggio dall’adolescenza all’adolescenza è accompagnato da miglioramenti nella comunicazione e nel benessere emotivo generale. Secondo lo psicologo americano R. Cattell, dai 12 ai 17 anni, gli indicatori di fattori come la socievolezza, la facilità nel trattare con le persone, la dominanza (perseveranza, competitività, desiderio di dominare) migliorano notevolmente, mentre l'eccitabilità generale, al contrario , diminuisce.
400 Capitolo 16. Caratteristiche di età e genere della sfera emotiva della personalità
In età prescolare (secondo L. Nebzhidovsky, a 6-7 anni) rapporti amichevoli tra i bambini, anche se non c'è ancora una chiara comprensione dell'amicizia; I concetti di fiducia e reciprocità sono troppo complessi per i bambini di questa età. Tuttavia, i bambini in età prescolare si comportano diversamente con amici e sconosciuti, e alcuni bambini di 4 e 5 anni sono in grado di mantenere relazioni strette e affettuose per lungo tempo. Non sono ancora in grado di esprimere a parole cosa sia l'amicizia, ma aderiscono alle regole corrispondenti alle relazioni amichevoli (Gottman, 1983).
Disturbi emotivi A bambini in età prescolare. G. M. Breslav (1990) classifica i disturbi emotivi in età prescolare come: 1) mancanza di decentramento emotivo - il bambino non è in grado di entrare in empatia né in una situazione reale né quando ascolta opere letterarie; 2) mancanza di sintonia emotiva - il bambino non è in grado di rispondere allo stato emotivo di un'altra persona, soprattutto se vicina o comprensiva; 3) l'assenza di un fenomeno specifico di autoregolazione emotiva: il bambino non sperimenta il senso di colpa associato a un nuovo stadio di autocoscienza ("Ho fatto questo") e la capacità di tornare emotivamente al passato.
G. E. Sukhareva (1959), V. V. Kovalev (1995) e altri autori notano la presenza nei bambini nevrastenici in età prescolare di un disturbo emotivo come una maggiore eccitabilità affettiva. Il bambino sviluppa rapidamente uno stato di rabbia per motivi minori; dopo una scarica affettiva può piangere e provare un senso di colpa.
Yu.M. Milanich (1997) divide i bambini con disturbi emotivi in tre gruppi. Il primo gruppo comprende bambini con conflitti intrapersonali pronunciati. Genitori e insegnanti segnalano ansia in questi bambini, paure infondate, frequenti sbalzi d'umore. Il secondo gruppo è costituito da bambini con conflitti interpersonali. Questi bambini sono caratterizzati da una maggiore eccitabilità emotiva, irritabilità e aggressività. Il terzo gruppo è costituito da bambini con conflitti sia intrapersonali che interpersonali. Sono caratterizzati da instabilità emotiva, irritabilità, aggressività, da un lato, e permalosità, ansia, sospettosità e paure, dall'altro.
Il primo gruppo è dominato dalle ragazze, il secondo e il terzo dai ragazzi. Con l'età (da 4,5 a 6-7 anni) aumenta il numero dei bambini appartenenti al primo e al terzo gruppo, mentre diminuisce quello appartenente al secondo gruppo.
Dall'intera gamma di disturbi emotivi rilevati, Yu. M. Milanich distingue tre gruppi:
1) reazioni emotive acute che colorano situazioni di conflitto specifiche per il bambino: reazioni aggressive, isteriche, di protesta, nonché reazioni di paura e risentimento eccessivo;
2) stati emotivi intensi - più stabili nel tempo, sovrasituazionali esperienze negative: tristezza, ansia, umore depresso, paura, timidezza;
3) disturbi nella dinamica degli stati emotivi: esplosività e labilità affettiva (transizioni rapide da emozioni positive a negative e viceversa).
16.5- Sfera emotiva degli scolari più piccoli 401
16.5. Sfera emotiva degli scolari più giovani
L’ingresso a scuola modifica la sfera emotiva del bambino a causa dell’espansione del contenuto delle attività e dell’aumento del numero di oggetti emotivi. Quegli stimoli che hanno causato reazioni emotive nei bambini in età prescolare non hanno più effetto sugli scolari primari. Sebbene lo scolaro più giovane reagisca violentemente agli eventi che lo riguardano, acquisisce la capacità di sopprimere le reazioni emotive indesiderate attraverso uno sforzo volontario (Bozhovich, 1968; Jacobson, 1966). Di conseguenza, c'è una separazione dell'espressione dall'emozione vissuta in entrambe le direzioni: può non rilevare l'emozione esistente o rappresentare un'emozione che non sperimenta.
D. I. Feldshtein (1988) osserva che i bambini di 10-11 anni si distinguono per un atteggiamento molto peculiare verso se stessi: circa 34 % i ragazzi e il 26% delle ragazze si vedono in modo completamente negativo. Il restante 70% dei bambini nota a casa e caratteristiche positive, Tuttavia tratti negativi superano ancora. Pertanto, le caratteristiche dei bambini di questa età sono caratterizzate da un background emotivo negativo.
Quindi, la sfera emotiva degli scolari più giovani è caratterizzata da:
1) facile reattività agli eventi in corso e colorazione della percezione, dell'immaginazione, dell'attività mentale e fisica con le emozioni;
2) spontaneità e franchezza nell'espressione dei propri sentimenti: gioia, tristezza, paura, piacere o dispiacere;
3) disponibilità all'effetto della paura; nel processo di attività di apprendimento, il bambino sperimenta la paura come una premonizione di problemi, fallimenti, mancanza di fiducia in se stessi e incapacità di far fronte al compito; lo studente sente una minaccia al suo status nella classe o nella famiglia;
4) grande instabilità emotiva, frequenti cambiamenti di umore (sullo sfondo generale di allegria, allegria, allegria, disattenzione), tendenza alle emozioni a breve termine e violente;
5) i fattori emotivi per gli scolari più giovani non sono solo i giochi e la comunicazione con i coetanei, ma anche il successo accademico e la valutazione di questi successi da parte dell'insegnante e dei compagni di classe;
6) le emozioni e i sentimenti propri e degli altri sono scarsamente riconosciuti e compresi; le espressioni facciali degli altri sono spesso percepite in modo errato, così come l'interpretazione dell'espressione dei sentimenti da parte degli altri, che porta a risposte inadeguate negli scolari più piccoli; l'eccezione sono le emozioni fondamentali di paura e gioia, per le quali i bambini di questa età hanno già idee chiare che possono esprimere verbalmente nominando cinque parole sinonimi che denotano queste emozioni (Zakabluk, 1985, 1986).
402 Capitolo 16. Caratteristiche di età e genere della sfera emotiva della personalità
Gli scolari più piccoli, come mostrato da T. B. Piskareva (1998), comprendono più facilmente le emozioni che sorgono in situazioni di vita a loro familiari, ma trovano difficile esprimere a parole le esperienze emotive. Le emozioni positive si distinguono meglio da quelle negative. Trovano difficile distinguere la paura dalla sorpresa. Il sentimento di colpa non era identificato.
A differenza dei bambini in età prescolare, che preferiscono percepire solo immagini allegre e gioiose, gli scolari più piccoli sviluppano la capacità di entrare in empatia quando percepiscono scene dolorose e conflitti drammatici (Blagonadezhina, 1968).
In età di scuola primaria, la socializzazione della sfera emotiva è particolarmente chiaramente visibile. Entro la terza elementare, gli scolari sviluppano un atteggiamento entusiasta nei confronti degli eroi e degli atleti eccezionali. A questa età, iniziano a formarsi l'amore per la Patria, un senso di orgoglio nazionale e l'attaccamento ai compagni.
R. Selman (1981), utilizzando il metodo dei bambini che discutono storie sulle relazioni tra amici, descrive quattro fasi dello sviluppo dell'amicizia negli scolari di età compresa tra 7 e 12 anni, sulla base del modello cognitivo da lui creato. Nella prima fase (fino a 7 anni), l'amicizia si basa su considerazioni di carattere fisico o geografico ed è di natura egocentrica: un amico è solo un compagno di giochi, qualcuno che vive vicino, frequenta la stessa scuola o ha interessi interessanti giocattoli. Non si parla ancora della comprensione degli interessi di un amico.
Nella seconda fase (dai 7 ai 9 anni), i bambini iniziano a permeare l’idea di reciprocità e ad essere consapevoli dei sentimenti dell’altro. Per stabilire relazioni amichevoli, è importante una valutazione soggettiva delle azioni di un altro.
Nella terza fase (dai 9 agli 11 anni), l'amicizia si basa sull'assistenza reciproca. Per la prima volta appare il concetto di impegno reciproco. I legami di amicizia sono molto forti finché durano, ma di solito non durano.
Nella quarta fase (11-12 anni), che, secondo Selman, si manifesta abbastanza raramente, l'amicizia è intesa come una relazione stabile e a lungo termine basata sull'impegno e sulla fiducia reciproca.
Alcuni autori criticano questo modello di sviluppo dell'amicizia. Così, T. Rizzo e V. Corsaro (Rizzo, Corsaro, 1988) notano che i bambini hanno una comprensione dell'amicizia molto più completa di quanto possano raccontarla. T. Berndt (1983) sottolinea che la vera amicizia è caratterizzata da relazioni piuttosto complesse e dinamiche. In un momento possono apparire interdipendenza e fiducia reciproca, in un altro indipendenza, rivalità e persino conflitto.
Molto spesso le amicizie dei bambini vengono interrotte: gli amici possono trasferirsi in un'altra scuola o lasciare la città. Quindi entrambi sperimentano un sentimento di vera perdita, un sentimento di dolore, finché non trovano nuovi amici. A volte le amicizie vengono interrotte dall'emergere di nuovi interessi, spingendo i bambini a rivolgersi a nuovi partner che possano soddisfare i loro bisogni (Rubin, 1980).
Non tutti i bambini hanno amici. In questo caso, c'è il pericolo di affrontare problemi di adattamento sociale di questi bambini. Alcuni studi suggeriscono che avere anche un solo amico intimo aiuta un bambino a superare la crisi Influenza negativa solitudine e ostilità da parte degli altri bambini.
16.6. Sfera emotiva degli adolescenti 403
16.6. Sfera emotiva degli adolescenti
Le emozioni degli adolescenti sono in gran parte legate alla comunicazione. Pertanto, le relazioni personalmente significative con altre persone determinano sia il contenuto che la natura delle reazioni emotive. Allo stesso tempo, come osserva VN Kunitsyna (1973), la mancanza di esperienza nel provare emozioni in una nuova attività principale (studio) e nell'esperienza comunicativa porta al fatto che l'adolescente basa il suo standard emotivo non su ciò che è comune, ripetuto in persone diverse, ma caratteristiche individuali specifica persona implicita. Gli adolescenti mantengono anche un atteggiamento negativo verso se stessi. Di conseguenza, gli scolari di questa età sono caratterizzati da una predisposizione alle emozioni negative e da una mancata corrispondenza nella sfera motivazionale.
Negli adolescenti, rispetto agli scolari, migliora la designazione verbale delle emozioni fondamentali di paura e gioia. La lunghezza del dizionario dei sinonimi che denotano queste emozioni aumenta da sei a sette parole (A. G. Zakabluk). A partire dall'adolescenza, la conoscenza delle emozioni diventa sempre più mediata dalle relazioni con queste emozioni (K. Izard, V. N. Kunitsyna, V. A. Labunskaya).
La sfera emotiva degli adolescenti è caratterizzata da:
1) eccitabilità emotiva molto elevata, quindi gli adolescenti si distinguono per il loro carattere, manifestazione violenta dei loro sentimenti, passione: assumono ardentemente un compito interessante, difendono appassionatamente le loro opinioni, sono pronti a “esplodere” alla minima ingiustizia verso se stessi e i propri compagni;
2) maggiore stabilità delle esperienze emotive rispetto agli scolari più giovani; in particolare, gli adolescenti non dimenticano a lungo le lamentele;
3) maggiore disponibilità ad aspettarsi la paura, manifestata nell'ansia (V.N. Kislovskaya, 1972, ha scoperto che l'ansia più alta si osserva nell'adolescenza); un aumento dell'ansia nell'adolescenza più anziana è associato all'emergere di relazioni intime-personali con una persona che evoca varie emozioni, anche a causa della paura di sembrare divertenti;
4) incoerenza dei sentimenti: spesso gli adolescenti difendono appassionatamente il loro amico, sebbene capiscano che è degno di condanna; avendo un senso di autostima molto sviluppato, possono piangere per risentimento, sebbene capiscano che piangere è vergognoso;
5) l'emergere di sentimenti non solo riguardo alla valutazione degli adolescenti da parte degli altri, ma
e sull'autostima che appare in loro come risultato della crescita della loro autoconsapevolezza;
6) fortemente senso sviluppato appartenenti ad un gruppo, quindi sono più acuti e dolorosi
sente più la disapprovazione dei suoi compagni che quella degli adulti o di un insegnante; spesso c'è la paura di essere rifiutati dal gruppo;
7) porre elevate esigenze sull'amicizia, che non si basa gioco cooperativo, come gli scolari più piccoli, ma una comunanza di interessi e sentimenti morali; l'amicizia tra adolescenti è più selettiva e intima, più duratura; Sotto l'influenza dell'amicizia, anche gli adolescenti cambiano, anche se non sempre in senso positivo; le amicizie di gruppo sono comuni;
8) manifestazione di senso civico di patriottismo.
404 Capitolo 16. Caratteristiche emotive di età e genere sfere della personalità
16.7. Sfera emotiva degli studenti delle scuole superiori
(ragazzi)
La sfera emotiva degli studenti delle scuole superiori è caratterizzata da:
1) la varietà dei sentimenti vissuti, soprattutto morali e socio-politici;
2) maggiore stabilità delle emozioni e dei sentimenti rispetto agli studenti delle scuole medie;
3) la capacità di empatia, cioè la capacità di rispondere ai sentimenti degli altri,
le persone a loro vicine;
4) lo sviluppo di sentimenti estetici, la capacità di notare la bellezza nella realtà circostante. Si sviluppa la sensibilità estetica verso oggetti lirici morbidi, gentili e calmi. Ciò, a sua volta, aiuta gli studenti delle scuole superiori a liberarsi dalle abitudini volgari e dai modi poco attraenti e promuove lo sviluppo di sensibilità, reattività, gentilezza e moderazione. I sentimenti estetici degli studenti delle scuole superiori sono più complessi di quelli degli studenti delle scuole medie. Ma, d'altra parte, possono essere sostituiti da originalità, idee estetiche immature e errate;
5) maggiore stabilità e profondità dell'amicizia; gli amici vengono scelti in base a interessi e attività comuni, uguaglianza di rapporti, devozione e obblighi; le amicizie sono per lo più interrotte dal tradimento (Hartup, 1989);
6) l'apparizione di un sentimento d'amore; l'amore giovanile, di regola, è puro, spontaneo
in poi, è ricco di varie esperienze, ha un'ombra di tenerezza, sogno, lirismo e sincerità.
Nella maggior parte dei casi, il sentimento d'amore emergente fa sì che ragazzi e ragazze si sforzino di superare i propri difetti e di svilupparsi tratti positivi personalità, da sviluppare fisicamente per attirare l'attenzione dell'oggetto dei propri sentimenti; l'amore favorisce sentimenti e aspirazioni nobili.
16.8. Cambiamenti legati all'età in varie manifestazioni
emotività
Dinamiche legate all'età della tendenza ad esprimere le emozioni di base. I dati ottenuti da M. S. Ponomareva (Ilyin, Ponomareva, 2001) sugli scolari dal 1° all'11° anno mostrano che in tutti gruppi di età la tendenza ad esprimere gioia prevale nettamente sulla tendenza ad esprimere rabbia, paura e tristezza (Fig. 16.2). La tendenza alla rabbia è un po' più pronunciata della tendenza alla paura e alla tristezza, e la tendenza alla tristezza è meno espressa.
Per tre emozioni (gioia, rabbia e tristezza), la dinamica dei loro cambiamenti con l'età è quasi la stessa, vale a dire, la loro manifestazione più pronunciata si osserva in
16.8. Cambiamenti legati all'età in varie manifestazioni di emotività 405
Riso. 16.2. Dinamica dell'età della gravità della tendenza a manifestarsi di base
Verticale: gravità della propensione, punti; orizzontalmente: età, anni
12-13 anni, cioè durante la pubertà. Nello stesso periodo si osserva la tendenza opposta rispetto alla paura: la sua gravità diminuisce. Questo coincide con i dati di N. D. Scriabin (19746), il quale ha rivelato che il maggior numero di scolari coraggiosi si verifica proprio durante la pubertà.
Dinamiche legate all'età dei tratti emotivi della personalità. P. A. Kovalev (1996) ha studiato i cambiamenti con l'età (dal 5° all'11° grado) nell'autostima di tre tratti emotivi della personalità: temperamento (eccitabilità emotiva), risentimento e vendetta. In quasi tutte le fasce d'età, gli scolari hanno valutato il loro temperamento al massimo, poi la suscettibilità e la vendetta al minimo (Figura 16.3).
L'autovalutazione dell'irascibilità è stata più alta tra gli scolari di 13 anni, il risentimento tra gli scolari di 12 anni e la vendetta tra gli scolari di 14-15 anni.
* * *
Riassumendo i cambiamenti legati all'età nella sfera emotiva, si possono notare i seguenti punti:
1) un aumento del numero di oggetti emotiogenici, soprattutto quelli di natura sociale;
2) crescente differenziazione delle esperienze emotive;
3) l'emergere di esperienze emotive non solo sul presente, ma anche sul futuro;
4) l'emergere della capacità di separare i mezzi espressivi dalle esperienze;
5) aumentare la capacità di comprendere le emozioni delle altre persone.
6) transizione delle reazioni emotiogene dall'impulsività alla volitività.

Riso. 16.3. Dinamica dell'età delle proprietà emotive della personalità Verticale: gravità delle proprietà, punti; orizzontalmente: età, anni
16.9. Caratteristiche della sfera emotiva degli anziani
Questo problema è discusso nel libro di T. A. Nemchin (1987) e nell'articolo di revisione di M. V. Ermolaeva (1999), di cui di seguito è riportato un breve riassunto.
T. A. Nemchin caratterizza i cambiamenti generali nella sfera emotiva di una persona anziana i seguenti segnali: un cambiamento nel dinamismo degli stati emotivi, espresso sia nell'inerzia che nella labilità delle emozioni; aumentare il ruolo e il posto occupato dalle emozioni negative; elevata stabilità delle emozioni superiori, comprese le emozioni associate alla creatività individuale. Nella vecchiaia, il controllo sull'espressione delle emozioni (risate, gioia, tristezza) diminuisce in modo significativo. Spesso si osserva il fenomeno opposto: insensibilità emotiva, diminuzione dell'empatia.
T. A. Nemchin considera la persistente predominanza dell'una o dell'altra modalità di esperienza: ansia, tristezza, insoddisfazione irritata come segni particolari della sfera emotiva nelle persone anziane. Tuttavia, esiste un'ampia categoria di persone che hanno fino a vecchiaia Restano ottimismo e buon umore.
Molte caratteristiche della sfera emotiva degli anziani sono dovute ai cambiamenti nel loro ruolo sociale nella società in relazione al pensionamento e alla necessità di adattarsi alle nuove condizioni di vita. Per alcuni, ciò provoca esperienze emotive negative, per altri - positive, quando una persona si rallegra di poter finalmente gestire liberamente il proprio tempo e dedicarsi alle questioni che lo interessano. Le persone che all'inizio non volevano andare in pensione provano insoddisfazione, amarezza e irritazione. Tuttavia, dopo un po' ritornano in sé e il loro atteggiamento nei confronti della nuova situazione diventa lo stesso di chi voleva andare in pensione (Levy, 1978).
16.9. Peculiarità della sfera emotiva dell'anziano 407
Il segno delle esperienze emotive è in gran parte determinato dalla strategia scelta dal pensionato per il suo adattamento alla nuova vita - preservandosi come individuo con legami sociali con la società o come individuo confinato nell'ambito della sua famiglia e di se stesso. Molto dipende dalla valutazione di una persona del suo percorso di vita. Come osserva E. Erikson (1996), se una persona è convinta che la sua vita abbia avuto luogo, allora è equilibrata e guarda con calma al futuro, ma se la vita viene valutata come vissuta invano, allora la persona viene sopraffatta da aumenta la sensazione di impotenza nel risolvere qualsiasi cosa, la disperazione e la paura della morte.
Le persone anziane spesso sviluppano rapporti amichevoli e amorevoli con i loro nipoti, rendendo questi ultimi una delle loro più grandi gioie (Cherlin & Furstenberg, 1986).
I cambiamenti nella sfera emotiva sono associati sia allo stato fisico che mentale di una persona. L'incapacità di una persona anziana di fare qualsiasi cosa per gli altri gli fa provare invidia e senso di colpa, che successivamente si trasformano in indifferenza verso gli altri (Smith, 1995), un atteggiamento indifferente verso il suo presente e futuro (Milentyev et al., 1996), e una diminuzione del controllo emotivo (gli anziani provano grande piacere nel parlare delle loro malattie, senza accorgersi che stanno diventando fastidiosi). Allo stesso tempo, la loro sensibilità aumenta (Alperovich, 1997). L'indifferenza degli anziani è considerata dai gerontologi e dagli psichiatri come un modo per proteggersi dalle esperienze forti (anche positive) che possono abbreviare gli anni di vita. In particolare, gli emergenti depressione senile, manifestato in un indebolimento del tono emotivo, rallentamento della vivacità emotiva, reazioni affettive ritardate, espressioni facciali impoverite, è associato al fatto che, non vedendo nulla di buono in futuro, le persone anziane smettono di collegare i loro piani con esso e quindi si assicurano contro possibili delusioni. È stato dimostrato, ad esempio, che la tendenza all’ottimismo infondato ha un impatto negativo sull’aspettativa di vita in età avanzata (Kalish, 1979).
È tipico delle persone anziane preoccupazione cronica che può essere considerata una lieve ansia. Gli anziani sono preoccupati per la loro salute, per il futuro dei loro figli e nipoti e per la situazione politica ed economica del Paese (Alperovich, 1997; Shakhmatov, 1996).
D'altra parte, le persone anziane sperimentano sensazione di solitudine. Rendendosi conto che il loro comportamento è spesso inappropriato, rifiutano la comunicazione e si chiudono sempre più in se stessi. Quando la loro esperienza di solitudine diventa persistente, iniziano a incolparsi per questo, il che aumenta il rischio di depressione maggiore (Peplo et al., 1989). L'esperienza della solitudine si sviluppa nel tempo in un sentimento di paura inspiegabile, grave ansia e disperazione. Contatti sociali, che gli anziani stessi non possono regolare, non danno loro soddisfazione, ma danno origine a una spiacevole sensazione di dipendenza (Rook, Peploe, 1989). Quest'ultimo è particolarmente acuto. Il sentimento di impotenza e di dipendenza è un fattore che permette agli anziani di valutare questa età come una sfortuna e una vergogna.
Le persone anziane provano meno ansia al pensiero della morte rispetto alle persone relativamente più giovani (Kastenbaum, 1986), e molti pensano alla morte frequentemente, ma con notevole calma. Solo il 10% degli anziani in un sondaggio ha risposto di avere paura di morire (Jeffers, Verwoerdt, 1977). Il pensiero della morte preoccupa soprattutto gli anziani che hanno progetti per il futuro.
409 Capitolo 16. Caratteristiche di età e genere della sfera emotiva della personalità
16.10. Differenze sessuali nelle emozioni
E. Maccoby e K. Jacklin (E. Maccoby, S. Jacklin, 1974), sulla base dell'analisi di una serie di studi sperimentali, sono giunti alla conclusione che nei primi anni di vita non vi sono differenze nella frequenza e nella durata di reazioni emotive negative nei ragazzi e nelle ragazze, ma con l’età la loro frequenza e intensità aumentano nei ragazzi e diminuiscono nelle ragazze. Lo spiegano con il fatto che le ragazze, avendo le stesse tendenze aggressive dei ragazzi, hanno paura di mostrarle a causa della punizione, mentre altre vedono l'aggressività dei ragazzi in modo più favorevole.
K. Horney (1993) scrive che in conformità con la divisione dei ruoli sociali, si è formata una certa visione delle donne come creature infantili che vivono di emozioni. In questa occasione, K. Batyushkov scrisse: “Amare o odiare! - a loro (donne. - E.I.) abbiamo bisogno di cibo costante per i sensi” 1 . Ciò è confermato in alcuni studi. Pertanto, V.A. Chiker e colleghi (1998) hanno scoperto che per le ragazze delle scuole superiori l'ambiente sociale risulta essere più saturo di eventi emotivi che hanno un significato stressante rispetto ai ragazzi. L.V. Kulikov (1997) osserva che la sfera emotiva delle donne è più differenziata e più complessa di quella degli uomini.
Molti studi, infatti, hanno evidenziato evidenti differenze nella sfera emotiva tra maschi e femmine. È vero, non è ancora chiaro se almeno alcuni di essi siano congeniti o se tutte queste caratteristiche siano acquisite nel processo di educazione specifica di ragazzi e ragazze.
1.2 Caratteristiche della sfera emotiva di un bambino in età prescolare
ansia prescolare crisi di adattamento
Fisico e sviluppo del linguaggio il bambino è accompagnato da cambiamenti nella sfera emotiva. Le sue opinioni sul mondo e le relazioni con gli altri cambiano. La capacità del bambino di riconoscere e controllare le proprie emozioni aumenta così come la sua comprensione del comportamento, ad esempio nelle aree in cui sono importanti le opinioni degli adulti su ciò che costituisce un comportamento "cattivo" e "buono". Gli adulti devono avere una buona idea di cosa aspettarsi dai bambini, altrimenti appariranno valutazioni errate che non tengono conto delle caratteristiche di età del bambino. L'atteggiamento ideale di un adulto nei confronti di un bambino è un graduale adattamento allo sviluppo emotivo e alla formazione della personalità del bambino.
All’età di tre anni, lo sviluppo emotivo del bambino raggiunge un livello tale che può comportarsi in modo esemplare. Solo perché i bambini sono capaci di un cosiddetto comportamento “buono” non significa che sarà sempre così. I bambini spesso mostrano insoddisfazione sotto forma di lacrime, isteria e urla. Anche se gli scoppi d’ira non sono così comuni tra le persone anziane come tra i più giovani, il loro senso di sé e il desiderio di indipendenza sono forti. Se un bambino di quattro anni discute usando la parola, non c’è bisogno che diventi isterico. Ma se l’adulto non risponde alla domanda del bambino: “Perché dovrei?” - allora potrebbe verificarsi un guasto. Se un bambino di quattro anni è molto stanco o ha avuto una giornata stressante, è più probabile che il suo comportamento assomigli a quello di un bambino più piccolo. Questo è un segnale per l'adulto che in questo momento il bambino ha troppo da sopportare. Ha bisogno di affetto, conforto e dell'opportunità di comportarsi per un po' come se fosse più giovane.
I sentimenti di un bambino in età prescolare sono involontari. Si accendono rapidamente, sono espressi brillantemente e svaniscono rapidamente. Il divertimento tempestoso spesso lascia il posto alle lacrime.
L'intera vita di un bambino in età prescolare è soggetta ai suoi sentimenti. Non riesce ancora a controllare le sue esperienze. Pertanto, i bambini sono molto più sensibili agli sbalzi d’umore rispetto agli adulti. Sono facili da divertire, ma ancora più facili da turbare o offendere, poiché non hanno quasi alcuna conoscenza di sé e non sanno come controllarsi. Ecco perché sono in grado di provare tutta una serie di sentimenti ed emozioni in un periodo di tempo insolitamente breve. Un bambino che si rotola sul pavimento ridendo può improvvisamente scoppiare in lacrime o disperarsi, e un minuto dopo, con gli occhi ancora umidi, ridere di nuovo in modo contagioso. Questo tipo di comportamento nei bambini è del tutto normale.
Inoltre, hanno giorni buoni e giorni brutti. Un bambino oggi può essere calmo e premuroso oppure capriccioso e piagnucoloso, e il giorno dopo può essere vivace e allegro. A volte possiamo spiegarlo cattivo umore stanchezza, dolore asilo, malessere, gelosia nei confronti del fratello minore, ecc. In altre parole, il suo cattivo umore a lungo termine è causato da uno stato di ansia dovuto a circostanze specifiche, e anche se facciamo del nostro meglio per aiutare il bambino a liberarsene, spesso accade che i sentimenti del bambino causino uno sconcerto completo. Se il cattivo umore non dura a lungo, ad esempio diversi giorni, e non oltrepassa alcun limite, non c'è motivo di preoccuparsi. Ma se il bambino è in uno stato d'animo depresso per un periodo molto lungo o si verificano cambiamenti improvvisi e inaspettati, è necessaria la consultazione con uno psicologo. Ma nella maggior parte dei casi, è meglio non attribuire troppa importanza ai cambiamenti di umore del bambino, che gli permetteranno di acquisire autonomamente stabilità emotiva.
Con lo sviluppo della sfera emotiva di un bambino in età prescolare, l'atteggiamento soggettivo viene gradualmente separato dall'oggetto dell'esperienza. Lo sviluppo delle emozioni e dei sentimenti di un bambino è associato a determinate situazioni sociali. Un’interruzione della situazione abituale (un cambiamento nella routine o nello stile di vita del bambino) può portare alla comparsa di reazioni affettive, così come alla paura. Insoddisfazione (soppressione) dei nuovi bisogni del bambino periodo di crisi può causare uno stato di frustrazione. La frustrazione si manifesta come aggressività (rabbia, rabbia, desiderio di attaccare il nemico) o depressione (stato passivo).
Lo sviluppo di emozioni e sentimenti nei bambini in età prescolare dipende da una serie di condizioni.
1. Emozioni e sentimenti si formano nel processo di comunicazione del bambino con i coetanei. Alcuni aspetti della psiche dei bambini in diverse fasi di età sono inegualmente sensibili alle condizioni dell'educazione. Quanto più piccolo è il bambino e maggiore è la sua impotenza, tanto più significativa si rivela la sua dipendenza dalle condizioni in cui è cresciuto. Con contatti emotivi insufficienti, può verificarsi un ritardo nello sviluppo emotivo, che può durare tutta la vita. L'insegnante dovrebbe sforzarsi di stabilire una vicinanza contatti emotivi con ogni bambino. Le relazioni con altre persone e le loro azioni sono la fonte più importante dei sentimenti di un bambino in età prescolare: gioia, tenerezza, simpatia, rabbia, ansia e altre esperienze. I sentimenti che sorgono in un bambino in relazione ad altre persone vengono facilmente trasferiti ai personaggi della finzione: fiabe, storie. Possono sorgere esperienze anche in relazione ad animali, giocattoli e piante. Un bambino simpatizza, ad esempio, con un fiore spezzato.
Una comunicazione impropria in famiglia può portare a:
All'attaccamento unilaterale, spesso alla madre. Allo stesso tempo, la necessità di comunicare con i pari si indebolisce;
Alla gelosia quando nella famiglia appare un secondo figlio, se il primo figlio si sente privato;
Temere quando gli adulti esprimono disperazione per il minimo motivo che minaccia il bambino. E in una situazione insolita, può sorgere l'ansia. La paura può essere instillata in un bambino. Ad esempio, la paura del buio. Se un bambino ha paura del buio, sarà l'oscurità stessa a spaventarlo.
2. Quando appositamente attività organizzate(ad esempio, lezioni di musica) i bambini imparano a provare determinati sentimenti associati alla percezione (ad esempio, la musica).
3. Emozioni e sentimenti si sviluppano in modo molto intenso in un tipo di attività adatta all'età dei bambini in età prescolare: giocosa, ricca di esperienze.
4. Nel processo di esecuzione di attività lavorative congiunte (pulizia dell'area, stanza del gruppo), si sviluppa l'unità emotiva del gruppo di bambini in età prescolare.
A seconda della situazione attuale, qualsiasi sentimento ed emozione qualitativamente diversi (amore, odio, gioia, rabbia, ansia) possono essere positivi, negativi, indicativi.
In generale, in generale, i bambini hanno un atteggiamento ottimista nei confronti delle situazioni della vita. Sono caratterizzati da uno stato d'animo allegro e allegro. Di solito, le emozioni e i sentimenti dei bambini in età prescolare sono accompagnati da movimenti espressivi: espressioni facciali, pantomima, reazioni vocali. I movimenti espressivi sono uno dei mezzi di comunicazione. Lo sviluppo di emozioni e sentimenti è associato allo sviluppo di altri processi mentali e, nella misura maggiore, alla parola.
Dovresti prestare costantemente particolare attenzione alle condizioni dei bambini e al loro umore. Puoi chiedere, ad esempio, se hanno avuto qualcosa di divertente o divertente, chi era felice per qualcosa oggi, chi era triste per qualcosa e chi ha pianto e perché. Se i bambini non sanno cosa rispondere, devi aiutarli: ricorda loro qualche episodio divertente o una lite tra bambini, chiedi perché è successo e se i bambini si sono perdonati a vicenda. Quando tali conversazioni diventano abituali, i bambini stessi memorizzeranno vari episodi e ne parleranno volentieri. E, quindi, l’ansia dei bambini sarà bassa.
Conclusioni sul primo capitolo
In questo capitolo abbiamo esaminato le questioni teoriche riguardanti le cause dell'ansia, i tipi di ansia, la sua manifestazione nei bambini in età prescolare e il modo in cui influisce sulla formazione della personalità.
L’ansia è la tendenza di una persona a provare ansia frequente e intensa.
Un'analisi teorica della letteratura ha dimostrato che l'ansia insorge in età molto precoce, quasi dall'infanzia. All'età di sette o otto anni, questo stato emotivo diventa un tratto della personalità. Il consolidamento e l'intensificazione dell'ansia portano quindi all'accumulo e all'approfondimento dell'esperienza emotiva negativa, che a sua volta dà origine a valutazioni prognostiche negative. Alto livello L’ansia rappresenta una minaccia per la salute mentale dell’individuo.
Capitolo 2. Studio della manifestazione dell'ansia nei bambini in età prescolare senior
Bambino, esperienza di vita traumatica) l'ansia si sviluppa in ansia... trasformandosi così in tratti caratteriali stabili. Ma questo non accade prima dell’età prescolare”. “Più vicino ai 7 anni e soprattutto agli 8 anni... possiamo già parlare dello sviluppo dell'ansia come tratto della personalità, come un certo stato emotivo con una predominanza di sentimenti di ansia e paura di fare qualcosa di sbagliato, non...




Il normale sviluppo del bambino interferisce con lo sviluppo creatività. Un gran numero di osservazioni, grida e sussulti può causare non solo aggressività in un bambino, ma anche ansia. FORMAZIONE PER LA CORREZIONE DELL'ANSIA PERSONALE PER L'ETÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA La composizione quantitativa del gruppo è di 5-6 coppie (10-12 persone). La durata di ciascun incontro è di 2 ore. Le lezioni si tengono una o due volte a settimana. ...