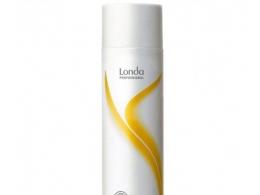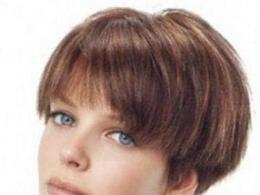Errori tipici dell'educazione familiare. "svantaggi tipici dell'educazione familiare e modi per superarli"
Una famiglia è molto spesso un mondo di relazioni complesse, tradizioni e regole nascoste all'osservazione esterna, che in un modo o nell'altro influenzano le caratteristiche della personalità dei suoi membri e, prima di tutto, dei bambini. Tuttavia, ci sono una serie di fattori sociali oggettivi che, in un modo o nell'altro, influenzano tutte le famiglie senza eccezioni. Tra questi ci sono:
- rottura dei legami di vicinato e, in alcuni casi, familiari;
- il crescente coinvolgimento delle donne nelle attività produttive e il loro doppio fardello – nel lavoro e in famiglia;
- mancanza di tempo per l'educazione e la comunicazione intrafamiliare;
- difficoltà abitative e finanziarie - tutto ciò, in un modo o nell'altro, causa difficoltà nell'attuazione delle sue funzioni educative da parte della famiglia.
Tuttavia, nonostante l’importanza dei fattori elencati, non sono quelli che giocano ruolo decisivo in caso di deviazioni, alienazione di genitori e figli. Il pericolo maggiore in questo senso deriva dagli errori che i genitori commettono nell'educazione dei figli, che vengono commessi volontariamente o inconsapevolmente dai genitori nella costruzione delle relazioni con i propri figli, dimenticando che queste relazioni sono sempre di natura educativa.
Durante l'analisi atteggiamento genitoriale Gli psicologi distinguono due dimensioni psicologiche nei confronti dei bambini: la forma di controllo sul comportamento del bambino e la natura dell'atteggiamento emotivo nei suoi confronti.
La violazione dell'atteggiamento dei genitori nei confronti del bambino o degli atteggiamenti dei genitori nell'ambito di una di queste dimensioni o contemporaneamente in entrambe porta a gravi difetti nello sviluppo della personalità del bambino. Quindi, ad esempio, la mancanza di un adeguato controllo sul comportamento del bambino in combinazione con un'eccessiva concentrazione emotiva su di lui, un'atmosfera di coccole, carezze, conformità senza principi, continua enfasi sui vantaggi esistenti e inesistenti forma tratti caratteriali isterici. Le stesse conseguenze si hanno con un atteggiamento indifferente di tipo “rifiuto”.
Il controllo eccessivo, l'imposizione di requisiti morali troppo rigidi, l'intimidazione, la soppressione dell'indipendenza, l'abuso della punizione, anche fisica, portano, da un lato, allo sviluppo della crudeltà nel bambino e, dall'altro, possono spingerlo a tentare il suicidio .
Assenza contatto emotivo, un atteggiamento affettuoso nei confronti del bambino, combinato con la mancanza di controllo adeguato e l'ignoranza degli interessi e dei problemi dei bambini, porta a casi di fuga da casa, vagabondaggio, durante i quali vengono spesso commessi reati.
Ce ne sono diversi relativamente autonomi attraverso i quali i genitori influenzano i propri figli. Innanzitutto, il rinforzo: incoraggiando il comportamento che gli adulti considerano corretto e punendo per la violazione delle regole stabilite, i genitori introducono nella mente del bambino un certo sistema di norme, il cui rispetto diventa gradualmente un'abitudine e un bisogno interno del bambino. In secondo luogo, l'identificazione: il bambino imita i suoi genitori, segue il loro esempio, cerca di diventare proprio come loro. In terzo luogo, la comprensione: conoscendo il mondo interiore del bambino e rispondendo sensibilmente ai suoi problemi, i genitori formano così la sua autocoscienza e le sue qualità comunicative.
Le migliori relazioni tra genitori e figli si sviluppano quando i genitori aderiscono a uno stile genitoriale democratico. Questo stile contribuisce maggiormente allo sviluppo dell'indipendenza, dell'attività, dell'iniziativa e della responsabilità sociale. In questo caso, il comportamento del bambino è diretto in modo coerente e allo stesso tempo flessibile e razionale:
- il genitore spiega sempre le ragioni delle sue richieste e ne incoraggia il confronto con il bambino (questo è particolarmente importante nell'età adolescenziale e in età avanzata) età scolastica);
- l'energia viene utilizzata solo quando necessario;
- in un bambino sono apprezzate sia l'obbedienza che l'indipendenza;
- il genitore fissa le regole e le fa rispettare con fermezza, ma non si ritiene infallibile;
- ascolta le opinioni del bambino, ma non procede solo dai suoi desideri.
I tipi estremi di relazioni, non importa se vanno verso l’autoritarismo o la tolleranza liberale, danno cattivi risultati. Lo stile autoritario fa sì che i bambini si alienino dai genitori e si sentano poco importanti e indesiderati nella famiglia. Le richieste dei genitori, se sembrano irragionevoli, causano protesta e aggressività, oppure apatia e passività abituali. Un'inflessione verso la tolleranza totale fa sì che il bambino abbia la sensazione che i suoi genitori non si preoccupino di lui. Inoltre, i genitori passivi e disinteressati non possono essere imitati e identificati, e altre influenze – scuola, pari, mass media – spesso non riescono a colmare questa lacuna, lasciando il bambino senza una guida e un orientamento adeguati in un mondo complesso e in cambiamento. L'indebolimento del principio genitoriale, così come la sua ipertrofia, contribuiscono ad un Io debole.
Le ricerche condotte dagli psicologi sui problemi familiari indicano che gli atteggiamenti distorti dei genitori nella stragrande maggioranza dei casi non sono la causa finale delle anomalie e dei disturbi nell'educazione familiare relazioni figli-genitori. Gli atteggiamenti dei genitori sono spesso associati a rapporti coniugali, con il rapporto con le famiglie dei genitori dei coniugi – nonni, con le caratteristiche personali dei familiari adulti e dei figli.
Come già notato nelle sezioni precedenti del lavoro, i bambini possono diventare un'arena di rivalità tra adulti, un mezzo di influenza o pressione, un metodo di punizione o vendetta. Può essere trasferito ai bambini emozioni negative sperimentato nei confronti degli altri membri della famiglia - nei confronti del coniuge, dei suoi genitori. Inoltre, i genitori possono essere emotivamente o moralmente impreparati alla genitorialità. Possono mancare la motivazione genitoriale, il senso di responsabilità può non essere sviluppato o, al contrario, esagerato; possono mancare di rispetto per se stessi e, di conseguenza, non sentirsi autorizzati a controllare il bambino e a guidare il suo sviluppo.
Gli errori dei genitori nell'allevare i figli possono essere dovuti a una serie di altri motivi. Ciò però non esclude, ma solo conferma quanto diverse e complesse siano le questioni legate alla formazione della personalità del bambino in famiglia, e quanto sia importante immaginare le difficoltà che ogni genitore può incontrare per evitare, se possibile, gli errori che lo attendono in questa importante questione.
A questo proposito ha senso soffermarsi separatamente sulle caratteristiche degli stili genitoriali tipici che più spesso si riscontrano famiglie disfunzionali.
Maggior parte Giusta direzione migliorare l'educazione dei bambini in famiglia - prevenire errori pedagogici dei genitori. E questo, a sua volta, presuppone la consapevolezza e la corretta interpretazione dei più tipici di essi. Gli errori comuni nell’educazione familiare possono essere suddivisi in tre gruppi:
1) idee sbagliate dei genitori sulle peculiarità della manifestazione dei sentimenti dei genitori (amore dei genitori);
2) insufficiente competenza psicologica dei genitori riguardo allo sviluppo legato all'età del bambino e metodi adeguati di influenza educativa;
3) sottovalutazione del ruolo dell'esempio personale dei genitori e dell'unità dei requisiti per il bambino.
Il primo gruppo di errori pedagogici dei genitori sono idee sbagliate sulle peculiarità della manifestazione dei sentimenti dei genitori.
Forse la situazione più comune in molte delle famiglie disfunzionali di oggi è l'incapacità, e talvolta la riluttanza, dei genitori a costruire i rapporti con i propri figli su una base ragionevole.
Considerare il bambino come personale e proprietà privata, tali genitori possono o proteggerlo eccessivamente, cercando di soddisfare immediatamente qualsiasi capriccio, o punirlo costantemente, mettendolo alla prova con i mezzi di influenza più crudeli, o evitare in ogni modo di lavorare con lui, dandogli completa libertà. Allo stesso tempo, possono sinceramente credere di farlo esclusivamente per il suo bene, aiutandolo nel suo sviluppo nella vita. La consapevolezza degli errori può arrivare molto tardi, quando è quasi impossibile correggere qualcosa nella personalità deformata del bambino.
Uno dei tipi più comuni di educazione familiare impropria è l'iperprotezione (cura eccessiva senza tener conto delle caratteristiche individuali, degli interessi e delle inclinazioni del bambino stesso, o elevando anche i suoi piccoli successi al rango di capacità eccezionali - educazione come "idolo familiare" "). L'iperprotezione si esprime nel desiderio dei genitori:
1) circondare il bambino con maggiore attenzione;
2) proteggerlo in tutto, anche se non ce n'è reale necessità;
3) accompagnare ogni suo passo;
4) proteggere da possibili pericoli, che spesso sono frutto dell'immaginazione dei genitori;
5) preoccuparsi per qualsiasi motivo e senza motivo;
6) tieni i bambini vicini a te, “legali” al tuo umore e ai tuoi sentimenti;
7) obbligare ad agire in un certo modo.
Proteggendo i bambini da ogni difficoltà e da affari noiosi e spiacevoli, assecondando i loro capricci e capricci, i genitori, infatti, non li allevano tanto quanto li servono. Tutto ciò può essere completato da un'esagerazione delle loro capacità e talenti, e i bambini crescono in un'atmosfera di lode e ammirazione sfrenate. In questo modo si infonde il desiderio di essere sempre visibili, di non vedersi negare nulla e l'aspettativa di un futuro brillante. Ma quando ciò non accade, la crisi è inevitabile. Alcuni cercano di prendere tutto ciò che vogliono con la forza, con qualsiasi mezzo illegale. Altri appassiscono e si considerano infelici, ingannati e svantaggiati. Come risultato dell'iperprotezione a lungo termine, il bambino perde la capacità di mobilitare la sua energia in situazioni difficili, si aspetta aiuto dagli adulti e, soprattutto, dai genitori; si sviluppa la cosiddetta "impotenza appresa": un'abitudine, una reazione riflessa condizionata a qualsiasi ostacolo insormontabile. È anche possibile un altro triste risultato. Il meschino controllo, il desiderio dei genitori di assumersi tutte le preoccupazioni e prendere da soli decisioni responsabili possono col tempo amareggiare i bambini e, una volta maturati, si ribellano all'oppressione e se non trovano sollievo possono lasciare la casa.
Di norma, l'iperprotezione, in quanto innaturale, livello aumentato le cure sono necessarie, innanzitutto, non tanto da parte dei bambini quanto da parte dei genitori stessi, soddisfacendo il loro bisogno irrealizzato e spesso acuto di affetto e di amore. Secondo gli esperti, un ruolo importante in in questo caso fattori legati all'infanzia dei genitori stessi, e prima di tutto delle madri (secondo studi di psicologi e medici, le madri sono più propense a prendersi cura dei bambini), molti dei quali sono cresciuti in famiglie senza calore e amore dei genitori. Pertanto, sono determinati a dare ai propri figli ciò che loro stessi non hanno ricevuto, ma "si spingono troppo oltre", il che alla fine porta ad un atteggiamento eccessivamente premuroso nei confronti del bambino.
Si basa sul desiderio della madre di “legare” il bambino a sé sentimento espresso preoccupazione o ansia per la salute del bambino se la sua nascita è stata accompagnata da complicazioni o durante l'infanzia soffriva spesso di malattie croniche e talvolta pericolose per la vita. In questi casi, l'iperprotezione durante la malattia è una misura ragionevole, ma sorgono difficoltà a causa del fatto che continua dopo il recupero.
Spesso l'iperprotezione si basa su un'illusione morale: nella mente dei genitori, il bambino si trasforma in un "tesoro" - una misura del prestigio dei genitori, una cosa fragile e inestimabile che deve essere tenuta "sotto il cofano" da tutto ciò che è ovviamente dannoso influenze del mondo esterno.
Un fattore importante che contribuisce all'emergere dell'iperprotezione è. I padri di figli iperprotettivi sono spesso persone eccessivamente sottomesse e difficilmente accettano partecipazione attiva nella vita quotidiana della tua famiglia. Insoddisfatta del rapporto con il marito, la madre può cercare una sorta di compensazione per ciò che il matrimonio non le dà, in un rapporto decisamente stretto con il bambino, riversando su di lui tutte le sue energie. La madre dominante nella famiglia si sforza involontariamente di creare dipendenza nei bambini. Qui si innesca il meccanismo psicologico non tanto del “legare”, quanto dell'“obbligare” i figli ad agire in un certo modo, una volta per tutte dato, che conviene alla madre.
L’iperprotezione può nascondere una forte ostilità nei confronti del bambino. Poiché questo sentimento è socialmente inaccettabile per il genitore ed è associato alla sua esperienza di colpa, viene represso nel subconscio. Alcuni genitori insoddisfatti e frustrati temono che la loro ostilità o il rifiuto del figlio possano causare loro qualcosa di terribile. Quando una madre inconsciamente “combatte contro” sentimenti di antagonismo verso al tuo stesso figlio, può reagire a questo con iperprotezione e cura eccessiva, come se dimostrasse a se stessa quanto lo ama davvero. Ciò è particolarmente probabile quando sentimenti di amore e odio coesistono tra loro. In questi casi, i genitori non possono riconoscere in se stessi la possibilità di odio verso qualcuno che allo stesso tempo amano. Questo tipo di ambiguità è una forma di esperienza molto comune e di per sé è del tutto normale. È la reazione a questi sentimenti che porta a una violazione dell'adattamento socio-psicologico, che in questo caso si manifesta sotto forma di iperprotezione.
A volte l’iperprotezione è motivata dall’ansia dei genitori e da un bisogno ossessivo di protezione psicologica per se stessi piuttosto che per il bambino.
L'iperprotezione può derivare direttamente da qualche tipo di disturbo di salute mentale nella madre. Tali violazioni portano alla manifestazione di un “bisogno” anormale della madre per la posizione di dipendenza del bambino. Quindi, M. Rutter fa un esempio questo tipo comportamento iperprotettivo di una madre che soffriva di schizofrenia.
Insisteva per dormire nello stesso letto di suo figlio e non poteva sopportare il pensiero che crescesse. Ogni notte andava a letto tenendogli la mano. Questo comportamento si è sviluppato come risultato di disturbi nel suo pensiero e in altre funzioni mentali. Periodicamente, durante l'esacerbazione della malattia, portava il bambino in clinica, come per lamentarsi delle difficoltà che suo figlio stava vivendo. Cercava infatti in questo modo di esprimere i suoi pensieri quasi deliranti riguardo al figlio e, in forma velata, chiedere aiuto per sé.
Ogni bambino prima o poi deve entrare in una vita indipendente. E quanto più prima era iperprotetto e protetto, tanto meno sarà preparato vita indipendente, tanto più difficile sarà per lui far fronte ai tanti fenomeni complessi di cui la vita è così ricca.
Lo stesso risultato negativo nello sviluppo della personalità di un bambino può essere causato dalla posizione pedagogica dei genitori di natura opposta: potere severo, fino alla crudeltà, sui bambini. Già dentro prima infanzia un bambino sperimenta tutti i tipi di punizione: per il minimo scherzo viene picchiato, per sconsideratezza viene punito. A volte non solo lo puniscono, ma lo mettono alla prova con i mezzi più crudeli: lo mettono in ginocchio in un angolo, lo minacciano con la polizia e lo picchiano in vari modi. Sfortunatamente, l’abuso sui minori è abbastanza comune, soprattutto nelle famiglie socialmente svantaggiate, dove la violenza contro i bambini diventa un luogo comune. A questo proposito ha senso ricorrere alla definizione del concetto di “crudeltà” in relazione alle questioni che stiamo considerando. Sfortunatamente, né nella psicologia domestica né in quella straniera non c'è ancora consenso sulla spiegazione dei meccanismi psicologici dell'emergere di comportamenti crudeli e manifestazioni di violenza. Questi stessi concetti sono ancora più quotidiani (cioè intuitivamente chiari) che scientifici. Tuttavia, nella moderna letteratura psicologica si trova la seguente interpretazione della crudeltà come uno dei tipi di comportamento aggressivo. “La crudeltà può essere intesa come qualcosa che causa un grave danno alla vittima e viene commesso senza provare pietà o simpatia da parte di chi ha commesso questo comportamento. La crudeltà è intesa anche come tratto caratteriale umano, e in questo caso presuppone innanzitutto la disumanità, la mancanza di umanità. Se l'aggressività è inerente sia agli animali che agli esseri umani, allora la crudeltà è inerente solo agli esseri umani. La crudeltà comporta anche la violenza contro i bisogni, le intenzioni, i sentimenti, gli atteggiamenti dell'oggetto, la sua umiliazione o la coercizione ad azioni contrarie alle sue aspirazioni. Crudeltà significa anche il desiderio di causare sofferenza e tormento a persone e animali, espresso non solo in azioni, ma anche inazione, parole e fantasie di contenuto corrispondente.
Esistono 4 forme principali di abuso e abbandono sui minori:
1. Violenza fisica.
2. Violenza sessuale o corruzione.
3. Violenza mentale (emotiva).
4. Trascuratezza dei bisogni primari del bambino (crudeltà morale).
La violenza fisica è l’inflizione deliberata di danni fisici a un bambino da parte dei genitori o di persone che ne fanno le veci, che possono portare alla morte del bambino o causare gravi danni alla salute fisica o mentale (che richiedono cure mediche), o portare a un ritardo nel il loro sviluppo.
La violenza fisica comprende anche le punizioni corporali che nuocciono alla salute fisica o mentale di un bambino.
Tenendo conto del fatto che la punizione corporale si trova più spesso nella pratica educativa di genitori provenienti da famiglie disfunzionali, soprattutto quelle con una forma aperta di svantaggio, soffermiamoci su alcuni aspetti psicologici di questo mezzo di disciplinare un bambino.
Come sapete, i genitori ricorrono molto spesso alla punizione nei casi in cui vogliono che i propri figli obbediscano e seguano incondizionatamente i requisiti, credendo che questo sia il mezzo più efficace di educazione e controllo della disciplina. E cadono nella trappola delle loro stesse delusioni.
Un noto specialista americano nel campo della psicologia e psichiatria infantile, Ross Campbell, ritiene che il pericolo principale dell'uso della punizione fisica come mezzo per controllare il comportamento è che, in primo luogo, allevia nettamente i sensi di colpa e, in secondo luogo, può portare all’autoidentificazione con l’aggressore.
Le punizioni corporali portano al degrado, alla disumanizzazione e all'umiliazione del bambino. Di conseguenza, il bambino potrebbe ritenere che la sculacciata sia di per sé una punizione sufficiente. Se viene punito spesso e severamente, il bambino non sviluppa il necessario senso di colpa, che gli impedisce di sviluppare una piena consapevolezza di sé come individuo. Senza le basi amore incondizionato il bambino non sarà in grado di attraversare tutte le fasi dello sviluppo, soprattutto identificandosi con i suoi genitori, il che paralizzerà la formazione di una psiche sana e di un'adeguata salute mentale.
Una delle conseguenze negative delle punizioni corporali è l'identificazione con l'aggressore. È anche un meccanismo psicologico per evitare i sensi di colpa. Il bambino si schiera dalla parte del genitore che punisce e ha la sensazione che essere aggressivo e punitivo sia giusto. Quindi, quando il bambino cresce e avrà figli suoi, è possibile che li tratterà nello stesso modo in cui è stato trattato durante l'infanzia. L'uso delle punizioni corporali (o la minaccia del loro utilizzo) come mezzo principale per disciplinare i bambini passa di generazione in generazione.
I genitori non dovrebbero dimenticare che la punizione stessa è efficace solo nei confronti della persona che punisce: il bambino inizia ad aver paura di lui, cerca di comportarsi “decentemente” solo in presenza di questa persona, senza osservare i requisiti di decenza nei confronti delle altre persone. L'efficacia della punizione dipende in gran parte dalla profondità dell'esperienza. La loro essenza non è punire il bambino, ma incoraggiarlo a provare un senso di colpa per ciò che ha fatto, a sentire gli aspetti negativi della sua offesa e cercare di prevenire comportamenti simili in futuro. Se questo obiettivo viene raggiunto, la punizione è vantaggiosa.
Molte persone considerano indesiderabile coltivare il senso di colpa e dimenticano che ha anche un importante aspetto positivo. Quando il senso di colpa deprime troppo una persona, è dannoso, ma in misura ragionevole è vitale per la formazione e il mantenimento di una coscienza sana. Un comportamento normale e sano, che consente al bambino di limitare ragionevolmente il suo comportamento, è molto più efficace della disciplina del bastone, che provoca paura, rabbia e indignazione.
Allo stesso tempo, va tenuto presente che la punizione può essere inefficace se viene applicata in modo frettoloso, sconsiderato, avventato e immeritatamente, ad es. non corrisponde al grado di “peccato”. Tale punizione provoca un sentimento di umiliazione, amarezza e distrugge i buoni rapporti familiari. Uno degli studenti delle scuole superiori, nel suo saggio sulla storia dell'educazione familiare, di carattere di ricerca, ha scritto: “Per la minima offesa, i miei genitori mi hanno messo in un angolo, premiandomi con epiteti poco lusinghieri e persino con una cintura. È spaventoso, ma è vero. Mia madre mi puniva soprattutto spesso. Se nel diario appariva almeno una C, lanciava i miei libri, quaderni, disegni per la stanza, mi urlava in modo offensivo e minacciava di cacciarmi di casa. Dopo scene del genere ci sarebbe stata una settimana di silenzio. Di conseguenza, non c’era alcuna vicinanza spirituale tra noi. Non volevo condividere con lei non solo le notizie più preziose, intime, ma anche ordinarie. Non volevo nemmeno parlare. E la cosa sorprendente: al lavoro lei bravo specialista, ingegnere, e la nostra famiglia è considerata prospera..."
Se i genitori sapessero quanto rigorosamente gli adolescenti valutano le loro azioni e i loro errori, molti di loro potrebbero comportarsi diversamente.
Anche i genitori che amano veramente i propri figli non sempre sanno usare saggiamente lo strumento della punizione. La crudeltà non può convincere, tanto meno correggere, una persona. Inoltre, la crudeltà può causare ritorsioni. La punizione è un'arma pedagogica molto affilata, quindi il suo utilizzo richiede grande cautela, prudenza e saggezza mondana.
Vorrei offrire ai genitori diverse regole per applicare la punizione:
- La punizione deve essere giusta e coerente con la natura del reato;
- Prima di punire, scoprire le ragioni e i motivi che hanno portato a commettere un reato;
- Non punire in base al sospetto, perché il sospetto non ha nulla a che vedere con la vera esattezza;
- Non punire i bambini in uno stato di amarezza, rabbia e irritazione; in questo stato molto spesso si commettono errori. La rabbia è un veleno che avvelena sia chi viene punito sia chi punisce;
- Sii misericordioso, non ricorrere avventatamente a punizioni crudeli, rimandale a tempi più tranquilli;
- Non abusare della potestà genitoriale, non dimenticare che anche tu sei stato bambino, mantieni il senso delle proporzioni nelle punizioni, perché le punizioni frequenti cessano di avere effetto;
- A volte è utile invitare l'autore del reato a valutare la propria colpa e ad assegnarsi una punizione. In questo modo insegnerai all'adolescente ad analizzare le sue azioni e a fare richieste a se stesso;
- Il diritto di punire in famiglia dovrebbe essere dato al genitore che ha un carattere più calmo ed equilibrato.
L'abuso o la corruzione sessuale è il coinvolgimento di un bambino, con o senza il suo consenso, consciamente o inconsciamente per immaturità funzionale o per altri motivi, in attività sessuali con adulti allo scopo di ottenere soddisfazione o beneficio per questi ultimi.
Il consenso del bambino al contatto sessuale non dà motivo di considerarlo non violento, poiché il bambino:
a) non gode di completa libertà, trovandosi in posizione dipendente da un adulto;
b) non può prevedere pienamente le conseguenze negative delle azioni sessuali per se stesso.
E ciò che più sorprende è che molti bambini e perfino adolescenti, quando diventano oggetto di molestie sessuali da parte di un loro parente, non la considerano violenza. Gli psicologi spiegano questa delusione infantile dal fatto che in condizioni di disfunzione familiare, il bambino spesso si sente non desiderato e non amato. La manifestazione di interesse sessuale nei suoi confronti da parte dei membri più anziani della famiglia è spesso considerata da lui come un favore speciale: si sente una persona importante perché l'adulto condivide con lui un segreto e ha chiaramente bisogno di lui. Considera questa forma di manifestazione di maggiore attenzione a se stesso non essere altro che amore.
Le manifestazioni più comuni di violenza mentale (emotiva), tipica delle famiglie con forme di disagio sia evidenti (aperte) che nascoste. Questo tipo di violenza intrafamiliare è caratterizzata da un impatto psicologico a lungo termine, costante o periodico, che porta alla formazione di tratti caratteriali patologici nel bambino o all'interruzione dello sviluppo della sua personalità. Questa forma di violenza comprende:
- rifiuto aperto e critica del bambino,
- insulto e umiliazione della sua dignità,
- minacce contro un bambino, manifestate in forma verbale senza violenza fisica,
- isolamento fisico o sociale deliberato di un bambino,
- imporre al bambino richieste eccessive che non sono adeguate alla sua età e alle sue capacità,
- bugie e mancato rispetto delle promesse da parte degli adulti,
- violazione della fiducia del bambino.
In questo tipo di violenza è incluso anche un singolo impatto mentale che ha causato un trauma mentale in un bambino.
La negligenza dei bisogni fondamentali del bambino (crudeltà morale) è abbastanza comune nelle famiglie disfunzionali. Allo stesso tempo, i genitori non hanno le cure di base per il bambino, di conseguenza il suo condizione emotiva oppure c'è una minaccia per la sua salute e il suo sviluppo.
Qualsiasi tipo di abuso sui minori (e molto spesso si tratta di una combinazione di diverse forme di violenza contro i bambini) viola il fisico e salute mentale bambino, il suo sviluppo come persona.
L'abuso da parte dei genitori sui bambini può essere basato su una serie di ragioni sociali e psicologiche, ma molto spesso i genitori, come i loro figli, sono vittime delle proprie idee. Cattivo atteggiamento ai bambini in famiglia avviene in un certo contesto. L'autore della psicoterapia familiare positiva, N. Pezeshkian, ritiene che i bambini siano solitamente abusati da genitori che sono sopraffatti dal peso di allevare i propri figli. Se tracciate la catena degli eventi che portano all’abuso, troverete una situazione quasi tipica: un bambino fa qualcosa che i genitori considerano un errore. Potrebbe piangere mentre suo padre guarda il suo programma sportivo preferito in TV. Oppure il bambino lascia la sua stanza in disordine, mentre la madre è orgogliosa che la sua casa assomigli alla copertina di una rivista. Oppure si macchia i pantaloni e la madre lo identifica con disobbedienza e impurità. Oppure gioca fuori con gli amici e torna a casa tardi.
In tutte queste situazioni, il bambino commette crimini contro il sistema di valori dei suoi genitori. A un osservatore esterno, questa o quella violazione può sembrare minore, ma nella mente dei genitori rappresenta una minaccia così grande che ritengono necessario rispondere con l'uso della forza fisica. I genitori cercano di proteggere i propri valori (rispetto, obbedienza, ordine, cortesia, realizzazione, purezza, ecc.) dall'abuso percepito da parte del bambino. Vogliono instillargli questi valori, ma nelle loro reazioni vanno oltre il loro obiettivo. Il risultato è l’abuso sui minori. La drammaticità della situazione è che i genitori, in realtà, avevano le migliori intenzioni, ma si sono lasciati catturare dalle loro idee rigide. Nel frattempo, basterebbe liberarli dalla sensazione che i loro valori siano così minacciati, perché possano reagire alle loro preoccupazioni in modo diverso dalle percosse. "Picchiare i bambini", dice N. Pezeshkian, "non è un'espressione della forza dei genitori, ma una manifestazione di impotenza che i genitori non possono ammettere".
A titolo di esempio, vorrei citare le tardive confessioni di una di queste madri, la quale si è accorta di aver privato i propri figli dell'infanzia con il suo comportamento sbagliato solo quando ha avuto l'opportunità di osservare come essi, divenuti adulti, si comportano con i loro propri figli e, per fortuna, non sono subentrati a quelli di mia madre “”. “Quanto sono colpevole! Non cantava ninne nanne né raccontava loro storie. Solo un po': solo una cintura o un angolo. E annotazioni: “I figli di tutti sono come bambini, ma io ho...”. Quanto tempo sono durati? Non si sono ribellati, non hanno scattato. Forse hanno intuito che semplicemente non potevo farlo in nessun altro modo? Mi sembrava che li stavo allevando. Adesso capisco che in realtà ho tiranneggiato i miei figli, li ho privati della loro infanzia. …Dio! Quanto mi vergogno quando ricordo tutti i miei “no!”, “non toccare!”, “non sono affari tuoi!” E così via. Per gelato di nuovo non l'ho dato. Ho salvato tutto. ...E la figlia? È una ragazza, ha ancora più bisogno del mio affetto e della mia tenerezza. Vorrei chiedere loro se è difficile essere miei figli. Ma non so decidermi: la domanda è retorica. Io stesso ho capito solo di recente quanto sia difficile quando nessuno dice di amarti, ma ti chiede e ti accusa solo. Quando ti rimproverano per sciocchezze e allo stesso tempo dicono che non è la tua azione ad essere cattiva, ma tu stesso.
Poiché il problema della violenza domestica ha recentemente superato i confini dei singoli appartamenti ed è diventato al centro dell'attenzione di molte organizzazioni internazionali, che si rivolgono a psicologi specializzati, sociologi, lavoratori forze dell'ordine con un appello a fermare la violenza domestica, che mina le basi non solo della famiglia, ma anche della società nel suo insieme. I bambini sono i primi a subire la violenza domestica. Secondo il Ministero degli Interni, ogni anno i genitori picchiano due milioni di bambini sotto i 14 anni. Oltre 50mila bambini sono scappati di casa per sfuggire alle violenze. Ciò che spaventa non sono le statistiche in sé, ma il fatto che dietro le porte chiuse degli appartamenti ogni giorno i destini vengono spezzati, la dignità umana viene umiliata e le anime dei bambini vengono mutilate.
Sin dall’avvento della civiltà umana, i bambini sono stati considerati proprietà dei loro genitori, il che spiega in una certa misura il trattamento crudele nei loro confronti. L’infanticidio è una pratica accettata da molte generazioni. Da bambini e neonati indesiderati con difetti di nascita venivano regolarmente respinti a Babilonia, Grecia antica E Antica Roma. Anche in Inghilterra nei primi tempi, le leggi giustificavano l'infanticidio se veniva commesso nei primi giorni dopo la nascita di un bambino. E solo nella seconda metà del 20° secolo molti paesi iniziarono ad approvare leggi speciali che richiedevano la denuncia di casi di abusi sui minori, confermando che la crudeltà nei confronti dei bambini è un grave problema sociale.
Vediamo il nostro compito nell'ambito di questo lavoro quello di soffermarci più in dettaglio su quei fattori psicologici che contribuiscono all'abuso sui minori al momento attuale, nonché di considerare le principali cause (tipiche) della crudeltà dei genitori e dell'abbandono del bambino.
Come mostrano studi di autori stranieri, il numero di casi di abusi sui minori nelle grandi aree urbane è molto più elevato che nelle piccole città, nelle periferie o nelle aree rurali. Tra i lavoratori manuali, il tasso di violenza contro i bambini è superiore del 45% rispetto a quello degli impiegati. Persone che hanno un livello più alto formazione educativa, sono più aggressivi nei confronti dei bambini, mentre le loro forme di violenza sono di tipo “raffinato”.
Gli autori di abusi sui minori sono così emotivamente instabili che non sono in grado di soddisfare i bisogni primari dei loro figli. In molti casi, un genitore che cura o trascura un figlio non è tanto crudele e disperato quanto fuorviato, impotente nella genitorialità o affetto da qualche tipo di patologia. Tuttavia, ci sono una serie di tipici ragioni psicologiche crudeltà dei genitori, su cui ci soffermeremo più in dettaglio.
1. Nelle famiglie in cui è comune il trattamento crudele dei bambini, c’è spesso un bambino preso di mira sul quale i membri della famiglia, compresi i coniugi, cercano di proiettare tutti i loro problemi. È considerato speciale, diverso dagli altri: o troppo attivo o troppo passivo, e diventa oggetto di aggressioni da parte dei familiari. Il bambino può somigliare a un parente odiato, essere il favorito di uno dei genitori, può avere un difetto che irrita il suo aguzzino, essere considerato malvagio, avere difetti fisici o mentali, oppure nascere prematuro.
2. Una situazione critica in famiglia o una combinazione di circostanze spesso causano esplosioni di comportamenti violenti. Questi possono includere la perdita del lavoro, la separazione da una persona cara, la morte di una persona cara, una gravidanza indesiderata o anche qualsiasi evento minore che sia di fondamentale importanza per un adulto che ha lui stesso un disperato bisogno di rassicurazione.
3. Molti genitori sono emotivamente impreparati alle responsabilità che la maternità o la paternità impongono loro e spesso prendono troppo sul serio i problemi associati alla genitorialità o semplicemente li ignorano. Da bambini, non hanno sviluppato abilità comunicazione interpersonale. La mancanza di educazione emotiva che hanno vissuto in momenti così significativi per loro crescita personale anni, ha limitato la loro capacità di trattarsi con rispetto e di interagire con gli altri.
4. Molto spesso, la causa della crudeltà nei confronti di un bambino è la mancanza di conoscenze di base sullo sviluppo infantile. Devi sapere che nella prima infanzia, e anche in età prescolare, i bambini non possono soddisfare immediatamente alcun requisito. Ciò non avviene per disobbedienza, ma a causa della lentezza delle reazioni, della lentezza della consapevolezza della necessità di nuove azioni e dell'inerzia delle connessioni nervose temporanee nella corteccia cerebrale. E i genitori possono aspettarsi un'obbedienza immediata, un adempimento incondizionato delle richieste, una pressione insopportabile per lui sul bambino. Il principale stress mentale e il comportamento "difficile" compaiono in un bambino molto spesso durante i cosiddetti periodi critici (crisi) del suo sviluppo, quando sorgono nuove formazioni e iniziano a manifestarsi attivamente nella struttura fisica, spirituale e morale del bambino in via di sviluppo personalità. E cosa prima dei genitori comprendere questa situazione, tanto meno è probabile che sorgano tensioni e deformazioni nei rapporti mentali e morali del bambino, tanto meno ha bisogno di metodi "forti" di influenza educativa da parte dei suoi genitori.
5. Il modello di violenza domestica tende a essere trasmesso da una generazione a quella successiva. Le punizioni severe non sono solitamente considerate violenza nei confronti dei bambini, ma sono viste come una tradizione familiare. Secondo gli psicologi, fino al 90% dei genitori che mostrano crudeltà verso i bambini, anche se si prendono cura di loro, lo hanno comunque fatto. circolo limitato competenze educative familiari perché seguono il modello che hanno ereditato.
6. L'isolamento dal mondo esterno è molto tipico delle famiglie in cui regna la violenza domestica. Molti di loro vivono una vita appartata e non si avvalgono dell'aiuto di nessuno. La loro intrinseca sfiducia porta alla negazione dei tentativi da parte dei vicini di stabilire una cooperazione con loro.
7. Nella società moderna, in molte famiglie, la violenza fisica diventa sistematica e cronica. Ogni anno, almeno un bambino su cento subisce percosse da parte dei genitori, e almeno il 40% dei bambini ha subito percosse almeno una volta durante l'infanzia. Tre bambini su cento subiscono l'uso di armi da fuoco e da taglio da parte dei genitori.
È impossibile non menzionarlo gravidanza in adolescenza, che ha gravi conseguenze. Le ragioni che motivano molti adolescenti ad avere un figlio sono solitamente legate alla mancanza di attaccamento emotivo in famiglia, dove esiste una tragica situazione di divario generazionale. Gli psicologi chiamano tutto questo “famiglie tese”. L’atmosfera stessa è sfavorevole, spesso tesa: c’è un clima psicologico malsano, dove tutti insieme e ogni individuo si sente a disagio. E i bambini corrono a cercare l'amore “dalla parte” se in casa non ce n'è abbastanza. Gli adolescenti vogliono trovare una scusa per uscire di casa o sperare che un bambino soddisfi i loro bisogni di amore e sostegno emotivo. Secondo le statistiche, solo a Mosca ogni anno si verificano 6mila nascite e 8mila aborti su minori. Ma questi sono solo quelli effettuati nelle cliniche governative. C'è motivo di credere che la cifra reale sia molto più alta.
Non meno dannoso per la formazione della personalità di un bambino è l'atteggiamento emotivamente indifferente nei suoi confronti dei genitori che gli forniscono gioventù una libertà che non sa ancora usare. Questa posizione genitoriale errata, manifestata in una mancanza di attenzione e cura per il bambino, è chiamata “ipotutela” o “ipoprotezione”.
A causa della mancanza di attenzione da parte dei genitori o degli adulti che li sostituiscono, il bambino sperimenta una mancanza di protezione (protezione) di fronte a un mondo esterno sconosciuto e spaventoso, sente la solitudine e l'impotenza nel superare le difficoltà, comprese anche quelle con cui incontra , con il sostegno dei suoi genitori, posso facilmente farcela.
Una forma estrema di ipotutela è la mancanza di assistenza all'infanzia (il più delle volte riscontrata nelle famiglie di alcolisti e tossicodipendenti). Ma forse le famiglie in cui i bambini sono finanziariamente sicuri, ma i loro bisogni emotivi e le loro esperienze emotive vengono ignorate, meritano un'attenzione speciale. Il bambino non viene quasi mai accarezzato, non hanno conversazioni intime con lui e non sono interessati ai suoi dolori, alle sue lamentele o ai suoi successi. Questo indica rifiuto emotivo bambino, perché i genitori non solo non amano i propri figli, ma ne sono anche gravati. Indipendentemente dal comportamento del bambino, non riceve approvazione, ma tutti i suoi difetti vengono notati e una grandinata di commenti e rimproveri piove su di lui, a volte i genitori possono ricorrere alla violenza fisica. Quando ai bambini viene costantemente ricordato che sono cattivi, inetti, incompetenti, pigri e che sono contrapposti agli altri, allora possono crescere timidi, oppressi, insicuri e con una bassa autostima. Ciò impedirà loro di realizzare le proprie capacità nella vita.
Con la mancanza del calore e dell'attenzione dei genitori, le capacità intellettuali dei bambini possono soffrire e rallentare. Inoltre, se un bambino nella prima infanzia non riesce a stabilirsi connessioni emotive con gli adulti, poi in età avanzata incontrerà notevoli difficoltà. La capacità di rispondere emotivamente si forma fin dai primi mesi di vita e, naturalmente, un ruolo speciale in questo spetta ai genitori, che devono insegnare al bambino ad essere felice e triste, a simpatizzare ed empatizzare.
Cosa può essere associato alle caratteristiche di un atteggiamento negligente dei genitori nei confronti del proprio figlio? Ci sono diverse ragioni per questo. In alcuni casi, i genitori semplicemente non si preoccupano dei propri figli, sono occupati con i propri problemi e si “dimenticano” completamente di loro. responsabilità genitoriali. Ciò è possibile nelle famiglie criminali e criminalmente immorali (orfanità sociale dei bambini). In altri casi, alcuni genitori, cercando di insegnare ai propri figli ad essere indipendenti fin dalla tenera età ed evitare cure eccessive, vanno all'estremo opposto, ignorando completamente i bisogni emotivi e le esperienze mentali del bambino.
A volte i genitori, non volendo assumersi il peso dei problemi educativi, cercano di dichiarare l'idea della separazione dei mondi del bambino e degli adulti. Spesso per questo viene posta una base "pedagogica": lascialo crescere indipendente, disinibito, libero. Limitano la loro partecipazione alla vita del bambino solo di tanto in tanto a porre domande formali su come stanno le cose, senza aspettare che il bambino condivida con loro le sue esperienze e chieda consigli sulla risoluzione di qualche problema che lo preoccupa. In questo caso, la ragione dell'ipotutela è più che seria: è l'indifferenza per il destino del bambino. Allo stesso tempo, i genitori indifferenti cercano di nascondere e mascherare il loro atteggiamento socialmente inaccettabile nei confronti del bambino con ogni sorta di gesti ostentati (si tratta spesso di regali costosi con cui sembrano ripagare il bambino senza realmente affrontare i suoi problemi), argomenti demagogici sulla “viziatura” dei bambini che sono felici delle vere cure genitoriali. Spesso tale ragionamento serve non solo come travestimento esterno, ma anche come difesa psicologica contro la propria coscienza, un mezzo di autogiustificazione.
È sempre difficile per i genitori trovare una “media d’oro” nell’educazione dei propri figli: mantenere un delicato equilibrio tra l’eccessiva premurosità e la richiesta di indipendenza dal bambino troppo presto, e la punizione per un reato commesso intenzionalmente, senza oltrepassare i limiti linea che separa la punizione meritata dalla violenza.
Il secondo gruppo di errori pedagogici dei genitori è l'insufficiente competenza psicologica nel campo sviluppo dell'età bambino. Molto spesso ciò si manifesta nell'incapacità di tenere conto dei cambiamenti legati all'età nella psiche del bambino e nel trattarlo secondo il modello del precedente. fase di età. Questa inerzia dei genitori provoca figli varie forme negativismo. Il negativismo è particolarmente pronunciato nell'adolescenza.
All’inizio i bambini sviluppano un “senso dell’età adulta”, un’idea di se stessi come persone che hanno diritto al proprio giudizio, iniziativa e indipendenza dal mondo degli adulti. Il passaggio dall’età della scuola primaria all’adolescenza è così rapido che non è facile per i genitori percepire cambiamenti significativi nella psiche del bambino, e continuano a prendersi cura di lui e a controllarlo come se fosse rimasto lo stesso.
I genitori cercano di limitare l'attività e l'indipendenza dell'adolescente, a volte esprimono in forma autoritaria opinioni negative sui suoi amici, interessi, cercando di influenzare gli hobby del bambino. Naturalmente, la fiducia e la mancanza di rispetto per la personalità di un adolescente contribuiscono all'alienazione dei bambini dai genitori, portandoli all'irritabilità e alla disobbedienza. Forse sarebbe opportuno qui ricordare le parole dell'antica saggezza indiana: "Tratta tuo figlio fino a cinque anni come un re, dai 5 ai 15 come un servitore, dopo i 15 come un amico". La mancanza di un atteggiamento amichevole e fiducioso nei confronti di un adolescente da parte dei genitori è molto spesso la ragione principale della comparsa di alienazione emotiva e persino di ostilità nel suo rapporto con loro.
Se i genitori non comprendono i bisogni dei loro figli, non vogliono analizzare i motivi delle loro azioni, attribuire loro motivazioni inesistenti e giudicare il bambino da loro, sorge una barriera semantica tra genitori e figli. Quindi, ad esempio, i genitori credono che il figlio sia scappato dalla classe perché non voleva studiare, e non per solidarietà con i ragazzi; ha coperto il misfatto di un compagno - per codardia, perché sarebbe stato rifiutato dalla classe, e non perché questo fosse il suo codice d'onore, ecc. I genitori devono sapere che i bambini vivono non solo secondo le norme degli adulti, ma anche secondo le norme che si sono sviluppate all'interno della classe o del gruppo con cui il bambino entra in contatto. Tuttavia, il mondo delle norme dei bambini è più ristretto e rigido di quello delle norme degli adulti, e i bambini preferiscono, pur sapendo che saranno giudicati dai genitori, vivere in conformità con queste norme di gruppo. I genitori credono che punire un bambino per aver violato sia generalmente accettato Standard morali lo avvantaggerà, ma il risultato sarà opposto se non si tiene conto di quali leggi vive il gruppo dei bambini e quali idee che si sono sviluppate in esso determinano principalmente il comportamento del bambino.
Gli errori tipici includono l'intolleranza dei genitori nei confronti delle differenze dei loro figli. A volte i genitori si lamentano della lentezza dei propri figli. Molto spesso, tali reclami provengono da madri con un sistema nervoso dinamico e forte. Se un bambino ha ereditato il temperamento di suo padre: flemmatico, lento (che in un uomo adulto assume il carattere di solidità), allora per una madre sanguigna, attiva e veloce, questo può essere fonte di costante irritazione. Madri così dinamiche si sforzano di invogliare il loro figlio flemmatico a fare un'escursione, una lunga passeggiata o un viaggio - e senza successo. Una persona flemmatica preferisce leggere di viaggi sdraiata sul divano, guardare i cartoni animati in TV, ecc. Di norma, tali madri non hanno la pazienza e la comprensione per concedere al bambino ciò che vuole, e nella famiglia sorgono litigi e malcontento reciproco.
C'è un altro malinteso tra i genitori che impedisce il pieno processo educativo: si ritiene che tutto in un bambino provenga dalla natura e non si possa farci nulla. Notano manifestazioni di carattere nei bambini già in tenera età e sono inclini a credere che i tratti della personalità e il carattere del bambino si sviluppino oltre la loro influenza: i bambini presumibilmente dalla nascita possono essere pigri, arrabbiati, aggressivi, permalosi. I genitori rafforzano le loro convinzioni argomentando che nella stessa famiglia crescono bambini completamente diversi: un bambino è laborioso, sensibile, premuroso e l'altro è l'esatto opposto. In tale argomentazione si nasconde un errore molto grave. Nonostante il fatto che i bambini crescano nella stessa famiglia, l'atteggiamento nei loro confronti e la posizione degli adulti possono essere diversi. Ad esempio, uno è stato allevato da sua nonna e l'altro da sua madre, il primo era l'idolo della famiglia, e l'altro è stato allevato dai suoi stessi genitori, essendo già più maturo e adulto. Oppure, al contrario, il maggiore si prendeva cura del più giovane e si prendeva cura di lui, e lui veniva coccolato.
Il carattere di un bambino, infatti, si sviluppa molto presto e il suo sviluppo è determinato dall'atteggiamento dei genitori nei confronti del bambino, dalle caratteristiche della propria personalità e dalle relazioni intrafamiliari. L’idea che il carattere di un bambino sia geneticamente predeterminato è pericolosa perché toglie ai genitori la responsabilità dell’educazione.
Il terzo gruppo di errori pedagogici dei genitori è la sottovalutazione dell'esempio personale e dell'unità dei requisiti per crescere un figlio, che hanno un orientamento positivo e forniscono supporto genitoriale nella formazione di tratti e qualità positive.
Come è noto, il processo di socializzazione primaria di un bambino inizia nella famiglia e le prime persone da cui viene presa in prestito l'esperienza comportamento sociale, sono i genitori. Imitando loro e altri membri adulti della famiglia, il bambino impara a costruire i suoi rapporti non solo con i parenti, ma anche con coloro che sono al di fuori del gruppo familiare, trasferendo nella comunicazione con loro le regole e le norme apprese nella casa dei genitori. Pertanto, è molto importante quale esempio di comportamento i genitori hanno mostrato ai loro figli. Come osserva M. I. Buyanov a questo proposito, "... se un ragazzo imita un padre ubriacone e turbolento, se una ragazza imita il comportamento di una madre capricciosa, litigiosa e maleducata, se un bambino prende esempio da cinico, crudele e persone cattive, questo può portare altro oltre al danno? La stragrande maggioranza delle persone con comportamenti antisociali lo sono diventati perché hanno scelto (o semplicemente si sono trovati circondati da) modelli di comportamento sbagliati”.
I genitori spesso sottovalutano questo aspetto dell'influenza educativa e chiedono ai propri figli ciò che non fanno da soli. Come risultato di tale influenza “pedagogica”, il bambino sviluppa protesta e un sentimento di mancanza di rispetto nei confronti dei suoi genitori.
Di solito, una situazione difficile e tesa in famiglia è creata dall'incapacità dei genitori di "dividere" il proprio figlio, dall'incapacità di avanzare richieste e di trovare unità nel loro approccio alla sua educazione. Il significato vitale dei requisiti è incoraggiare il bambino a farlo buone azioni e allo stesso tempo inibiscono la manifestazione di tratti e azioni negative. Esistono due gruppi di requisiti: diretti e indiretti. Quelli diretti - domanda-ordine, domanda-minaccia, domanda-divieto - sono progettati principalmente per subordinare i bambini ai loro genitori. Queste richieste spesso suonano come un comando o un grido e provocano proteste e resistenze interne da parte dei bambini.
Quei genitori che intendono le richieste come un mezzo per fare pressione sul bambino al fine di ottenere un'obbedienza incondizionata si sbagliano profondamente. Le richieste crudeli, prive di rispetto per la personalità del bambino, si trasformano in coercizione e ostacolano la sua attività e indipendenza. L'uso di richieste dirette è irto del pericolo di reprimere l'individuo.
Spesso è più facile per un padre e una madre costringere un bambino a soddisfare questo o quel requisito piuttosto che fargli desiderare di fare sempre la cosa giusta. Tali genitori credono che tutti i mezzi siano buoni per raggiungere l'obiettivo educativo, dimenticando che l'essenza dell'educazione non è forzare, ma incoraggiare il bambino ad agire consapevolmente come è appropriato.
Pertanto, nel processo educativo, è più opportuno utilizzare richieste indirette, in cui non vi è alcun sentimento di pressione e coercizione volontaria. Grazie ai requisiti indiretti, rapporto di fiducia nella famiglia i figli non hanno la dolorosa consapevolezza di essere allevati. Le richieste indirette hanno un effetto stimolante; sono progettate per creare un inizio positivo nel mondo spirituale del bambino. Domanda-consiglio, domanda-richiesta, domanda con fiducia, domanda-suggerimento, domanda-approvazione si basano sull'uso di argomenti ragionevoli e sulla fiducia nella propria forza e capacità, quindi, con l'aiuto di richieste indirette si può ottenere un'obbedienza non cieca , ma obbedienza consapevole.
Le osservazioni mostrano che i genitori utilizzano determinate forme di richieste a seconda della loro competenza pedagogica. Quelli più esperti in questo settore tendono a preferire i requisiti indiretti. In alcune famiglie talvolta si abusa degli ordini e dei divieti (non toccare, non sporcarsi, non prendere, non fare rumore, non accendere, ecc.), non è consentito uscire alla festa di compleanno di un amico, su una pista di pattinaggio in inverno, o in campeggio in estate, per paura della cattiva influenza dei propri coetanei. . Eppure i genitori non forniscono un solo argomento convincente. "Siamo i tuoi genitori e i genitori hanno sempre ragione", è il motivo principale del rifiuto. Tale trattamento non solo offende, ma umilia anche la personalità dell’adolescente. Non puoi allevare una persona degna umiliando la sua dignità e violando i suoi diritti. Divieti irragionevoli da parte dei genitori possono causare opposizione, espressa in una forma appassionata, spesso scortese.
Affinché gli adolescenti possano soddisfare le esigenze quotidiane (non disturbare chi riposa o lavora, pulire il letto, ecc.), non è necessario ricorrere a ordini rigorosi. Abbastanza per sostenere la famiglia tradizioni utili, ordine, rispetto reciproco. Tutti devono conoscere le proprie responsabilità permanenti e adempiervi.
La scarsa efficacia delle richieste dirette è ovviamente spiegata dal fatto che presuppongono che l'adolescente sia una persona maliziosa, che viola deliberatamente le norme e le regole di comportamento generalmente accettate. Se i genitori sono troppo trascinati da tali richieste, i loro figli spesso sperimentano emozioni negative. Man mano che queste emozioni si accumulano, formano centri di eccitazione stagnanti e creano una situazione di conflitto. L'adolescente diventa aggressivo e resiste apertamente ai dettami.
I genitori devono utilizzare abilmente tutti i tipi di requisiti. Per superare, ad esempio, la disobbedienza, dovresti prima di tutto cambiare l'approccio con tuo figlio o tua figlia, poiché un bambino in adolescenza ha bisogno di sensibilità e buona volontà. Oltre a cambiare il tuo approccio, dovresti fare richieste con un tono che non consenta obiezioni. È utile assicurarsi che la tua voce trasmetta calma fiducia in se stessi e, allo stesso tempo, fiducia nella forza dell’adolescente. I bambini non dovrebbero avere dubbi sul diritto degli adulti di avanzare richieste. Rivolgersi a un adolescente con rispetto rende più facile sia presentargli le richieste sia soddisfarle.
La scelta del requisito dipende dalla natura della situazione specifica, dalla capacità di orientamento dei genitori e dalla capacità di agire con saggezza in varie circostanze. Se la situazione è estremamente tesa, a volte è opportuno che il padre o la madre scendano a compromessi per superare il conflitto. I genitori pedagogicamente competenti adottano tutte le misure per prevenire i conflitti nella loro relazione con un adolescente. Se, in uno stato di rabbia e passione, un adulto commette maleducazione, allora dovrebbe essere il primo a cercare una via d'uscita dalla situazione di conflitto.
Oltre alla complessità della situazione, è sempre necessario tenere conto delle specificità. Quanto più vulnerabile è la sua psiche, tanto più delicate dovrebbero essere le forme della domanda. Più l’adolescente è anziano, più spesso le richieste dovrebbero essere formulate nella forma seguente, ad esempio: “Pensiamo insieme, consultiamoci su come farlo al meglio”. A tutti gli adolescenti piace quando vengono consultati e parlati come adulti, quando vengono apprezzati, quando si tiene conto della loro opinione, del loro sé umano.
Sebbene i requisiti siano diversi, hanno tutti caratteristiche comuni. In primo luogo, il rispetto dei requisiti è obbligatorio. Se i bambini ne sono consapevoli, nella famiglia l'autorità degli adulti è alta e irremovibile. Gli adolescenti considerano le richieste del padre e della madre come una norma di comportamento e una guida all'azione.
In secondo luogo, la responsabilità di soddisfare i requisiti. È il senso di responsabilità che caratterizza l’atteggiamento dell’adolescente nei confronti delle richieste genitoriali, e quindi nei confronti dei genitori stessi. È importante instillare negli adolescenti che l'adempimento tempestivo dei requisiti contribuisce allo sviluppo della volontà.
Educare significa, innanzitutto, accrescere la responsabilità personale dell'educando rispetto al lavoro assegnato. Ma l'essenza della responsabilità non è solo che l'adolescente comprenda la sua responsabilità, ma anche che mostri iniziativa personale e attività nel realizzarla. Tale responsabilità è indissolubilmente legata alla coscienza, che incoraggia a soddisfare diligentemente le richieste dei propri anziani.
Molti genitori sono ben consapevoli della necessità di essere esigenti nei confronti dei propri figli adolescenti. Ma ogni richiesta è efficace? Quali condizioni contribuiscono ad aumentare l’efficacia delle richieste dei genitori?
Per influenzare positivamente gli adolescenti e mantenere il rispetto di sé, è necessario padroneggiare la tecnica delle richieste. Questa tecnica include:
- conoscenza della portata dei requisiti (cosa richiedere);
- applicazione di varie forme di requisiti, tenendo conto della personalità dell'adolescente e della situazione specifica;
- creazione di condizioni pedagogiche favorevoli alle quali il requisito può essere soddisfatto.
La pratica dell'educazione familiare mostra che l'efficacia nel soddisfare i requisiti dipende, in primo luogo, dalla loro equità. Se i genitori a volte sono duri, ma sempre giusti, i figli perdonano loro la loro durezza e obbediscono alle loro richieste. I bambini, come gli adulti, sono sensibili alla giustizia, la apprezzano molto e condannano l’ingiustizia.
In secondo luogo, l’efficacia nel soddisfare i requisiti dipende dalla loro attenzione. Prima di fare un'osservazione o pretendere qualcosa, è utile pensare: “Cosa darà questo? Cosa può ottenere questo? È noto che un obiettivo nobile richiede mezzi nobili per raggiungerlo. I metodi e i mezzi educativi raggiungono con successo l'obiettivo quando rafforzano il sentimento autostima una persona, anziché umiliarla.
In terzo luogo, l’efficacia nel soddisfare i requisiti dipende dall’unità e dalla coerenza delle azioni dei genitori. Se le giuste richieste e i commenti del padre incontrano il sostegno della madre, si creano condizioni favorevoli per l’educazione. Al contrario, l’incoerenza nelle azioni dei genitori mina il loro prestigio e insegna al bambino ad adattarsi a richieste opposte. Ad esempio, in alcune famiglie, ci sono disaccordi tra i genitori nella comprensione di ciò che è giusto e accettabile: la madre crede che il bambino potrebbe non andare a scuola perché dice che è malato (“il bambino è stanco”), ma per per il padre questa è una violazione dello stereotipo, che disorganizza il bambino e anche una palese menzogna. E se i genitori discutono le loro posizioni di fronte al bambino, questo svaluta per lui l'opinione di colui dalla cui parte ha incondizionatamente ragione.
A volte sorgono disaccordi tra i genitori quando si sceglie una punizione per il misfatto di un bambino: uno pretende una punizione severa o crudele, l’altro ne offre una più clemente o non offensiva per lui, dimenticando che deve essere, prima di tutto, giusta.
Quando si incontrano caratteristiche individuali sviluppo del bambino, che causano confusione tra i genitori e servono come fonte di giudizi contrastanti sul carattere dei bambini, madri e padri si comportano diversamente. I padri, di natura più severa e crudele, tendono ad attribuire le difficoltà nel rapporto con i figli alla loro ostinazione e mancanza di volontà. Vedendo una via d'uscita nell'approccio spartano all'educazione, spesso vedono un grande effetto nell'uso della punizione, inclusa quella fisica. Paradossalmente, i mezzi paterni di "educazione alla forza" producono effettivamente un certo risultato: l'obbedienza del bambino, che serve come conferma per i padri della fedeltà della loro linea. Di norma, è difficile convincerli dell'inopportunità dell'uso di tali metodi di influenza, perché l'effetto è ovvio, quindi perché discutere? Tuttavia, l'obbedienza che i genitori tanto ricercano attraverso la punizione è solo esteriore, un'obbedienza dovuta alla paura, che non contribuisce alla maturazione dell'individuo, allo sviluppo della sua iniziativa e alla crescita creativa. Pertanto, quando si puniscono i bambini, i genitori, in primo luogo, devono essere uniti nel trovare una via d'uscita adeguata da una situazione difficile. In secondo luogo, il bambino deve sentire che, qualunque sia il reato commesso, non perderà in nessun caso l'amore dei suoi genitori e che la punizione non si applica a tutta la sua personalità, ma solo a un'azione specifica (in questo caso, il reato ). Terzo, metodi educativi e i mezzi non dovrebbero umiliare l’autostima del bambino e combinare richieste ragionevoli con una forma di presentazione discreta. Solo a queste condizioni i genitori potranno mantenere la loro autorità agli occhi dei figli, e l’equità e la coerenza delle loro richieste saranno considerate una norma di comportamento e una guida all’azione.
Nell’istruzione abbiamo bisogno di una linea d’azione unica, ragionevole e pedagogicamente giustificata. Il ruolo di protagonista dovrebbe essere affidato a qualcuno che abbia più solidità esperienza pedagogica e autorità educativa. Se nell'istruzione studente della scuola media a volte i metodi di intimidazione aiutano, poi per influenzare un adolescente servono altri mezzi e, soprattutto, cultura, conoscenze particolari, richieste non schiaccianti, ma persuasive basate sul tatto pedagogico, sulla cordialità e sul rispetto dell'individuo. La combinazione di precisione e tatto è la condizione più importante per l'efficacia dei requisiti dei genitori. Il tatto è il modo più efficace per influenzare la coscienza, i sentimenti e la volontà di un adolescente senza il rischio di perdere la propria autorità. Il tatto è caratterizzato da naturalezza e facilità d'uso, sincerità di tono, fiducia senza connivenza, richiesta senza pignoleria, richiesta senza supplica. Un atteggiamento discreto presuppone:
- rispetto della dignità della personalità dell'adolescente e ragionevole esattezza nei confronti del suo insegnamento, lavoro e comportamento;
- molta attenzione anziani a stato mentale un adolescente e la sequenza dei requisiti per lui nello svolgimento degli incarichi;
- interconnessione e uso ragionevole vari mezzi e metodi di influenza educativa: approvazione, incoraggiamento, requisiti severi, persuasione, avvertimento, suggerimento, condanna, giusta punizione;
- fiducia abbinata ad un controllo sistematico, ma non invasivo, che incoraggia l'adolescente all'autocontrollo;
- una combinazione di calma fiducia e buona volontà nella comunicazione, che aiuta a evidenziare ciò che è necessario e importante nelle richieste degli anziani.
Naturalmente abbiamo evidenziato solo una piccola parte delle difficoltà che incontrano i genitori e degli errori che commettono nella loro pratica educativa. Ci auguriamo tuttavia che la conoscenza anche di questi aspetti tipici dell'educazione familiare li aiuti a evitare molti malintesi nel rapporto con i propri figli.
La psicologia dell'educazione familiare ha avanzato l'idea di una posizione genitoriale ottimale. La posizione dei genitori nell'allevare i figli è ottimale se:
- accettano il bambino, lo trattano calorosamente, lo valutano obiettivamente e costruiscono l'educazione sulla base di questa valutazione;
- sono in grado di modificare metodi e forme di influenza in base alle mutevoli circostanze della vita del bambino;
- i loro sforzi educativi sono rivolti al futuro e sono correlati alle esigenze che la vita futura del bambino pone.
La posizione genitoriale ottimale è finalizzata al beneficio del bambino. Presuppone un atteggiamento critico dei genitori verso i propri errori e un'espressione ragionevole del loro amore per i figli. I genitori devono ricordare che sia l'eccessiva severità dell'educazione che la completa permissività e impunità sono dannose per il bambino. Il bambino non dovrebbe sentire le differenze nelle posizioni pedagogiche dei genitori, altrimenti sarà semplicemente disorientato (cosa è possibile e cosa no) o inizierà ad abusare del loro disaccordo. Inoltre, i genitori dovrebbero ricordare che è molto più difficile correggere i propri errori pedagogici che rilevarli o prevenirli, perché gli errori pedagogici nell'educazione familiare molto spesso hanno una natura cronica e prolungata.
I rapporti umani, compresi quelli familiari, così come i sentimenti che li colorano, richiedono un'attenzione costante e un notevole “lavoro dell'anima” per il loro tempestivo ripristino, altrimenti una volta che si insinuano ostilità, ostilità e conflitto, corrodono il calore dei rapporti familiari. e diventano irreversibili e creano un'atmosfera in casa insopportabile per il bambino. I principali indicatori di ciò sono vari tipi di deviazioni nel comportamento del bambino.
Ogni genitore vuole essere il meglio per i propri figli. Ma cosa significa essere il migliore e ottenere rispetto da chi ti circonda? O ancora crearne uno intelligente, bambino indipendente? Naturalmente la seconda cosa è importante. Non importa cosa dice la gente di te, ciò che conta è ciò che accade nella tua famiglia. E le persone intorno a te non possono sempre dare consiglio utile. Come fai a sapere quali pensieri li motivano?
Non esiste un codice speciale per crescere un figlio ideale, ma ci sono errori tipici nell'educazione familiare. Familiarizzando con loro, puoi evitare molte difficoltà in famiglia.
Usare la violenza contro un bambino
Per qualche ragione, i genitori credono che l'uso della violenza fisica li aiuterà ad avere un forte impatto sul bambino. In una certa misura, gli stai mostrando la tua autorità. Ma il bambino spesso inizia semplicemente ad avere paura di te. Non dimenticare che tuo figlio prima o poi crescerà e come sarà in futuro dipende da te. Nelle famiglie in cui viene usata frequentemente violenza contro un bambino, c'è sempre un ambiente teso e negativo. Spesso i bambini che hanno subito abusi fisici crescono persone aggressive e ritengono normale mostrare la propria forza senza motivo. Tale educazione può traumatizzare notevolmente la psiche del bambino, proteggere la tua famiglia da un errore educativo così tipico.
Freddezza verso il bambino
Molti genitori credono che un'eccessiva espressione di emozioni nei confronti di un bambino contribuisca allo sviluppo dell'egoismo e del comportamento viziato. Questo non è del tutto vero. Non è necessario correre da un estremo all’altro. Naturalmente, se sei eccessivamente emotivo nei confronti di tuo figlio, capirà che sei facile da manipolare, lo ami così tanto e semplicemente non puoi rifiutare nulla. Ma è impossibile negare al bambino il calore e l'amore dei genitori nei momenti in cui ne ha davvero bisogno. Anche i bambini hanno i loro problemi. Età di transizione, rapporti con i compagni di classe, una nuova squadra: questo può causare problemi psicologici Il bambino ha. Spesso i genitori semplicemente non riescono a dedicare tempo adeguato ai propri figli, citando il lavoro, la stanchezza e la mancanza di tempo. Quindi il bambino è costretto ad affrontare da solo i suoi problemi e la tua autorità ai suoi occhi diminuisce notevolmente. I bambini sono creature vulnerabili, quindi potrebbero considerarsi inutili per chiunque e ritirarsi.
Abbondanza di amore dei genitori
La maggior parte dei bambini in ritardo sono molto viziati e capricciosi. Questo perché le madri non possono rifiutare il proprio figlio e soddisfare quasi tutti i suoi capricci. Questo tipico errore familiare può portare a crescere un figlio egoista. Non dovresti viziare troppo tuo figlio; devi potergli dire di no a volte. Credimi, questo non lo farà amare di meno.
Troppi divieti
Non sorprende che un bambino desideri costantemente qualcosa. E non c’è bisogno di dire che questo è tipico solo dei bambini; anche gli adulti hanno tanti desideri; semplicemente non sempre li esprimiamo. E i bambini, come sai, dicono tutto ciò che hanno in mente. Anche in tenera età, il bambino inizia a esprimere i suoi desideri. Ad esempio, i genitori vietano ai propri figli di mangiare caramelle. Assicurati che mentre non sei nei paraggi, il bambino rubi delle caramelle. Questo perché i genitori sanno solo vietare ai propri figli, senza indicarne il motivo. E alla semplice domanda del bambino: “Perché no?” I genitori non possono trovare una risposta migliore di: “Perché l’ho detto io!” Questo modello di educazione familiare è un errore tipico. Devi essere in grado di giustificare le tue parole e alzare la voce non è affatto necessario. Certo, i bambini adorano chiedere tutto molte volte, ma sii paziente e cerca di giustificare con calma il tuo divieto. Il bambino deve essere in grado di comprendere correttamente la parola “no”. Altrimenti, potrebbe diventare una persona indecisa e riservata.
Assenza di divieti e permissività dei bambini
Come accennato in precedenza, non correre da un estremo all'altro. Fare di tuo figlio un idolo è un errore tipico nell'educazione familiare. Spesso possiamo osservare questo modello di educazione. Così vengono allevati i bambini da persone che dicono: “Non nego nulla a mio figlio”. A questi bambini è concesso tutto: sono abituati alla libertà fin dall'infanzia e sono abituati a raggiungere i propri obiettivi con l'aiuto dei capricci. Senza negare nulla a tuo figlio, puoi commettere un grave errore. È necessario insegnare ai bambini ad essere indipendenti fin dalla tenera età, altrimenti, quando cresceranno, semplicemente non saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi da soli. Questi bambini spesso manipolano i loro genitori e, a loro volta, semplicemente non capiscono come possono rifiutare il loro bambino. Il bambino deve comprendere la parola “no”, come discusso sopra. Inoltre, i bambini viziati causano molti problemi a chi li circonda. Ad esempio, per questi ragazzi insegnante di scuola non è un'autorità e non può influenzare in alcun modo un bambino del genere. Tipo, chi è lui/lei? A casa mi comporto come voglio, e anche qui mi comporterò come voglio. Non lasciare che tuo figlio ti manipoli, altrimenti non noterai come si siede sul tuo collo con le gambe penzolanti.
…Ogni famiglia inventa il suo
"biciclette" educative
ripetendo gli stessi errori che
altri genitori lo hanno fatto prima di lei.
M. Pankratova
Una famiglia è molto spesso un mondo di relazioni complesse, tradizioni e regole nascoste all'osservazione esterna, che in un modo o nell'altro influenzano le caratteristiche della personalità dei suoi membri e, prima di tutto, dei bambini. Tuttavia, ci sono una serie di fattori sociali oggettivi che, in un modo o nell'altro, influenzano tutte le famiglie senza eccezioni. Tra questi ci sono:
rottura dei legami di vicinato e, in alcuni casi, familiari;
il crescente coinvolgimento delle donne nelle attività produttive e il suo doppio fardello – nel lavoro e in famiglia;
mancanza di tempo per l'educazione e la comunicazione intrafamiliare;
difficoltà abitative e finanziarie: tutto ciò, in un modo o nell'altro, causa difficoltà nell'attuazione delle sue funzioni educative da parte della famiglia.
Tuttavia, nonostante l'importanza dei fattori elencati, essi non svolgono un ruolo decisivo nel verificarsi di deviazioni nello sviluppo della personalità del bambino, nell'alienazione di genitori e figli. Il pericolo maggiore in questo senso sono quegli errori che i genitori commettono, volontariamente o inconsapevolmente, nella costruzione dei rapporti con i propri figli, dimenticando che tali rapporti sono sempre di natura educativa.
Quando si analizzano gli atteggiamenti dei genitori nei confronti dei bambini, gli psicologi evidenzianodue dimensioni psicologiche : forma di controllo sul comportamento del bambino e sulla natura dell'atteggiamento emotivo nei suoi confronti .
La violazione dell'atteggiamento dei genitori nei confronti del bambino o degli atteggiamenti dei genitori nell'ambito di una di queste dimensioni o contemporaneamente in entrambe porta a gravi difetti nello sviluppo della personalità del bambino. Quindi, ad esempio, la mancanza di un adeguato controllo sul comportamento del bambino in combinazione con un'eccessiva concentrazione emotiva su di lui, un'atmosfera di coccole, carezze, conformità senza principi, continua enfasi sui vantaggi esistenti e inesistenti forma tratti caratteriali isterici. Le stesse conseguenze si hanno con un atteggiamento indifferente di tipo “rifiuto”.
Il controllo eccessivo, l'imposizione di requisiti morali troppo rigidi, l'intimidazione, la soppressione dell'indipendenza, l'abuso della punizione, anche fisica, portano, da un lato, allo sviluppo della crudeltà nel bambino e, dall'altro, possono spingerlo a tentare il suicidio .
La mancanza di contatto emotivo, un atteggiamento affettuoso nei confronti del bambino, combinato con la mancanza di controllo adeguato e l'ignoranza degli interessi e dei problemi dei bambini, porta a casi di fuga di casa, vagabondaggio, durante i quali vengono spesso commessi reati.
Esistono diversi meccanismi psicologici relativamente autonomi attraverso i quali i genitori influenzano i propri figli. in primo luogo, rinforzo: Incoraggiando il comportamento che gli adulti considerano corretto e punendo per la violazione delle regole stabilite, i genitori introducono nella mente del bambino un certo sistema di norme, la cui osservanza diventa gradualmente un'abitudine e un bisogno interno del bambino. In secondo luogo, identificazione: il bambino imita i suoi genitori, segue il loro esempio e cerca di diventare proprio come loro. Terzo, comprensione: Conoscendo il mondo interiore del bambino e rispondendo con sensibilità ai suoi problemi, i genitori modellano così la sua autoconsapevolezza e le sue qualità comunicative.
Le migliori relazioni tra genitori e figli si sviluppano quando i genitori aderiscono a uno stile genitoriale democratico. Questo stile contribuisce maggiormente allo sviluppo dell'indipendenza, dell'attività, dell'iniziativa e della responsabilità sociale. In questo caso, il comportamento del bambino è diretto in modo coerente e allo stesso tempo flessibile e razionale:
il genitore spiega sempre le ragioni delle sue richieste e ne incoraggia il confronto con il bambino (questo è importante soprattutto in età adolescenziale e scolare);
il potere viene utilizzato solo se necessario;
sia l'obbedienza che l'indipendenza sono apprezzate in un bambino;
il genitore stabilisce le regole e le fa rispettare con fermezza, ma non si considera infallibile;
ascolta le opinioni del bambino, ma non procede solo dai suoi desideri.
I tipi estremi di relazioni, non importa se vanno verso l’autoritarismo o la tolleranza liberale, danno cattivi risultati. Lo stile autoritario fa sì che i bambini si alienino dai genitori e si sentano poco importanti e indesiderati nella famiglia. Le richieste dei genitori, se sembrano irragionevoli, causano protesta e aggressività, oppure apatia e passività abituali. Un'inflessione verso la tolleranza totale fa sì che il bambino abbia la sensazione che i suoi genitori non si preoccupino di lui. Inoltre, i genitori passivi e disinteressati non possono essere imitati e identificati, e altre influenze – scuola, pari, mass media – spesso non riescono a colmare questa lacuna, lasciando il bambino senza una guida e un orientamento adeguati in un mondo complesso e in cambiamento. L'indebolimento del principio genitoriale, così come la sua ipertrofia, contribuiscono alla formazione di una personalità con un sé debole
Le ricerche condotte dagli psicologi sui problemi familiari indicano che gli atteggiamenti distorti dei genitori nella stragrande maggioranza dei casi non sono la causa finale delle anomalie nell'educazione familiare e delle violazioni dei rapporti genitore-figlio. Gli atteggiamenti dei genitori molto spesso risultano essere associati ai rapporti coniugali, al rapporto dei genitori dei coniugi - i nonni - con le caratteristiche personali dei familiari adulti e dei figli.
Come già notato nelle sezioni precedenti del lavoro, i bambini possono diventare un'arena di rivalità tra adulti, un mezzo di influenza o pressione, un metodo di punizione o vendetta. Le emozioni negative provate nei confronti degli altri membri della famiglia - nei confronti del coniuge e dei suoi genitori - possono essere trasferite ai figli. Inoltre, i genitori possono essere emotivamente o moralmente impreparati alla genitorialità. Potrebbero mancare la motivazione dei genitori, il senso di responsabilità nella crescita di un figlio potrebbe non essere sviluppato o, al contrario, esagerato; possono mancare di rispetto per se stessi e, di conseguenza, non sentirsi autorizzati a controllare il bambino e a guidare il suo sviluppo.
I problemi che sorgono nel processo di educazione familiare possono essere dovuti a una serie di altri motivi. Ciò però non esclude, ma solo conferma quanto diverse e complesse siano le questioni legate alla formazione della personalità del bambino in famiglia, e quanto sia importante immaginare le difficoltà che ogni genitore può incontrare per evitare, se possibile, gli errori che lo attendono in questa importante questione.
A questo proposito ha senso soffermarsi separatamente sulle caratteristiche degli stili genitoriali tipici che si riscontrano più spesso nelle famiglie disfunzionali.
Il modo più sicuro per migliorare l'educazione dei figli in famiglia è prevenire gli errori pedagogici dei genitori. E questo, a sua volta, presuppone la consapevolezza e la corretta interpretazione dei più tipici di essi. Gli errori comuni nell'educazione familiare possono essere condizionatamente dividi pertre gruppi :
Ogni genitore vuole essere un buon genitore. Ma cosa significa essere buoni? Senti l'approvazione di parenti, amici e conoscenti? Oppure fai crescere il tuo personalità morale? Sicuramente il secondo.
La moderna educazione familiare è caratterizzata da una serie di malintesi che impediscono di essere veramente buoni genitori. Probabilmente questi malintesi ci sono sempre stati. Ogni genitore alleva i figli secondo la propria comprensione, nella migliore delle ipotesi, ricorrendo ai metodi di insegnanti famosi, nel peggiore dei casi, al consiglio degli altri. Nessuna di queste garanzie garantisce che i tuoi figli non saranno colpiti dalle comuni trappole genitoriali. Senza dubbio è necessario avere almeno un’idea degli equivoci educativi più comuni: chi è avvisato è salvato.
Errore 1. Violenza fisica

La punizione fisica è un modo efficace per influenzare. Questo modello educativo viene scelto più spesso nelle famiglie con una struttura autoritaria. Ma nella loro rabbia, i genitori dimenticano: la violenza spesso porta a traumi psicologici, che contribuiscono a questo comportamento aggressivo bambino in futuro.
Errore 2. Freddezza eccessiva

Alcuni genitori credono che, mostrando amore ed emozione nella relazione con il proprio figlio, rischino di crescere un essere egoista e prepotente. Questo non è del tutto vero, è importante solo sapere quando fermarsi. Negare aiuto e sostegno al bambino nei momenti in cui ne ha più bisogno è un atteggiamento sbagliato.
L'indifferenza verso il bambino si osserva spesso nelle famiglie in cui i genitori sono impegnati a risolvere i propri problemi personali. Il bambino è lasciato a se stesso ed è costretto a prendersi cura di se stesso. I genitori semplicemente non hanno abbastanza tempo per prendersi cura dei propri figli e questo influisce naturalmente sulla loro autorità.
Errore 3. Troppo amore

Gli educatori hanno notato da tempo che un bambino nato tardi da sua madre molto spesso cresce egoista e viziato. I genitori di mezza età risparmiano il bambino, non vietando assolutamente nulla, tutti i suoi capricci vengono soddisfatti immediatamente e lui si crogiola letteralmente nell'attenzione e nella cura. Fate attenzione a non fare di un bambino un dio, altrimenti diventerete solo suoi servi.
Errore 4. Troppi divieti

Non sorprende affatto che il bambino voglia soddisfare i suoi bisogni, perché questo è caratteristico di quasi tutti gli esseri viventi del pianeta. Avendo appena iniziato a prendere coscienza di se stesso, il bambino si sforza di soddisfare i suoi desideri: all'inizio sono “innocui”, ma poi lo diventano sempre di più.
Anche in età prescolare è importante sviluppare la reazione corretta alla parola “no”. Se lo usi troppo spesso, può causare due conseguenze: o l'attenzione del bambino sulla parola "impossibile" si atrofizzerà e semplicemente smetterà di rispondere, oppure il bambino avrà paura di fare qualcosa che è "impossibile", e crescerà oppresso e indeciso. Fin dall'inizio è necessario determinare i divieti più obbligatori, se violati, il bambino si farà del male. Non dovrebbero essercene molti, tre o quattro al massimo. Ed è meglio lasciare che il bambino soddisfi la sua curiosità sotto la supervisione degli adulti piuttosto che farlo comunque quando non ci sei, perché il frutto proibito è dolce.
Errore 5. Mancanza di divieti

Un bambino-idolo è un altro estremo nella genitorialità. Abbiamo già parlato di permissività quando abbiamo menzionato l'amore ipertrofico per un bambino, ma qui la situazione è diversa. I genitori rifiutano in linea di principio qualsiasi divieto, scegliendo consapevolmente un simile modello di educazione, e dicono anche con orgoglio agli altri: "Non mi proibisco nulla".
Al bambino è concesso tutto e usa attivamente la sua libertà, causando disagi e problemi agli altri. Ricordate che sono i genitori i responsabili dell’inclusione del bambino nella società, e solo con il vostro aiuto potrà imparare cosa è permesso e cosa non è permesso, come comportarsi a casa e come comportarsi per strada.
Spesso c'è una situazione più agevole quando i genitori cercano di proibire qualcosa ai loro figli, ma lo fanno con molta delicatezza, con l'aiuto della persuasione, quando hanno bisogno di mostrare fermezza e determinazione. Ad esempio, un bambino in un negozio implora sua madre di dargli un altro giocattolo e lei gli spiega che ha già dei giocattoli, che non ha soldi, in generale trova ogni sorta di scuse, alla fine ottiene stanco della pressione morale e compra ciò che il bambino chiede. Questo comportamento è fondamentalmente sbagliato: il bambino implorerà ogni volta ciò che vuole, sapendo che raggiungerà il suo obiettivo. Puoi spiegare qualcosa al bambino all'infinito ed esortarlo, oppure puoi fermare immediatamente il "lamento" con un "no" categorico.
Errore 6. Genitorialità incoerente

Succede che i genitori non riescono a sopportare lo stress psicologico. Il comportamento categorico è sostituito dall'acquiescenza, la punizione dall'affetto. Non ci si può aspettare alcun effetto educativo da tali azioni. Un bambino ha bisogno di un'educazione coerente e premurosa.
Come puoi vedere, gli errori tipici nell'educazione familiare sono estremi che dovrebbero essere evitati. Il rimedio più sicuro è trovare una via di mezzo: un posto dove sostenere e rimpiangere, un posto dove mostrare perseveranza, proibire qualcosa e permettere qualcosa. Sì, ciò richiederà una resistenza ferrea e molta pazienza, ma nessuno ha promesso che crescere un figlio sarà facile: è un lavoro duro che richiede un enorme dispendio morale e fisico da parte dei genitori.
* Questo lavoro non è un lavoro scientifico, non è un lavoro di qualificazione finale ed è il risultato dell'elaborazione, strutturazione e formattazione delle informazioni raccolte destinate ad essere utilizzate come fonte di materiale per la preparazione indipendente di lavori didattici.
Introduzione................................................. ...................................................... ............. ...................3
Capitolo 1. Errori tipici dell’educazione familiare................................. .......... ......5
1.1. Peculiarità dell’educazione familiare............................................ ....................................5
1.2. Errori dell’educazione familiare............................................ ....................................................9
Capitolo 2. Stili genitoriali familiari............................................ ......................................12
Conclusione................................................. .................................................... ......................17
Bibliografia............................................... .................................................... ..... ...20
introduzione
Tradizionalmente, la principale istituzione educativa è la famiglia. Ciò che un bambino acquisisce dalla famiglia durante l'infanzia, lo conserva per tutta la vita successiva. L'importanza della famiglia come istituzione educativa è dovuta al fatto che il bambino vi rimane per una parte significativa della sua vita e, in termini di durata del suo impatto sull'individuo, nessuna istituzione educativa può essere paragonata alla famiglia. Getta le basi della personalità del bambino e quando entra a scuola è già formato per più della metà come persona.
La famiglia può agire sia come fattore positivo che come fattore negativo nell’educazione. E allo stesso tempo, nessun’altra istituzione sociale può potenzialmente causare tanti danni nella crescita dei figli quanto una famiglia. La famiglia è un tipo speciale di collettivo che svolge il ruolo principale, a lungo termine e ruolo vitale. Le madri ansiose hanno spesso figli ansiosi; i genitori ambiziosi spesso reprimono così tanto i loro figli da portare alla comparsa di un complesso di inferiorità; un padre sfrenato che perde la pazienza alla minima provocazione spesso, senza saperlo, forma un comportamento simile nei suoi figli, ecc.
In connessione con lo speciale ruolo educativo della famiglia, si pone la questione di come farlo in modo da massimizzare il positivo e minimizzarlo influenze negative famiglie a crescere un figlio. Per fare ciò, è necessario determinare con precisione i fattori socio-psicologici intrafamiliari che hanno un significato educativo.
È nella famiglia che il bambino riceve il suo primo esperienza di vita, fa le prime osservazioni e impara come comportarsi nelle varie situazioni. È molto importante che ciò che i genitori insegnano al bambino sia supportato da esempi concreti, in modo che possa vedere che la teoria degli adulti non si discosta dalla pratica. La cosa principale nell'istruzione piccolo uomo- raggiungimento dell'unità spirituale, connessione morale tra genitori e figlio. I genitori non dovrebbero mai lasciare che il processo educativo faccia il suo corso.
Situazione di conflitto tra genitori: diversi approcci alla crescita dei figli. Il primo compito dei genitori è trovare una soluzione comune e convincersi a vicenda. Se devi scendere a compromessi, assicurati di soddisfare i requisiti di base delle parti. Quando un genitore prende una decisione, deve ricordare la posizione dell'altro. Il secondo compito è assicurarsi che il bambino non veda contraddizioni nelle posizioni dei genitori, ad es. È meglio discutere di questi problemi senza di lui. Crescere un figlio prevede numerose forme di interazione e nasce in vita insieme in famiglia. Quando prendono una decisione, i genitori dovrebbero mettere al primo posto non le proprie opinioni, ma ciò che sarà più utile per il bambino.
Capitolo 1. Errori tipici dell'educazione familiare
1.1. Caratteristiche dell'educazione familiare
Nel lavoro genitoriale, come in ogni altro lavoro, sono possibili errori, dubbi, battute d'arresto temporanee, sconfitte sostituite da vittorie. Crescere in una famiglia è la stessa vita, e il nostro comportamento e persino i nostri sentimenti nei confronti dei bambini sono complessi, mutevoli e contraddittori. Inoltre, i genitori non sono simili tra loro, così come non sono simili tra loro i bambini. Le relazioni con un bambino, così come con ogni persona, sono profondamente individuali e uniche.
Ad esempio, se i genitori sono perfetti in tutto, conoscono la risposta corretta a qualsiasi domanda, in questo caso è improbabile che siano in grado di svolgere il compito genitoriale più importante: instillare nel bambino la necessità di una ricerca indipendente, di apprendere nuove cose cose.
Quando allevano i figli, i genitori devono tenere conto delle loro caratteristiche di genere. Dopotutto, ragazzi e ragazze differiscono non solo nell'aspetto:
uomini o natura femminile si manifesta molto prima della pubertà e lascia la sua impronta definitiva sui sentimenti, sulla coscienza e sul comportamento. Allo stesso tempo, non dovremmo dimenticare che i rappresentanti dei sessi maschile e femminile sono ancora, prima di tutto, uniti dalle qualità umane universali che sono caratteristiche di entrambi;
le caratteristiche sessuali sono generalmente evidenziate solo con una certa enfasi all'interno delle caratteristiche di una persona in generale. Sapere questo e tenere presente le caratteristiche psicologiche di una persona, determinate dal suo genere, significa avere l'opportunità di fare affidamento su tutto ciò che è positivo, di tenere conto delle possibili manifestazioni negative e, quindi, realizzare in modo più efficace l’educazione familiare.
Alcune differenze significative tra ragazzi e ragazze sono già evidenti nei primi mesi di vita. Ad esempio, le ragazze si sviluppano un po' più velocemente dei ragazzi sia fisicamente che psicologicamente; iniziano a parlare circa 2-4 mesi prima. In media, all'età di tre anni, sia i ragazzi che le ragazze, con l'aiuto dei genitori e di altri, conoscono già il proprio genere e distinguono il genere di altri bambini e adulti.
Man mano che il bambino cresce, le caratteristiche psicologiche di genere si intensificano gradualmente. Si manifestano a livello di reazioni emotive, in interessi e inclinazioni specifici, nella natura del pensiero, in relazione a fatti specifici, ecc.
Le ragazze già in tenera età manifestano “l'istinto della maternità”, che si esprime nell'interesse per gli altri bambini, per i giochi e in un atteggiamento premuroso nei confronti delle bambole. La loro attenzione è attratta principalmente dalla persona, dai suoi rapporti con le altre persone. Più invecchiano, più forte aumenta il loro interesse per il mondo interiore di una persona, le sue esperienze e il suo comportamento. È tipico anche che le ragazze mostrino un interesse predominante per ciò che le circonda direttamente (mobili, utensili, vestiti, ecc.).
Le ragazze comunicano di più con la madre e sono più attaccate a casa. Sono, di regola, più diligenti ed efficienti dei ragazzi, più attenti, parsimoniosi e coscienziosi. Tendono ad essere più inclini a mostrare interesse per gli altri, a prendersi cura di loro, nonché a insegnare e criticare. La maggiore emotività delle rappresentanti femminili è spesso la ragione della loro mancanza di obiettività. La sensibilità della psiche femminile è superiore a quella del maschio, le ragazze sono più permalose, orgogliose, reagiscono più bruscamente sia all'incoraggiamento che al rimprovero.
Le ragazze hanno un'attenzione involontaria più sviluppata e sono più attratte dalla visualizzazione concreta. Sono più facilmente suggestionabili; adattarsi più velocemente al nuovo ambiente e sentirsi più sicuri in condizioni insolite.
L'educazione familiare dei ragazzi, avendo molto in comune con l'educazione delle ragazze, ha tuttavia le sue caratteristiche specifiche, che sono direttamente determinate dalle caratteristiche fisiche e caratteristiche psicologiche rappresentanti maschili. È vero, in pratica, per vari motivi e circostanze, queste caratteristiche spesso non vengono prese in considerazione sia in famiglia che a scuola. Ma tale pratica, ovviamente, non serve all’interesse di aumentare l’efficacia degli sforzi degli educatori per modellare la personalità dei futuri uomini. Pertanto, per i genitori che sono veramente e seriamente interessati alla corretta educazione dei propri figli, è consigliabile conoscere e tenere conto delle loro caratteristiche di genere.
I maschi hanno una forza fisica maggiore rispetto alle donne, ma sono inferiori a loro in termini di resistenza. I ragazzi sono più attivi, rilassati, meno pazienti e disciplinati, sono meno diligenti e diligenti.
I ragazzi sono solitamente interessati a un'ampia varietà di domande e problemi, a volte ben oltre la portata della realtà circostante (paesi lontani, fenomeni misteriosi, incidenti insoliti, ecc.). Preferiscono le scienze esatte, amano la tecnologia, l'educazione fisica e lo sport, amano i giochi all'aperto, molti si impegnano volentieri nel lavoro fisico e sono più propensi ad attività trasformative. Allo stesso tempo, sono spesso meno disposti a prendersi cura di sé, spesso mostrano impotenza nelle semplici questioni quotidiane e hanno maggiori probabilità di subire infortuni di ogni tipo.
A causa delle caratteristiche di genere dei ragazzi, allevarli è un po’ più difficile. Il loro rendimento scolastico è inferiore a quello delle ragazze, sono meno autocritiche; in età di scuola media, a causa di omissioni nell'educazione, compaiono spesso tra loro adolescenti “difficili”, caratterizzati da cattive abitudini(fumare, bere alcolici, abuso di sostanze, linguaggio volgare, ecc.), nonché reati (hooliganismo, furto). Sotto l'influenza del cattivo esempio degli adulti, alcuni ragazzi sviluppano un falso senso di superiorità rispetto alle ragazze, che influisce negativamente sulle loro relazioni, così come in seguito sulla vita coniugale.
I genitori costituiscono il primo ambiente sociale del bambino. Le personalità dei genitori svolgono un ruolo vitale nella vita di ogni persona. Non è un caso che ci rivolgiamo mentalmente ai nostri genitori, soprattutto a nostra madre. momento difficile vita. Allo stesso tempo, i sentimenti che colorano la relazione tra bambino e genitori sono sentimenti speciali, diversi da altre connessioni emotive. La specificità dei sentimenti che nascono tra figli e genitori è determinata principalmente dal fatto che la cura dei genitori è necessaria per sostenere la vita stessa del bambino. E il bisogno dell'amore dei genitori è davvero un bisogno vitale di un piccolo essere umano. L'amore di ogni bambino per i suoi genitori è sconfinato, incondizionato, illimitato. Inoltre, se nei primi anni di vita l'amore per i genitori garantisce la propria vita e sicurezza, man mano che si invecchia, l'amore dei genitori svolge sempre più la funzione di mantenimento e sicurezza del mondo interiore, emotivo e psicologico di una persona. L'amore dei genitori è la fonte e la garanzia del benessere umano, del mantenimento della salute fisica e mentale.
Ecco perché il primo e principale compito dei genitori è creare nel bambino la fiducia di essere amato e curato. Mai, in nessuna circostanza, un bambino dovrebbe avere dubbi sull'amore dei genitori. Il più naturale e necessario di tutti i doveri dei genitori è trattare il bambino a qualsiasi età con amore e attenzione.
1.2. Errori dell'educazione familiare
Violenza fisica.
La punizione fisica è un metodo efficace di influenza. Questo modello educativo viene scelto più spesso nelle famiglie con una struttura autoritaria. Ma con rabbia, i genitori dimenticano: la violenza spesso porta a traumi psicologici, che contribuiscono al comportamento aggressivo del bambino in futuro.
Freddezza eccessiva.
Alcuni genitori credono che, mostrando amore ed emozione nella relazione con il proprio figlio, rischino di crescere un essere egoista e prepotente. Questo non è del tutto vero, è importante solo sapere quando fermarsi. Negare aiuto e sostegno al bambino nei momenti in cui ne ha più bisogno è un atteggiamento sbagliato.
L'indifferenza verso il bambino si osserva spesso nelle famiglie in cui i genitori sono impegnati a risolvere i propri problemi personali. Il bambino è lasciato a se stesso ed è costretto a prendersi cura di se stesso. I genitori semplicemente non hanno abbastanza tempo per prendersi cura dei propri figli e questo influisce naturalmente sulla loro autorità.
Abbondanza d'amore.
Gli educatori hanno notato da tempo che un bambino nato tardi da sua madre molto spesso cresce egoista e viziato. I genitori di mezza età risparmiano il bambino, non vietando assolutamente nulla, tutti i suoi capricci vengono soddisfatti immediatamente e lui si crogiola letteralmente nell'attenzione e nella cura. Fate attenzione a non fare di un bambino un dio, altrimenti diventerete solo suoi servi.
Tanti divieti.
Non sorprende affatto che il bambino voglia soddisfare i suoi bisogni, perché questo è caratteristico di quasi tutti gli esseri viventi del pianeta. Avendo appena iniziato a prendere coscienza di se stesso, il bambino si sforza di soddisfare i suoi desideri: all'inizio sono “innocui”, ma poi lo diventano sempre di più.
Anche in età prescolare è importante sviluppare la reazione corretta alla parola “no”. Se lo usi troppo spesso, può causare due conseguenze: o l'attenzione del bambino sulla parola "impossibile" si atrofizzerà e semplicemente smetterà di rispondere, oppure il bambino avrà paura di fare qualcosa che è "impossibile", e crescerà oppresso e indeciso. Fin dall'inizio è necessario determinare i divieti più obbligatori, se violati, il bambino si farà del male. Non dovrebbero essercene molti, tre o quattro al massimo. Ed è meglio lasciare che il bambino soddisfi la sua curiosità sotto la supervisione degli adulti piuttosto che farlo comunque quando non ci sei, perché il frutto proibito è dolce.
Senza restrizioni.
Un bambino-idolo è un altro estremo nella genitorialità. Abbiamo già parlato di permissività quando abbiamo menzionato l'amore ipertrofico per un bambino, ma qui la situazione è diversa. I genitori rifiutano in linea di principio qualsiasi divieto, scegliendo consapevolmente un simile modello di educazione, e dicono anche con orgoglio agli altri: "Non mi proibisco nulla".
Al bambino è concesso tutto e usa attivamente la sua libertà, causando disagi e problemi agli altri. Ricordate che sono i genitori i responsabili dell’inclusione del bambino nella società, e solo con il vostro aiuto potrà imparare cosa è permesso e cosa non è permesso, come comportarsi a casa e come comportarsi per strada.
Spesso c'è una situazione più agevole quando i genitori cercano di proibire qualcosa ai loro figli, ma lo fanno con molta delicatezza, con l'aiuto della persuasione, quando hanno bisogno di mostrare fermezza e determinazione. Ad esempio, un bambino in un negozio implora sua madre di dargli un altro giocattolo e lei gli spiega che ha già dei giocattoli, che non ha soldi, in generale trova ogni sorta di scuse, alla fine ottiene stanco della pressione morale e compra ciò che il bambino chiede. Questo comportamento è fondamentalmente sbagliato: il bambino implorerà ogni volta ciò che vuole, sapendo che raggiungerà il suo obiettivo. Puoi spiegare qualcosa al bambino all'infinito ed esortarlo, oppure puoi fermare immediatamente il "lamento" con un "no" categorico.
Genitorialità incoerente.
Succede che i genitori non riescono a sopportare lo stress psicologico. Il comportamento categorico è sostituito dall'acquiescenza, la punizione dall'affetto. Non ci si può aspettare alcun effetto educativo da tali azioni. Un bambino ha bisogno di un'educazione coerente e premurosa.
Come puoi vedere, gli errori tipici nell'educazione familiare sono estremi che dovrebbero essere evitati. Il rimedio più sicuro è trovare una via di mezzo: un posto dove sostenere e rimpiangere, un posto dove mostrare perseveranza, proibire qualcosa e permettere qualcosa. Sì, ciò richiederà una resistenza ferrea e un mare di pazienza, ma nessuno ha promesso che crescere un figlio sarà facile: è un lavoro duro che richiede un enorme dispendio morale e fisico da parte dei genitori.
Capitolo 2. Stili genitoriali familiari
I problemi di crescere i figli in una famiglia sono un argomento eterno, ma ancora irrisolto. Questa domanda occupa le menti degli scienziati: insegnanti, psicologi, causando polemiche e disaccordi. Le battaglie quotidiane si trasformano in conferenze scientifiche. Rigore o morbidezza? Autoritarismo o connivenza? Non mancano i sostenitori di questo o quel tipo di educazione.
In pedagogia, è consuetudine distinguere quattro stili di educazione dei figli: dettatura, iperprotezione, non interferenza e cooperazione. Ognuno di essi ha i propri risultati e conseguenze per quanto riguarda la formazione della personalità del bambino.
Stile democratico – “Ti ascolto... mi importa di te... voglio capirti...”
Stile democratico: i genitori incoraggiano la responsabilità personale e l'indipendenza dei propri figli in base alle loro capacità di età.
La cooperazione è un modo per costruire relazioni in una famiglia, il cui principio principale è l'unificazione mediante scopi e obiettivi comuni, attività congiunte e sostegno reciproco in tutte le aree, comprese quelle emotive. Il punto di partenza dell’educazione in questo caso è la parola “noi”. Il bambino ha abbastanza indipendenza, ma c'è sempre un adulto nelle vicinanze, pronto ad aiutare in tempo, sostenere, spiegare, calmare. I membri di tali famiglie sono uniti da valori comuni, tradizioni familiari, vacanze spontanee, bisogno emotivo l'uno nell'altro, attività congiunta.
I genitori limitano l'indipendenza del bambino e non ritengono necessario giustificare in qualche modo le loro richieste, accompagnandole con uno stretto controllo, severi divieti, rimproveri e punizioni fisiche. Durante l’adolescenza, l’autoritarismo dei genitori genera conflitti e ostilità. Il più attivo adolescenti forti resistono e si ribellano, diventano eccessivamente aggressivi e spesso abbandonano la casa dei genitori non appena possono permetterselo. Gli adolescenti timidi e insicuri imparano ad obbedire ai genitori in tutto, senza fare alcun tentativo di decidere nulla da soli. Se le madri tendono ad adottare comportamenti più “permissivi” nei confronti degli adolescenti più grandi, i padri autoritari aderiscono fermamente al tipo di autorità genitoriale prescelta.
Con tale educazione, i bambini sviluppano solo un meccanismo di controllo esterno, basato sul senso di colpa o sulla paura della punizione, e non appena scompare la minaccia di punizione dall’esterno, il comportamento dell’adolescente può diventare potenzialmente antisociale. Le relazioni autoritarie escludono la vicinanza spirituale con i bambini, quindi raramente nasce un sentimento di affetto tra loro e i loro genitori, che porta al sospetto, alla vigilanza costante e persino all'ostilità verso gli altri.
Il genitore dittatoriale si sforza di dare al bambino “il meglio”. Lo nutre e lo veste bene e gli permette di giocare con gli altri bambini. In generale, fornisce tutto il necessario per una vita “normale”. Tutto tranne il sostegno e l'amore. Vivendo con genitori dittatori, i bambini scelgono una delle tattiche: scappare o combattere.
Quando i bambini scelgono di fuggire, di solito si chiudono in se stessi, anche se esteriormente mostrano compiacenza e obbedienza. Ma tutto ribolle nelle loro anime. Prima o poi il vapore uscirà. In un'altra situazione, il “fuggitivo” potrebbe crollare e fare un passo disperato, perché non è più in grado di sopportare la situazione attuale. Nella migliore delle ipotesi scapperà di casa, nel peggiore dei casi si suiciderà.
Se il bambino decide di “combattere”, la sua rabbia verrà fuori. Si lamenta, si offende, scatta, addirittura aggredisce il delinquente con insulti e minacce. Insomma, il bambino si ribella perché le regole con le quali è costretto a vivere non sono riscaldate dall'amore dei genitori.
Scoprire un tiranno in te stesso è spiacevole e quindi difficile: il nostro subconscio si rifiuta di valutare oggettivamente il nostro comportamento. Chiedi a tuo figlio che tipo di fiore vede se stesso? Lascialo disegnare. Se l'immagine mostra un cactus o una specie di drosera che divora tutto intorno, vale la pena pensarci. Questi sono segni di aggressività interna (aggressione difensiva) e semplicemente aggressività. Se il fiore è pallido, fragile, solitario e non è chiaro da cosa cresca, c'è anche qualcosa a cui pensare: hai “schiacciato” troppo il bambino?
Connivente: "fai come vuoi!"
I bambini che hanno sofferto di uno stile genitoriale autoritario molto spesso decidono che alleveranno la loro prole in un modo completamente diverso. Ciò è in parte corretto, ma in questo caso puoi andare all'estremo opposto: il tipo opposto di relazione: la permissività. "Non piaccio ai miei genitori", puoi sentire da un bambino che cresce in una famiglia del genere, "perché permettono tutto". Tali genitori dimenticano se stessi: i loro bisogni, interessi. E ogni desiderio del “piccolo imperatore” viene esaudito senza dubbio. Molto rapidamente il bambino impara a manipolare gli adulti, costringendoli a soddisfare qualsiasi desiderio.
Stile permissivo: il bambino non è adeguatamente guidato, praticamente non conosce i divieti e le restrizioni da parte dei genitori, o non segue le istruzioni dei genitori, che sono caratterizzati da incapacità, incapacità o riluttanza a guidare i bambini. Man mano che invecchiano, questi adolescenti entrano in conflitto con coloro che non li assecondano, non sono in grado di tenere conto degli interessi delle altre persone, stabiliscono forti legami emotivi e non sono pronti per restrizioni e responsabilità. D'altra parte, percependo la mancanza di guida da parte dei genitori come una manifestazione di indifferenza e rifiuto emotivo, i bambini provano paura e incertezza. L'incapacità della famiglia di controllare il comportamento di un adolescente può portare al suo coinvolgimento in gruppi antisociali, poiché non ha sviluppato i meccanismi psicologici necessari per un comportamento indipendente e responsabile nella società.
L'iperprotezione è un sistema di relazioni in una famiglia in cui i genitori, provvedendo con il proprio lavoro, alla soddisfazione di tutti i bisogni del bambino, lo proteggono da ogni preoccupazione, fatica e difficoltà, assumendoli su di sé. Il risultato in questo caso è facilmente prevedibile: si forma una personalità emotivamente immatura, capricciosa, egocentrica ed esigente, non adattata alla vita. D'altra parte, l'iperprotezione può contribuire allo sviluppo di tendenze ipocondriache. Sopraffatto da cure eccessive fin dall'infanzia, il bambino stesso inizia a sentirsi impotente in ogni situazione che gli richiede di agire o prendere una decisione. Succede anche il contrario: avvicinandosi all'adolescenza, un bambino sente il bisogno di liberarsi di cure eccessive, che alla fine porta alla ribellione, vivide manifestazioni di emancipazione e comportamenti di protesta.
Secondo la "diagnostica dei fiori", questi bambini spesso si disegnano sotto forma di fiori: re e regine.
Indifferente (indifferenza, indifferenza, indifferenza)
La non interferenza è un sistema di relazioni familiari, basato sul riconoscimento dell'opportunità dell'esistenza indipendente di adulti e bambini. Il bambino è lasciato a se stesso. I genitori che si affidano a questo stile educativo credono che esso promuova lo sviluppo dell’indipendenza, della responsabilità e l’accumulo di esperienza. Quando commette errori, il bambino è costretto ad analizzarli e correggerli da solo. Ma questo metodo comporta il rischio di sviluppare alienazione emotiva nel bambino, anche dai suoi genitori. Non curato durante l'infanzia, non ricevendo la quota necessaria di cure genitoriali, un bambino del genere si sente troppo solo, diffidente e spesso eccessivamente sospettoso. È difficile per lui affidare qualsiasi attività ad altre persone. Cerca di fare tutto da solo.
Lo stile caotico (leadership incoerente) è l'assenza di un approccio unificato all'educazione, quando non ci sono requisiti specifici chiaramente espressi, definiti e specifici per il bambino o ci sono contraddizioni e disaccordi nella scelta mezzi educativi tra genitori.
Con questo stile di educazione, uno degli importanti bisogni primari personalità: la necessità di stabilità e ordine nel mondo circostante, la presenza di linee guida chiare nel comportamento e nelle valutazioni.
L'imprevedibilità delle reazioni dei genitori priva il bambino di un senso di stabilità e provoca maggiore ansia, incertezza, impulsività e situazioni difficili anche aggressività e incontrollabilità, disadattamento sociale. Con tale educazione non si formano autocontrollo e senso di responsabilità, si notano immaturità di giudizio e bassa autostima.
La "collaborazione" è riconosciuta come la più importante tipo efficace educazione tutto grande quantità psicologi e insegnanti. Ma in pratica, le famiglie di solito affrontano stili diversi genitorialità, creando tensione e influenzando negativamente lo sviluppo del bambino.
La corretta genitorialità lo è tutta una scienza, dalla cui conoscenza dipende in gran parte il futuro dei nostri figli. Pertanto, se vuoi crescere un bambino felice, indipendente e sicuro di te, non abusare dei tuoi diritti genitoriali, ma non ignorare le tue responsabilità. Non dividere la tua famiglia in due stati separati che sono in guerra tra loro.
Conclusione
Ogni famiglia sviluppa oggettivamente un certo sistema educativo. Il sistema educativo si riferisce agli obiettivi dell'educazione, alla formulazione dei suoi compiti, all'applicazione più o meno mirata di metodi e tecniche educative, tenendo conto di ciò che può e non può essere consentito in relazione al bambino. Si possono distinguere quattro tattiche di educazione familiare e quattro tipi di relazioni familiari ad esse corrispondenti, che sono sia un prerequisito che il risultato del loro verificarsi: dettatura, tutela, “non interferenza” e cooperazione. Il diktat in famiglia si manifesta nella sistematica soppressione da parte di alcuni membri della famiglia dell'iniziativa e dell'autostima di altri membri della famiglia. La cura familiare è un sistema di relazioni in cui i genitori, pur assicurando con il loro lavoro che tutti i bisogni del bambino siano soddisfatti, lo tutelano da ogni preoccupazione, fatica e difficoltà, facendosene carico. Sistema relazioni interpersonali in una famiglia, basata sul riconoscimento della possibilità e persino dell’opportunità di un’esistenza indipendente degli adulti dai bambini, può essere generata dalla tattica della “non interferenza”. La cooperazione come tipo di relazione in una famiglia presuppone la mediazione delle relazioni interpersonali nella famiglia mediante scopi e obiettivi comuni di attività congiunta, sua organizzazione e alti valori morali. È in questa situazione che l’individualismo egoistico del bambino viene superato. Una famiglia, in cui il tipo principale di relazione è la cooperazione, acquisisce una qualità speciale e diventa un gruppo ad alto livello di sviluppo: una squadra.
I genitori costituiscono il primo ambiente sociale del bambino. Le personalità dei genitori svolgono un ruolo vitale nella vita di ogni persona. La specificità dei sentimenti che nascono tra figli e genitori è determinata principalmente dal fatto che la cura dei genitori è necessaria per sostenere la vita stessa del bambino. L'amore di ogni bambino per i suoi genitori è sconfinato, incondizionato, illimitato. Inoltre, se nei primi anni di vita l'amore per i genitori garantisce la propria vita e sicurezza, man mano che si invecchia, l'amore dei genitori svolge sempre più la funzione di mantenimento e sicurezza del mondo interiore, emotivo e psicologico di una persona. L'amore dei genitori è la fonte e la garanzia del benessere umano, del mantenimento della salute fisica e mentale.
Ecco perché il primo e principale compito dei genitori è creare nel bambino la fiducia di essere amato e curato. Il più naturale e necessario di tutti i doveri dei genitori è trattare il bambino a qualsiasi età con amore e attenzione. Eppure, l'enfasi sulla necessità di creare fiducia in un bambino nell'amore dei genitori è dettata da una serie di circostanze. Gli psicologi hanno dimostrato che dietro la tragedia dell'alcolismo adolescenziale e della tossicodipendenza adolescenziale ci sono spesso genitori che non amano i propri figli. Il requisito principale per l'educazione familiare è il requisito dell'amore. Solo con la fiducia del bambino nell'amore dei genitori è possibile la corretta formazione del mondo mentale di una persona, solo sulla base dell'amore si può educare il comportamento morale, solo l'amore può insegnare l'amore.
Molti genitori credono che in nessun caso i bambini dovrebbero mostrare amore per loro, credendo che quando un bambino sa bene di essere amato, ciò porta al deterioramento, all'egoismo, all'egoismo. Al contrario, questi tratti sfavorevoli della personalità sorgono proprio quando manca l'amore, quando si crea un certo deficit emotivo, quando il bambino viene privato di un solido fondamento di immutabile affetto genitoriale.
Il contatto psicologico profondo e costante con un bambino è un requisito universale per l'educazione, che può essere ugualmente raccomandato a tutti i genitori; il contatto è necessario nell'educazione di ogni bambino a qualsiasi età. È il sentimento e l'esperienza del contatto con i genitori che offre ai bambini l'opportunità di sentire e realizzare l'amore, l'affetto e la cura dei genitori. La base per mantenere i contatti è un sincero interesse per tutto ciò che accade nella vita del bambino.
Oltre al dialogo, per instillare in un bambino un sentimento di amore dei genitori, è necessario fare ancora una cosa: regola importante. Nel linguaggio psicologico, questo lato della comunicazione tra bambini e genitori si chiama accettazione del bambino. Accettazione significa riconoscimento del diritto del bambino alla sua intrinseca individualità, a essere diverso dagli altri, compreso essere diverso dai suoi genitori. Accettare un bambino significa affermare l'esistenza unica di questa particolare persona, con tutte le sue qualità intrinseche. I genitori devono essere consapevoli che ogni valutazione negativa della personalità del bambino e delle qualità caratteriali intrinseche del tipo: “È stupido! Quante volte da spiegare, stupido!", "Perché ti ho messo al mondo, testardo, mascalzone!", non importa quanto sia giusto in sostanza, non importa cosa causa la situazione, causa un grave danno a il contatto con il bambino, viola la fiducia nell'amore dei genitori. È necessario sviluppare una regola per te stesso per non valutare negativamente il bambino stesso, ma per criticare solo un'azione eseguita in modo errato o un atto errato e sconsiderato.
La distanza che è diventata predominante nei rapporti con un bambino in una famiglia dipende direttamente dal luogo delle attività educative nell'intero sistema complesso, ambiguo e talvolta internamente contraddittorio di vari motivi del comportamento di un adulto. Pertanto, vale la pena rendersi conto del posto che occuperà l’attività di allevare il nascituro nel sistema motivazionale del genitore.
Bibliografia
1. Akutina, S.P. - “Educazione – famiglia e scuola”, 2007
2. Dementieva, I. - “Educazione e famiglia”, 2008
3. Efimov, A. - "Alcune caratteristiche dell'educazione familiare", Megarif, 2007.
4. Zubova, G. - “Educazione familiare dei bambini piccoli”, 2004.
5. Ivantsova, A. - "Studiare le caratteristiche dell'educazione nelle famiglie" // Educazione degli scolari, 2000.
6. Ilyin, S. - “ Lezione di famiglia"(Rivista "Educazione degli scolari", n. 7 - 2002)
7. Isaakovich, E.I. - “Nelle tendenze dei cambiamenti nell'istituzione familiare nella società moderna” (Rivista “ Scuola elementare", n. 1 - 2007)
8. Kapterov, P.F. - “Istruzione primaria”//Istruzione familiare; Lettore/Comp. PAPÀ. Lebedev, M., 2001
9. Kovalev, S.V. - “Psicologia famiglia moderna", M., 1998
10. Kulik, Los Angeles - “Educazione familiare”, M., 1990
11. Lodkina, T.V. Pedagogia sociale. - M., 2003.
12. Lesgaft, P.F. - “L'educazione familiare del bambino e il suo significato”, M., Pedagogia, 1991.
13. Mardakhaev, L.V. Pedagogia sociale. - M., 2005.
14. Nikitin, V. A. Pedagogia sociale. - M., 2002.
15. Pozina, M.B. - “Psicologia e pedagogia: libro di testo” Scientifico. ed. SE. Nevolin. - Università M. Natalia Nesterova, 2001
16. Stepanov, S. - “Strategie per l'educazione familiare” (rivista “Psicologo scolastico”, n. 5 - 2000)
17. Suhar, E. - “Errori nell'educazione familiare” // Educazione degli scolari, 2005.
18. Radugina, A.A. - “Psicologia e Pedagogia”, M., 1997
19. Whiteley R. - “Il fenomeno dell'educazione familiare” M., 2002.